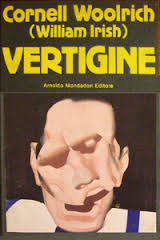Nel corso della progressiva disfatta (artistica e umana) collezionata dallo scrittore americano Cornell Woolrich, è possibile evidenziare la componente essenziale del noir.
Nel corso della progressiva disfatta (artistica e umana) collezionata dallo scrittore americano Cornell Woolrich, è possibile evidenziare la componente essenziale del noir.
Woolrich, tra i massimi autori della materia, ancor (prima) più che in Jim Thompson e David Goodis, centra il cuore perturbante del genere, fissandone alcuni aspetti.
Il noir di Woolrich, come capirà bene David Lynch, è borderline con l’horror più psicogeno.
Dai primi raccontini pulp o hard boiled, dove ancora inutili derive poliziesche d’azione incrostano la pagina, lo scrittore di New York accantona progressivamente la dimensione logica del giallo, a beneficio di un quadro da incubo urbano cinico e paradossale, quasi parabola filosofica sull’assurdità dell’esistenza in balia di un fato crudele e ironico.
In questo senso è emblematico uno dei capolavori di Woolrich, Sipario nero, del 1941 (data storica per l’avvio del noir su grande schermo), storia di un uomo, Frank Townsend, che ha smarrito tre anni della propria vita, tre anni durante i quali è stato un altro. Purtroppo, Frank non ricorda nulla di quegli anni e dovrà compiere un viaggio a ritroso nel tempo per strappare il pesante sipario del suo passato. La seconda parte del giallo si scioglierà ancora dentro la cornice di un mystery classico, con tanto di spiegazione razionale e colpevoli impacchettati, tuttavia, la prima bobina del libro è una descrizione in prima persona da dentro le pieghe di un sogno dai contorni impalpabili.
Molto noir a venire avrà debiti importanti con questo libro e col tema (da qui in avanti classico) dell’amnesia vista come frantumazione dell’anatomia narrativa e falso movimento in un plot per nulla martellante, preludio alle ombre della cecità finzionale.
 La sposa era in nero, del 1940 è il primo classico di Woolrich e innumerevoli pellicole ne sono state tratte. A me, piuttosto che Truffaut (noioso), piace citare She killed in ecstasy di zio Jess Franco, opera a metà tra Godard, il trash e il soft porno anni Settanta.
La sposa era in nero, del 1940 è il primo classico di Woolrich e innumerevoli pellicole ne sono state tratte. A me, piuttosto che Truffaut (noioso), piace citare She killed in ecstasy di zio Jess Franco, opera a metà tra Godard, il trash e il soft porno anni Settanta.
Ok, la sposa è scritto con stile asciutto e cinematografico, spezzato da descrizioni psicologiche ammorbanti, capaci di comunicarci la disperazione senza redenzione dei personaggi, in particolare della sposa, ammantata di amor fou surreale e mossa dal bisogno di cancellare la propria identità, fino a divenire la donna dai mille volti (ancora una volta l’identità è luogo di conflitti che muovono tutte le fila della vicenda; in Sipario Nero Townsend doveva ritrovare il suo passato, qui la sposa ricorda benissimo, tuttavia è mossa dal proposito di vendetta maturato verso coloro che le hanno ucciso il marito; decide così di travestirsi e cambiare continuamente aspetto per potersi avvicinare alle vittime e fuorviare la polizia). La bellezza del libro sta nella costruzione pulita delle scene, quadri quasi staccati tra loro, autosufficienti, che, nel finale, si ricompongono in uno scioglimento soluzione razionale. A impreziosire il tutto le parentesi di poesia surreale aperte dalla prosa dello scrittore newyorkese che, alternate alla suspence, ci fanno intuire (ed è questo alla fine il lato più moderno, contemporaneo di Woolrich, quello che lo pone vicinissimo a certo neo noir) un mondo di forze oscure che si agita appena dietro a quello che conosciamo; un mondo contro il quale è vano resistere e a cui nessun eroe (o criminale geniale) riuscirà a resistere; un mondo in cui, in ultimo, ogni cosa perde di senso e anche acciuffare per un soffio la verità (o la vendetta) si rivela illusorio e fallace.
 A questo proposito rimando anche alla lettura del racconto Il tredicesimo giorno, dalla chiara matrice d’incubo (nonostante il finale assolutorio e conciliante, appiccicato e pieno di incongruenze narrative, segno dello sprezzo di Woolrich nei confronti delle scienze narratologiche di oggi): un uomo, alla vigilia delle nozze, perde le tracce dell’amata e, man mano che si procede nella lettura, pare che nemmeno sia mai esistita. Il quadro delle certezze che muove il burattino/maritino si sgretola velocemente, rivelando il sipario nero che fa da sfondo a tutto l’universo di Woolrich.
A questo proposito rimando anche alla lettura del racconto Il tredicesimo giorno, dalla chiara matrice d’incubo (nonostante il finale assolutorio e conciliante, appiccicato e pieno di incongruenze narrative, segno dello sprezzo di Woolrich nei confronti delle scienze narratologiche di oggi): un uomo, alla vigilia delle nozze, perde le tracce dell’amata e, man mano che si procede nella lettura, pare che nemmeno sia mai esistita. Il quadro delle certezze che muove il burattino/maritino si sgretola velocemente, rivelando il sipario nero che fa da sfondo a tutto l’universo di Woolrich.
Woolrich ha scritto altri libri e racconti memorabili.
 Penso all’Alibi nero, da cui è tratto il bellissimo film L’uomo leopardo, oppure i racconti sugli sbirri borderline immersi nel jazz fumoso dei locali e nell’alcool della raccolta Giallo a tempo di swing, per noi licenziata dalla Feltrinelli.
Penso all’Alibi nero, da cui è tratto il bellissimo film L’uomo leopardo, oppure i racconti sugli sbirri borderline immersi nel jazz fumoso dei locali e nell’alcool della raccolta Giallo a tempo di swing, per noi licenziata dalla Feltrinelli.
Tuttavia è negli ultimi racconti che l’apocalisse nera, apocalisse discreta che corrode il mondo ordinario e borghese dei piccoli uomini e donne protagonisti dei racconti di Woolrich, si arricchisce di una vena sperimentale fortissima, ormai libera da qualunque legame formale col giallo classico, col bisogno di spiegazioni e restrizioni di genere.
Woolrich (ormai distrutto dall’alcool) si immerge in un magma puro di paranoia, follia, morte e amnesie totali, tenute assieme da una prosa scioltissima, fulminante e poetica, capace di mescolare brani di canzoni, descrizioni cinematografiche e minimalismo.
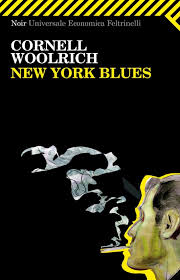 Penso a un racconto bellissimo come New York Blues, il cui seguito potrebbero essere certi (micro) testi (noir?) di Beckett; penso a Per finire ancora e altri fallimenti contenuti in un vecchio Einaudi dal titolo Racconti e teatro, dove alle city frenetiche e doppie di Woolrich si arriva alla tappa finale della strada perduta, all’ultima mutazione, ossia a dei non-luoghi chiusi, “di un nero inintaccabile, denso sui bordi come al centro”.
Penso a un racconto bellissimo come New York Blues, il cui seguito potrebbero essere certi (micro) testi (noir?) di Beckett; penso a Per finire ancora e altri fallimenti contenuti in un vecchio Einaudi dal titolo Racconti e teatro, dove alle city frenetiche e doppie di Woolrich si arriva alla tappa finale della strada perduta, all’ultima mutazione, ossia a dei non-luoghi chiusi, “di un nero inintaccabile, denso sui bordi come al centro”.
Beckett completerà il prosciugamento narrativo di Woolrich, colpendo la grammatica, riducendola alla selvaggia economia di un geroglifico, appunto diaristico per una fine del mondo umano a vantaggio di una totale amnesia del personaggio finzionale, non più gangster o passante notturno, bensì figura nel fango, che striscia lungo i muri di “cubo tutto luce bianco assoluto facce senza tracce nessun ricordo”, come descritto nei testi fulminati dell’Einaudi L’immagine senza lo spopolatore.
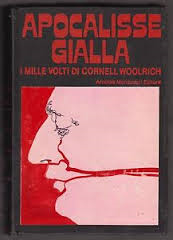 E non è un caso se Woolrich, in Italia, abbia avuto dei bellissimi Omnibus della Mondadori, assai azzeccati fin dalle copertine. Penso ad Apocalisse Gialla, con eccellente cura di Alberto Tedeschi e disegni di Ferenc Pinter, o all’Omnibus Vertigine, con un dipinto di Bacon ad aprire il libro e a chiudere un cerchio, il nostro.
E non è un caso se Woolrich, in Italia, abbia avuto dei bellissimi Omnibus della Mondadori, assai azzeccati fin dalle copertine. Penso ad Apocalisse Gialla, con eccellente cura di Alberto Tedeschi e disegni di Ferenc Pinter, o all’Omnibus Vertigine, con un dipinto di Bacon ad aprire il libro e a chiudere un cerchio, il nostro.
Ecco.
Tiriamo le fila.
Il noir.
Beckett.
L’Auster della Trilogia di New York e di Viaggio nello scriptorum.
Lo Sclavi di Nero.
Non è un caso se Strade perdute finisce col personaggio di Bill Pulman che muta, assumendo le forme provvisorie di un dipinto di Bacon.
Un viso distorto da pennellate di carne.
Personaggio atomo di parole su un foglio bianco (e nero) fatto di buchi, regressioni, precarietà ansiogene e astrazione esistenziale.
Oggi, in un’epoca di neoliberismo terminale, nella sistematica distruzione dei sistemi di tutela conquistati dai movimenti in oltre 150 anni di lotte, quest’uomo deambulante, grumo precario dal destino ineluttabile, è perfetto.