 La morte ha sorriso all’assassino di Aristide Massaccesi, con Ewa Aulin e Klaus Kinski, anno 1973. La morte è sempre stato visto come un Le Fanu riletto da Massaccesi con l’accidia tipica dei film liquefatti di Jean Rollin. Un vampiresco pseudo-artistico alla maniera francese. Tuttavia, nella vicenda scritta anche dallo stesso regista, possiamo rinvenire tracce di un isterismo spettrale concentrato sulla figura mesmerica di Greta/Ewa Aulin. Greta è una bambolina di carne, avvolta da reggicalze e stivaletti di pelle, oppure dalle pieghe d’un mantello che le conferisce un’andatura da post-ombra, ectoplasma del desiderio che si può persino toccare, con cui si può fare l’amore dolcemente.
La morte ha sorriso all’assassino di Aristide Massaccesi, con Ewa Aulin e Klaus Kinski, anno 1973. La morte è sempre stato visto come un Le Fanu riletto da Massaccesi con l’accidia tipica dei film liquefatti di Jean Rollin. Un vampiresco pseudo-artistico alla maniera francese. Tuttavia, nella vicenda scritta anche dallo stesso regista, possiamo rinvenire tracce di un isterismo spettrale concentrato sulla figura mesmerica di Greta/Ewa Aulin. Greta è una bambolina di carne, avvolta da reggicalze e stivaletti di pelle, oppure dalle pieghe d’un mantello che le conferisce un’andatura da post-ombra, ectoplasma del desiderio che si può persino toccare, con cui si può fare l’amore dolcemente.
Greta/Aulin è morta di parto, infettata dal seme di Giacomo Rossi Stuart. Su di lui (e i suoi discendenti) graverà la maledizione. E così sarà sul fratello di lei, un deforme Luciano Rossi incestuoso e parafiliaco. Tra delitti al rasoio e fucilate in faccia, mentre un misterioso maniaco falcia tutti i comprimari, Massaccesi fotografa splendidamente la bella morta adagiata sul lettino d’un medico ipnotista affidato al carisma malato di Klaus Kinski. Greta rivela la propria eziologia traumatica di natura (come avrebbe appurato il buon Freud) sessuale e psicopatologica (appunto la figura di Giacomo Rossi Stuart, amante old fashion, un padre simbolico che alimenta la formazione di un sintomo traumatico). Greta è un fantasma carnoso che sconvolge la speculazione nosologica del dottor Kinski e cerca soddisfazione al proprio desiderio di vendetta oltretombale. Tutto ci riporta ai pornofumetti da stazione del periodo. Il corpo di Greta è una macchina dei nervi malfunzionante, una massa apatica di cera vivente, di energia pulsionale. I suoi bulbi, le sue movenze, rimandano alle sonnambule in trance ipnotica, regredite a uno stadio meramente automatico, atavico. Su di lei il dottor Kinski opera un teatro ottocentesco misto di pseudoscienza e grand guignol; Massaccesi non ci risparmia lo sguardo rompi cranio del medico intento a penetrare il nucleo cupo del bulbo epidermico di Greta. In lui il discorso razionale e geometrico della clinica come scienza dell’osservazione distaccata del malato trova piena corrispondenza. Ewa Aulin è il tableau su cui Kinski struttura le nuove classificazioni d’una medicina ispirata al De Vermis Mysteris di Ludvig Prinn.
 Nella stretta morsa del ragno di Antonio Margheriti, anno 1971. Anche qui troviamo il medesimo disordine psicosomatico nella tavolozza acidula di colori che compongono questo tardo remake (di se stesso). Nella stretta morsa del ragno ha un cast internazionale (Franciosa, Mercier, Kinski) e una trama che interpella fantasmi gravati dal senso di colpa del peccato carnale (tradimenti, lesbismo, sadismo ignorantissimo) e costretti a ri-vivere in eterno l’ultima (tragica) notte di vita. Nel gioco, le madamine coprono ogni gamma di femminilità: dalla passiva e masochista, alla padrona autoritaria e lesbica. Tuttavia, nei loro andirivieni, vi è un qualcosa di malfunzionante, corpi in balia d’una macchina dei nervi inceppata. Sono simili a sonnambule inceppate, fili automatici, avatar ritagliati su un fondale pseudoscientifico (Carmus, Poe) tipico in questo tipo di pellicole. E se il gotico inglese intrattiene un rapporto più fecondo con la scienza positivista, quello italico è più alla carlona, moralista e superficiale. Le donne sono tutte puttane, gli uomini tutti puttanieri (magari ammorbiditi da un romanticismo da benpensanti DC). Indemoniate, mad doctor, mostri deformi e iper-dotati e altre bizzarrie. Margheriti è bravo a visualizzare il suo teatrino di carne. Li rallenta, li fotografa già come fluidi. In sintesi, l’isteria delle isteriche di Nella stretta morsa è un rovesciamento dell’iconografia spiritica, col fotografo tecnologico e le sue macchine acustiche. Il personaggio di Franciosa è in balia d’uno spazio meraviglioso che non può essere archiviato, fotografato, fissato su lastre di bromuro.
Nella stretta morsa del ragno di Antonio Margheriti, anno 1971. Anche qui troviamo il medesimo disordine psicosomatico nella tavolozza acidula di colori che compongono questo tardo remake (di se stesso). Nella stretta morsa del ragno ha un cast internazionale (Franciosa, Mercier, Kinski) e una trama che interpella fantasmi gravati dal senso di colpa del peccato carnale (tradimenti, lesbismo, sadismo ignorantissimo) e costretti a ri-vivere in eterno l’ultima (tragica) notte di vita. Nel gioco, le madamine coprono ogni gamma di femminilità: dalla passiva e masochista, alla padrona autoritaria e lesbica. Tuttavia, nei loro andirivieni, vi è un qualcosa di malfunzionante, corpi in balia d’una macchina dei nervi inceppata. Sono simili a sonnambule inceppate, fili automatici, avatar ritagliati su un fondale pseudoscientifico (Carmus, Poe) tipico in questo tipo di pellicole. E se il gotico inglese intrattiene un rapporto più fecondo con la scienza positivista, quello italico è più alla carlona, moralista e superficiale. Le donne sono tutte puttane, gli uomini tutti puttanieri (magari ammorbiditi da un romanticismo da benpensanti DC). Indemoniate, mad doctor, mostri deformi e iper-dotati e altre bizzarrie. Margheriti è bravo a visualizzare il suo teatrino di carne. Li rallenta, li fotografa già come fluidi. In sintesi, l’isteria delle isteriche di Nella stretta morsa è un rovesciamento dell’iconografia spiritica, col fotografo tecnologico e le sue macchine acustiche. Il personaggio di Franciosa è in balia d’uno spazio meraviglioso che non può essere archiviato, fotografato, fissato su lastre di bromuro.
Tutto si ripeterà.
Per qualcun altro.
Noi saremo già morti.
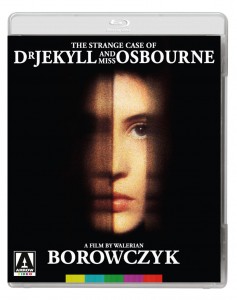 The strange case of Dr. Jekyll and miss Osbourne di Walerian Borowczyk, anno 1981. Cast: Udo Kier, Marina Pierro, Howard Vernon. Uno dei gotici più belli in assoluto. Il regista prova a spacciarlo come un recupero dal testo originale di Stevenson, quello infittito dei tubercolinici deliri sessuali di Hyde, retore delle tenebre profonde. The strange case, nelle mani di un regista snob che qui (per fortuna) precipita nei generi più sozzi e compiaciuti (dalle parti di un Franco, di un Rollin, sollevati al di sopra dei propri limiti cerebrali). Il film è doppio. The strange case of Dr. Jekyll and Miss Osbourne, col culo rinascimentale di Marina Pierro (poco dopo musa anche per Rollin) nel ruolino censorio di Fanny Osbourn, la moglie reale di Stevenson, colei che bruciò la prima stesura del testo di Jekyll. Borowczyk immagina di restaurare l’opera narrativa (analogamente a quello che farà Crepax con la sua trasposizione a fumetti) mescolando finzione e realtà. Fanny diventa la fidanzata, imminente sposa, di un Jekyll tra i più riusciti dello schermo: Udo Kier, già Conte Dracula, Barone Frankenstein. L’altra idea è quella di condensare tutta la storia durante le fasi d’una cena per il fidanzamento ufficiale dei due protagonisti. Gli altri personaggi sono i commensali invitati, tra cui il dottor Lanyon, un generale, un reverendo. Ognuno sarà costretto a rincorrere per le varie stanze le voluttà di un Hyde raffinato e grottesco, dotato d’un pene mostruoso con cui squarta i culetti delle fanciulle convenute alla festa (ad interpretare il mostro è l’attore Gerard Zalcberg, che ritornerà in simili faccende nel Jess Franco del 1988, I violentatori della notte). Questa contrazione uterina dei luoghi rimanda all’Angelo Sterminatore di Bunuel, e così i conflitti sociali che esplodono nel proseguo della trama; il pomposo reverendo, il sadico generale, l’arrogante dr. Lanyon (interpretato dal sempre ottimo Howard Vernon). Tra loro Zalcberg/Hyde libera le sue azioni amorali e fisiche, a metà tra un Buster Keaton glaciale e i deliri fallici del Kinski de Le amanti del mostro. A impreziosire la messa in scena, una ricerca estetica lontanissima dal cinema fantastico pieno di effetti di quei primi anni ’80. Borowczyk ricerca la magia d’un Melies pornografo, attratto da camere oscure, magie degli specchi e giochi di lanterne magiche, insomma tutto un teatro d’ombre pre-cinema, regressione verso i tableaux de projections mouvementes . E Miss Osbourne? E l’isteria? Qui si libera quando le femmine borghesi sono attinte dal cazzo asinino di Hyde. In loro s’accende una fregola che le tramuta da probe figliole in meretrici da bordello, sguaiate donnacce semiepilettiche. La chiarovisione (o chiavovisione) del cazzo di Hyde le declassa da elite alto borghese a sonnambule dai deretani spanati. E a nulla potranno servire i salassi, le sanguisughe e le vescicanti. Miss Osbourne è la sola a possedere un quid regale, un’eterodossia del corpo represso da sciogliere nella trance della vasca da bagno, efficacissimo simbolo color terra di una panacea universale, specchio psichico del meraviglioso fuori da ogni regola. Hyde & Osbourne faranno piazza pulita delle false moraline vittoriane, uccideranno i padri, accoltelleranno le madri, fuggiranno in carrozza, liberi di amarsi, mordersi, leccarsi tra i rulli saltellanti dei fotogrammi. E la musica di Bernard Parmigiani fiorisce nei diorami dell’ombra. Immenso.
The strange case of Dr. Jekyll and miss Osbourne di Walerian Borowczyk, anno 1981. Cast: Udo Kier, Marina Pierro, Howard Vernon. Uno dei gotici più belli in assoluto. Il regista prova a spacciarlo come un recupero dal testo originale di Stevenson, quello infittito dei tubercolinici deliri sessuali di Hyde, retore delle tenebre profonde. The strange case, nelle mani di un regista snob che qui (per fortuna) precipita nei generi più sozzi e compiaciuti (dalle parti di un Franco, di un Rollin, sollevati al di sopra dei propri limiti cerebrali). Il film è doppio. The strange case of Dr. Jekyll and Miss Osbourne, col culo rinascimentale di Marina Pierro (poco dopo musa anche per Rollin) nel ruolino censorio di Fanny Osbourn, la moglie reale di Stevenson, colei che bruciò la prima stesura del testo di Jekyll. Borowczyk immagina di restaurare l’opera narrativa (analogamente a quello che farà Crepax con la sua trasposizione a fumetti) mescolando finzione e realtà. Fanny diventa la fidanzata, imminente sposa, di un Jekyll tra i più riusciti dello schermo: Udo Kier, già Conte Dracula, Barone Frankenstein. L’altra idea è quella di condensare tutta la storia durante le fasi d’una cena per il fidanzamento ufficiale dei due protagonisti. Gli altri personaggi sono i commensali invitati, tra cui il dottor Lanyon, un generale, un reverendo. Ognuno sarà costretto a rincorrere per le varie stanze le voluttà di un Hyde raffinato e grottesco, dotato d’un pene mostruoso con cui squarta i culetti delle fanciulle convenute alla festa (ad interpretare il mostro è l’attore Gerard Zalcberg, che ritornerà in simili faccende nel Jess Franco del 1988, I violentatori della notte). Questa contrazione uterina dei luoghi rimanda all’Angelo Sterminatore di Bunuel, e così i conflitti sociali che esplodono nel proseguo della trama; il pomposo reverendo, il sadico generale, l’arrogante dr. Lanyon (interpretato dal sempre ottimo Howard Vernon). Tra loro Zalcberg/Hyde libera le sue azioni amorali e fisiche, a metà tra un Buster Keaton glaciale e i deliri fallici del Kinski de Le amanti del mostro. A impreziosire la messa in scena, una ricerca estetica lontanissima dal cinema fantastico pieno di effetti di quei primi anni ’80. Borowczyk ricerca la magia d’un Melies pornografo, attratto da camere oscure, magie degli specchi e giochi di lanterne magiche, insomma tutto un teatro d’ombre pre-cinema, regressione verso i tableaux de projections mouvementes . E Miss Osbourne? E l’isteria? Qui si libera quando le femmine borghesi sono attinte dal cazzo asinino di Hyde. In loro s’accende una fregola che le tramuta da probe figliole in meretrici da bordello, sguaiate donnacce semiepilettiche. La chiarovisione (o chiavovisione) del cazzo di Hyde le declassa da elite alto borghese a sonnambule dai deretani spanati. E a nulla potranno servire i salassi, le sanguisughe e le vescicanti. Miss Osbourne è la sola a possedere un quid regale, un’eterodossia del corpo represso da sciogliere nella trance della vasca da bagno, efficacissimo simbolo color terra di una panacea universale, specchio psichico del meraviglioso fuori da ogni regola. Hyde & Osbourne faranno piazza pulita delle false moraline vittoriane, uccideranno i padri, accoltelleranno le madri, fuggiranno in carrozza, liberi di amarsi, mordersi, leccarsi tra i rulli saltellanti dei fotogrammi. E la musica di Bernard Parmigiani fiorisce nei diorami dell’ombra. Immenso.
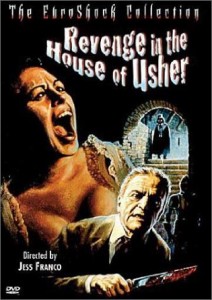 Revenge in the House of Usher, di Jess Franco, con Howard Vernon, Lina Romay, Francoise Blanchard, Antonio Mayans, anno 1983. E’ curioso notare come alcuni di questi gotici (potremmo pensare anche a Rollin, certo) abbiano un evidente interesse per il pre-cinema, quello delle avanguardie. Qui Franco opera una ricostruzione linguistica raffinatissima, sperimentando una regia e una recitazione che guarda al passato e cancella tutte le recenti innovazioni di una industria (quella americana) sempre e solo narrativa. La casa Usher di Franco è l’occasione per resettare tutto il proprio cinema e ri-partire. L’immagine, il montaggio, il ritmo (soprattutto) riflettono una intensità negativa, una rottura dagli orizzonti disciplinari della verosimiglianza. Feuilletons, mondo onirico e una recitazione automatica, sgangherata, al limite del ridicolo, puro gioco estroflesso nella sostanza stessa dello sguardo. Ed è questa follia latente, anarchica, ad avvicinare questo cinema (così come per il Jekyll di Borowczyk) agli stati mentali psico-patologici, che sin dalle prime 3 pagine del Manifesto del Surrealismo vengono difesi ed equiparati alle frontiere della ragione. La ragione di questa similitudine tra isteria/follia e cinema sperimentale sta nella possessione dello spirito poetico, nel delirio mentale di Franco, interessato a raccontare pochissimo e a mostrare ancora meno (solo certe concessioni sfumate sui piedini della Blanchard, tra le pieghe del sudario). Questo Usher franchiano lasciò l’amaro in bocca persino ai fan del regista spagnolo: zero spirito fumettistico, zero porno e pruriginoso. La casa Usher va in sottrazione, asciuga la messa in scena, concentrandosi sulla follia verbale di Roderick/Vernon, lasciando campo alle parole di una biografia sempre contro i condizionamenti della società (cinematografica) e della vita.
Revenge in the House of Usher, di Jess Franco, con Howard Vernon, Lina Romay, Francoise Blanchard, Antonio Mayans, anno 1983. E’ curioso notare come alcuni di questi gotici (potremmo pensare anche a Rollin, certo) abbiano un evidente interesse per il pre-cinema, quello delle avanguardie. Qui Franco opera una ricostruzione linguistica raffinatissima, sperimentando una regia e una recitazione che guarda al passato e cancella tutte le recenti innovazioni di una industria (quella americana) sempre e solo narrativa. La casa Usher di Franco è l’occasione per resettare tutto il proprio cinema e ri-partire. L’immagine, il montaggio, il ritmo (soprattutto) riflettono una intensità negativa, una rottura dagli orizzonti disciplinari della verosimiglianza. Feuilletons, mondo onirico e una recitazione automatica, sgangherata, al limite del ridicolo, puro gioco estroflesso nella sostanza stessa dello sguardo. Ed è questa follia latente, anarchica, ad avvicinare questo cinema (così come per il Jekyll di Borowczyk) agli stati mentali psico-patologici, che sin dalle prime 3 pagine del Manifesto del Surrealismo vengono difesi ed equiparati alle frontiere della ragione. La ragione di questa similitudine tra isteria/follia e cinema sperimentale sta nella possessione dello spirito poetico, nel delirio mentale di Franco, interessato a raccontare pochissimo e a mostrare ancora meno (solo certe concessioni sfumate sui piedini della Blanchard, tra le pieghe del sudario). Questo Usher franchiano lasciò l’amaro in bocca persino ai fan del regista spagnolo: zero spirito fumettistico, zero porno e pruriginoso. La casa Usher va in sottrazione, asciuga la messa in scena, concentrandosi sulla follia verbale di Roderick/Vernon, lasciando campo alle parole di una biografia sempre contro i condizionamenti della società (cinematografica) e della vita.
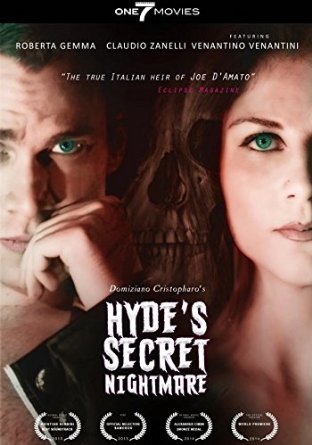 Un film recente, del 2013, è Hyde’s secret nightmare di Domiziano Cristopharo, con Roberta Gemma, Claudio Zanelli e Venantino Venantini. La trama riprende lo spunto del film di Roy Ward Baker Barbara, il mostro di Londra, col dottor Jekyll che si tramutava in una donna. Tuttavia Cristopharo sembra guardare maggiormente a The adult version of Jekyll & Hyde di Lee Raymond o ai porno horror di Joe D’Amato a cui il film è dedicato. Zanelli è uno scienziato impotente che, come in ogni porno fumetto che si rispetti, è alla ricerca di una cura ai propri mali fisici (e morali). In un laboratorio d’una povertà alla Jess Franco, l’uomo si fa portare cadaveri di donne e uomini per trafficare coi suoi sieri. Lo aiutano un servo storpio innamorato di lui e un becchino portantino di autoambulanze che è pure necrofilo e si chiama come l’arabo pazzo che ha scritto il Necronomicon. Alla fine Henry proverà il siero su se stesso, tramutandosi nella bellissima pornostar Roberta Gemma. Il film porta con sè tutte le ossessioni di questo regista originale, capace di mescolare il porno cinema necrofilo di Massaccesi a quello lirico e surreale di Fellini. A scene gore e hard seguono sequenze in cui gli attori guardano direttamente in macchina e si lasciano andare a confessioni extra-diegetiche, accompagnati da musiche alla Nino Rota. E’ il baraccone di carne di Cristopharo. L’opera, pur nei suoi limiti di budget, svela un coraggio ambizioso nella messa in scena, scrollandosi di dosso l’intimismo esistenziale di tutto il cinema italiano di oggi. Domiziano abbraccia i generi e li adatta ai suoi gusti da body performer affascinato dalle dark room oscure delle periferie romane. Le inquadrature si riempiono come tavole di un fumetto della Ediperiodici, mettendo il glande in primo piano e volti di donne putrefatti in secondo piano. L’isteria qui c’entra poco. Forse solo nei corpi adagiati e spenti dei cadaveri manipolati dal pene del laido Abdul il necrofilo, degno omaggio al Nekromantic di Jorg Buttgereit. Una di esse, durante una penetrazione sulla lettiga dell’autoambulanza, rinviene, similmente a quanto fa il cadavere manipolato dalle scienze azteche del dottor Kinski nel film di D’Amato. Tempo dopo, all’ospedale, la donna rediviva presenterà i segni di quell’irrigidimento coatto del corpo mesmerico patologicamente leso, ridotto a mero carattere significante, metafora sintomatica di un involucro in presa diretta sull’immaginario.
Un film recente, del 2013, è Hyde’s secret nightmare di Domiziano Cristopharo, con Roberta Gemma, Claudio Zanelli e Venantino Venantini. La trama riprende lo spunto del film di Roy Ward Baker Barbara, il mostro di Londra, col dottor Jekyll che si tramutava in una donna. Tuttavia Cristopharo sembra guardare maggiormente a The adult version of Jekyll & Hyde di Lee Raymond o ai porno horror di Joe D’Amato a cui il film è dedicato. Zanelli è uno scienziato impotente che, come in ogni porno fumetto che si rispetti, è alla ricerca di una cura ai propri mali fisici (e morali). In un laboratorio d’una povertà alla Jess Franco, l’uomo si fa portare cadaveri di donne e uomini per trafficare coi suoi sieri. Lo aiutano un servo storpio innamorato di lui e un becchino portantino di autoambulanze che è pure necrofilo e si chiama come l’arabo pazzo che ha scritto il Necronomicon. Alla fine Henry proverà il siero su se stesso, tramutandosi nella bellissima pornostar Roberta Gemma. Il film porta con sè tutte le ossessioni di questo regista originale, capace di mescolare il porno cinema necrofilo di Massaccesi a quello lirico e surreale di Fellini. A scene gore e hard seguono sequenze in cui gli attori guardano direttamente in macchina e si lasciano andare a confessioni extra-diegetiche, accompagnati da musiche alla Nino Rota. E’ il baraccone di carne di Cristopharo. L’opera, pur nei suoi limiti di budget, svela un coraggio ambizioso nella messa in scena, scrollandosi di dosso l’intimismo esistenziale di tutto il cinema italiano di oggi. Domiziano abbraccia i generi e li adatta ai suoi gusti da body performer affascinato dalle dark room oscure delle periferie romane. Le inquadrature si riempiono come tavole di un fumetto della Ediperiodici, mettendo il glande in primo piano e volti di donne putrefatti in secondo piano. L’isteria qui c’entra poco. Forse solo nei corpi adagiati e spenti dei cadaveri manipolati dal pene del laido Abdul il necrofilo, degno omaggio al Nekromantic di Jorg Buttgereit. Una di esse, durante una penetrazione sulla lettiga dell’autoambulanza, rinviene, similmente a quanto fa il cadavere manipolato dalle scienze azteche del dottor Kinski nel film di D’Amato. Tempo dopo, all’ospedale, la donna rediviva presenterà i segni di quell’irrigidimento coatto del corpo mesmerico patologicamente leso, ridotto a mero carattere significante, metafora sintomatica di un involucro in presa diretta sull’immaginario.
E potremmo continuare su questa china citando anche le vampire mesmerizzate del finale de Il plenilunio delle vergini, pseudo erotico squallido e satanico, o la pazza segregata nel finale del rozzo (e sozzo) La sanguisuga conduce la danza, cripto-gotico-trash di metà anni ’70, infettato dai medesimi cascami dell’inconscio rimosso, funzione biologica anatomica dell’occhio psicogeno della visione.






























