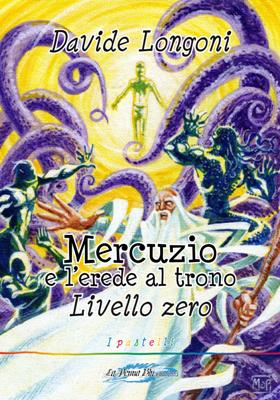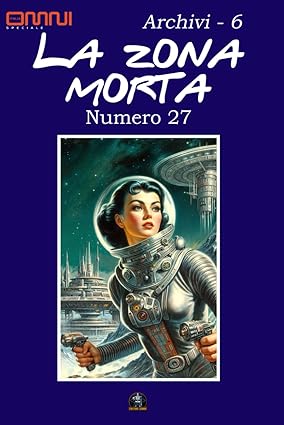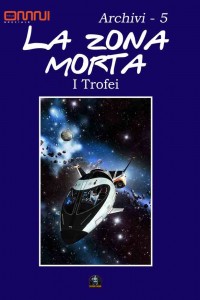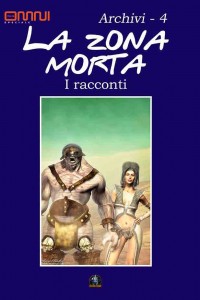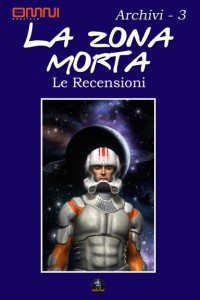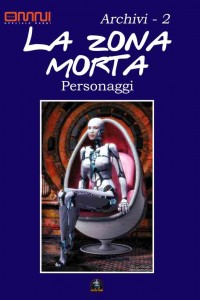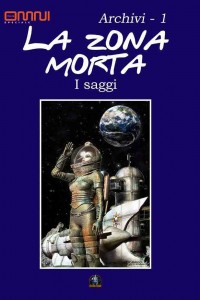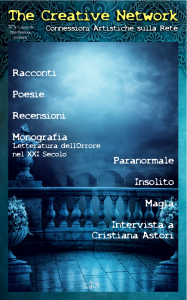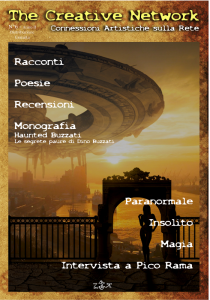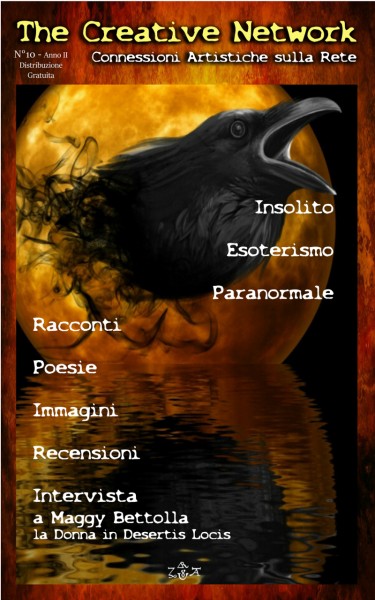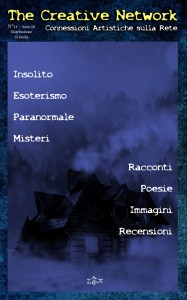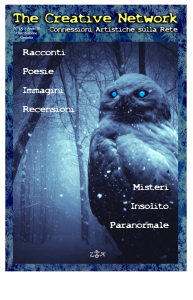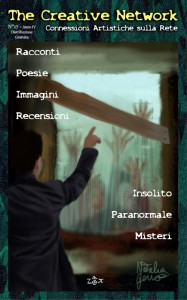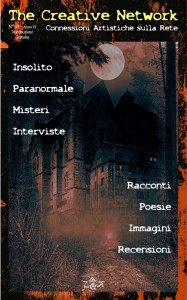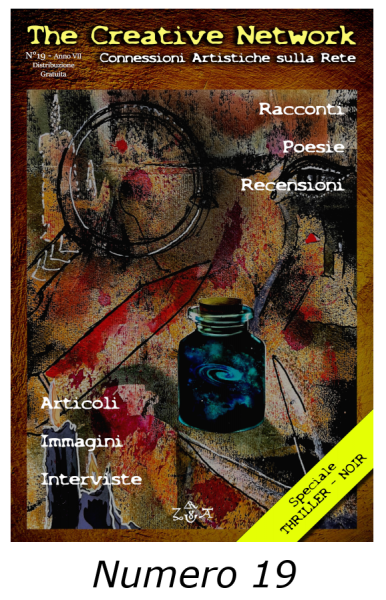SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA“Solaris” fu pubblicizzato come la risposta sovietica a “2001: odissea nello spazio” di Kubrick. Nulla di più falso e antipodico, pur essendo entrambi due capolavori assoluti. La tecnologia messa in mostra in ”2001” è totalmente ignorata in “Solaris”, quasi completamente privo di effetti speciali: la stazione orbitale è colta nei suoi aspetti più “terrestri”, niente hardware scenografico elettronico ma scorci di dipinti, libri, frutti, immagini, oggetti comunissimi nelle case di ciascuno. Per Tarkowskij la vera odissea avviene nella coscienza, nello spazio interiore dell’anima. La sua riflessione filosofica è limpida e morale (prima di lanciarsi nello spazio alla ricerca di altre intelligenze è meglio che l’uomo conosca a fondo se stesso), il suo stile lirico, nostalgico, malinconico, a volte struggente. A differenza del romanzo di Lem (forse una delle più grandi opere di SF mai scritte), a tratti dinamico e decisamente fantascientifico, nonché assolutamente pessimistico per quanto concerne la posizione dell’uomo nell’universo, Tarkowskij dirige una pellicola lentissima, quasi elegiaca, in cui si perde l’impressione di trovarsi nello spazio. Ma “Solaris” è un’opera unica, eccezionale, commovente. Nessuna creatura aliena è mai stata descritta con la veridicità (sia letteraria che cinematografica) dell’oceano pensante, totalmente estraneo ad ogni tentativo d’interpretazione umana (e quasi del tutto estraneo anche nell’economia del film, incentrato tutto sul rapporto tra Kelvin e Harey, che si umanizza sempre di più rinfacciando agli uomini il loro amorale senso della scienza e della verità). Se Lem è pessimista, Tarkowskij crede nei miracoli e conclude il film con la speranza del contatto, del ritorno (non della donna amata, ma della terra rimpianta, dei veri valori della vita). La sequenza della resurrezione di Harey dopo che ha inghiottito l’ossigeno liquido è terrificante e straziante allo stesso tempo mentre dolcissima è quella dell’assenza di gravità che coglie la coppia abbracciata nella biblioteca. Va comunque rilevata una certa pesantezza del narrato, specie nella seconda parte del film, quando i ricordi terrestri di Kelvin si fondono con l’esperienza vissuta sulla stazione, tematiche non presenti nel romanzo di Lem e dovute tutte allo spirito di Tarkowskij. La versione italiana di “Solaris” è sciaguratamente priva di almeno 45’, tutta la parte sulla Terra con l’incontro di Kelvin e Berton (in Kelvin vengono fusi ridicolmente i due personaggi antitetici tra loro) e diverse scene molto importanti al fine della comprensione del film. Il doppiaggio è cagnesco e dialettale: Pier Paolo Pasolini doppia il padre di Kelvin e Gibarian ha assunto una cadenza così partenopea da risultare ben oltre il ridicolo. Un’operazione vergognosa, che colpì così negativamente Tarkowskij da indurlo a lasciare l’Italia. Da recuperare la versione originale sottotitolata in inglese ed evitare accuratamente quella italiana. Al di là di tutto, un capolavoro assoluto (e grande tonfo al botteghino). Remake nel 2003 di Steven Soderbergh.