DINO BARBERO – professore di Storia
CARLO DECOVIC – scultore, cugino del Barbero
NARRATORE – amico del Barbero
QUINTINO BARBERO – zio defunto del Barbero
GUGLIELMO FRAGONARD – professore in pensione
ISPETTORE LANG – uno degli inquirenti
La grande nevicata cominciò la sera del 23 dicembre.
I rumori del traffico si affievolirono, le tracce dei pneumatici, le orme dei passanti e tutti gli altri segni del mondo civile vennero cancellati da fiocchi bianchi che scendevano volteggiando dalla sorgente illimitata del cielo. La gente si chiedeva se avrebbe mai smesso. Io, invece, mi sentivo così stanco, da non badar più a tutto quel biancore. Desideravo solamente tornare a casa, riscaldare le mie povere ossa, assopirmi nel letto e dimenticare ogni cosa. Dormii per buona parte della giornata del 24 e quando riuscii ad alzarmi, mi sentivo ancora gelato e inquieto. Per fortuna nessun incubo aveva turbato il mio sonno. Nessuna bara divelta, nessun cadavere a spasso nelle notti di brina. Le prime ombre del pomeriggio indugiavano nel mio salotto. Controllai la segreteria. Un messaggio era dell’ispettore Lang: mi chiedeva di passare alla Questura per firmare la mia deposizione sui fatti concernenti la morte del mio amico, il professor Dino Barbero. Ancora scosso, accesi le luci e cercai conforto in un disco di musica jazz. Un secondo messaggio apparteneva al professor Fragonard. Mi chiedeva se erano arrivati i libri che aveva ordinato presso la mia libreria. In effetti erano arrivati e li avevo davanti a me, incartati in un voluminoso pacco marrone. Pur di sfuggire all’abisso della notte che mi stava nuovamente stringendo, decisi di uscire per prendere una boccata d’aria e andare di persona a consegnare i libri. Successivamente sarei passato in Questura.
Fuori la neve aveva smesso di cadere e il bianco scenario della città era immoto, paralizzato da cumuli bianchi e scintillanti, alti come muri. Camminavo in quel silenzio innaturale e i miei scarponi erano ancora chiazzati dal fango della sera precedente. Il fango del cimitero! Un lungo brivido di paura socchiuse per un attimo il fragile velo della memoria, riportandomi a quelle lunghe ore d’inferno. Cercai di non pensarci, concentrandomi sulla spessa coltre di neve nella quale affondavano i miei passi. Arrivai a casa del professor Fragonard. Negli anni del liceo era stato il mio istitutore di latino. Fragonard, ormai in pensione, aveva insegnato per quarant’anni, nutrendo e ispirando, dall’alto della sua immensa cultura, generazioni di studenti. Eravamo rimasti in contatto anche negli anni dell’Università, poi, quando avevo aperto la mia libreria, lo avevo ritrovato come affezionato cliente e amico. La moglie del professore mi accolse sulla soglia con la consueta gentilezza. Mi fece accomodare, porgendomi un paio di pantofole comode e asciutte. Fragonard mi aspettava nel suo piccolo studio ricolmo di libri e stampe d’epoca. Non appena i suoi occhi caddero sul voluminoso pacco di libri, una luce euforica ne illuminò i lineamenti bambineschi. La sua mole alta e robusta si alzò dalla comoda poltrona di pelle e venne ad abbracciarmi con forza. Nonostante cercassi di mostrarmi disinvolto e cordiale, al professore non sfuggì il mio aspetto sconvolto. Con grande tatto aprì la pagina del quotidiano locale e mi chiese se sapessi qualcosa sull’incredibile morte del professor Barbero. Il mio ex maestro ricordava che ero confidente di quell’altro illustre studioso di storia medievale – assurto agli onori accademici dopo studi chiarissimi e trasmissioni televisive di felice successo – e mi fu difficile sottrarmi. Ancora esausto, e con una dura pena nel cuore, mi accomodai nello studio, lasciando che i ricordi concitati della notte precedente risalissero dall’abisso. Fragonard accese una sigaretta e rimase ad ascoltarmi. I suoi occhi sornioni brillavano intensi e non perdevano una sola parola. Mi avrebbe interrotto raramente, per avere chiarimenti su piccoli particolari a cui non avevo prestato la minima attenzione, oppure per assentarsi alcuni istanti e tornare carico di cioccolatini per il suo fedelissimo gatto nero, Belfagor. L’animale ci osservava dall’alto di una pila di dizionari, indifferente ai nostri discorsi e ai miei patemi. Ogni tanto si leccava una zampina o saltava da uno scaffale all’altro, in cerca di un cantuccio più comodo. Fuori dalle finestre un’aria d’eterno biancheggiava in lontananza, riportandomi alla sera precedente, quando il mio amico Dino Barbero mi aveva convocato a casa sua, nella frazione di Lucedio, per aiutarlo a riesumare la salma del defunto zio.
Con noi c’era Carlo Decovic, scultore abbastanza noto nella città e cugino del Barbero.
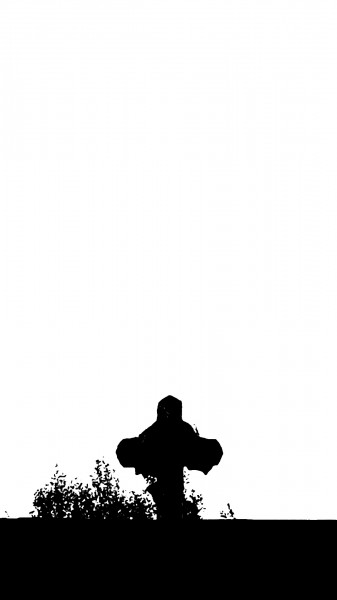 Dino ci aveva chiamati fuori città, nell’abitazione di campagna che aveva ereditato, insieme a tutte le ingenti sostanze, dallo zio Quintino Barbero, deceduto qualche mese prima. Quintino era stato un noto finanziere, finito sui giornali nazionali per aver frequentato ministri e deputati e per qualche oscuro scandalo finanziario. La sua frenetica vita, sempre all’inseguimento degli astratti labirinti dell’economia, era terminata a 84 anni per via di una gastrite mai curata. Dino, come unico erede, all’apice del suo successo (da poco era terminata una trasmissione di divulgazione storica prodotta dalla RAI) aveva preferito lasciare i ritmi e la vita cittadina per trasferirsi nella casa isolata del parente, in una frazione paludosa e sonnolenta come quella di Lucedio. Qui s’era cullato nel successo arriso dal programma e aveva deciso di prendersi un anno di congedo dall’Università per preparare un nuovo libro. Ogni tanto abbandonava i suoi studi per qualche uscita galante (era uno scapolo conteso da molte ricercatrici) o per delle cene editoriali. Spesso veniva in centro per ordinare dei volumi nella mia libreria. Ne approfittavamo per un aperitivo veloce e qualche battuta sui bei tempi andati. Fu proprio durante uno di questi ultimi incontri (avvenuto dopo un lungo periodo di assenza e silenzio) che Dino mi pregò di raggiungerlo a casa sua. Voleva mettermi a parte di alcuni episodi incresciosi che gli erano capitati. Durante quel breve colloquio, mi apparve velatamente preoccupato, quasi oppresso da qualcosa d’informe e cupo che lo seguiva come un’ombra. Più volte, infatti, lo vidi girarsi bruscamente e scrutare le facce dei passanti oltre le porte a vetri del mio negozio. Mi diede subito l’impressione di una persona che si sentiva perseguitata. Glielo chiesi, e lui preferì dileguarsi in fretta, con la promessa di spiegarmi ogni cosa la sera successiva. E così fu. Il 23 dicembre guidai fino a casa di Dino. Il cielo notturno era al contempo scuro e vivido, carico di quella neve che presto ci avrebbe sommersi. Dino mi accolse in un salotto confortevole e spazioso, illuminato da un grande fuoco che ardeva nel camino. Ceppi impilati e pitture a olio in pesanti cornici dorate rendevano perfetta quell’atmosfera quieta. In realtà il mio amico non si sentiva affatto al sicuro. Poco dopo arrivò suo cugino, Carlo Decovic, che già conoscevo. Carlo mi salutò calorosamente, informandosi su alcuni amici comuni. Capii che anche lui era all’oscuro dei motivi di quell’invito inusuale. Il nostro ospite ci offrì da bere. Comodamente seduti nelle poltrone del salotto, lo ascoltammo mentre raccontava una storia assurda e penosa che aveva trasformato il suo ultimo mese in un lungo incubo a occhi aperti. Tutto era cominciato poco dopo il trasferimento nella casa dello zio. Piccoli segni. Premonizioni a cui non aveva dato molta importanza. Una sera, rientrato da una cena, s’era infilato nella doccia. Sotto i getti caldi e vaporosi, ebbe la sensazione che ci fosse qualcuno nella casa. Quasi gli sembrò di scorgere un’ombra immobile oltre i vetri smerigliati. Temendo per un ladro, agguantò l’accappatoio ed esaminò ogni stanza, senza incontrare nessuno. Chiuse bene ogni finestra e controllò la serratura delle porte. Nessun segno di scasso. Solo una piccola pozza d’acqua fangosa appena davanti all’ingresso. Non diede molta importanza alla cosa, dopotutto quella sera aveva piovuto e poteva essere stato lui stesso a chiazzare il vestibolo. Ormai tranquillo, tornò in camera, si vestì, indossò la vestaglia e cercò il portasigarette d’argento da cui non si separava mai (fumava infatti solo una marca inglese d’importazione). Si accorse che l’oggetto era sparito, eppure ricordava di averlo lasciato sul tavolino del salotto. Lo cercò dappertutto, in ogni camera, nelle tasche dei vestiti che aveva indossato, ma il portasigarette era scomparso. Quella sera Dino s’addormentò incredulo, con una sensazione cupa e minacciosa a cui non sapeva trovare una risposta. I giorni seguenti cercò ancora il portasigarette d’argento, infine si convinse di averlo perso e se ne dimenticò. Passò un’altra settimana. Una sera, solo in casa, seduto in poltrona dinanzi al camino, con un buon giallo sulle ginocchia, Dino provò nuovamente la sensazione d’essere spiato. Da uomo di cultura non indugiò in pensieri bambineschi e nebulosi e ignorò quella sensazione. Poi percepì un rumore nel silenzio della casa. Un suono chiaro, improvviso, echeggiante e inconfondibile. Una risata smorzata. Dino spense subito la luce dell’abatjour e s’accostò a una delle finestre. Quel che vide lo lasciò senza fiato, sgretolando in un attimo tutta la sua razionalità.
Dino ci aveva chiamati fuori città, nell’abitazione di campagna che aveva ereditato, insieme a tutte le ingenti sostanze, dallo zio Quintino Barbero, deceduto qualche mese prima. Quintino era stato un noto finanziere, finito sui giornali nazionali per aver frequentato ministri e deputati e per qualche oscuro scandalo finanziario. La sua frenetica vita, sempre all’inseguimento degli astratti labirinti dell’economia, era terminata a 84 anni per via di una gastrite mai curata. Dino, come unico erede, all’apice del suo successo (da poco era terminata una trasmissione di divulgazione storica prodotta dalla RAI) aveva preferito lasciare i ritmi e la vita cittadina per trasferirsi nella casa isolata del parente, in una frazione paludosa e sonnolenta come quella di Lucedio. Qui s’era cullato nel successo arriso dal programma e aveva deciso di prendersi un anno di congedo dall’Università per preparare un nuovo libro. Ogni tanto abbandonava i suoi studi per qualche uscita galante (era uno scapolo conteso da molte ricercatrici) o per delle cene editoriali. Spesso veniva in centro per ordinare dei volumi nella mia libreria. Ne approfittavamo per un aperitivo veloce e qualche battuta sui bei tempi andati. Fu proprio durante uno di questi ultimi incontri (avvenuto dopo un lungo periodo di assenza e silenzio) che Dino mi pregò di raggiungerlo a casa sua. Voleva mettermi a parte di alcuni episodi incresciosi che gli erano capitati. Durante quel breve colloquio, mi apparve velatamente preoccupato, quasi oppresso da qualcosa d’informe e cupo che lo seguiva come un’ombra. Più volte, infatti, lo vidi girarsi bruscamente e scrutare le facce dei passanti oltre le porte a vetri del mio negozio. Mi diede subito l’impressione di una persona che si sentiva perseguitata. Glielo chiesi, e lui preferì dileguarsi in fretta, con la promessa di spiegarmi ogni cosa la sera successiva. E così fu. Il 23 dicembre guidai fino a casa di Dino. Il cielo notturno era al contempo scuro e vivido, carico di quella neve che presto ci avrebbe sommersi. Dino mi accolse in un salotto confortevole e spazioso, illuminato da un grande fuoco che ardeva nel camino. Ceppi impilati e pitture a olio in pesanti cornici dorate rendevano perfetta quell’atmosfera quieta. In realtà il mio amico non si sentiva affatto al sicuro. Poco dopo arrivò suo cugino, Carlo Decovic, che già conoscevo. Carlo mi salutò calorosamente, informandosi su alcuni amici comuni. Capii che anche lui era all’oscuro dei motivi di quell’invito inusuale. Il nostro ospite ci offrì da bere. Comodamente seduti nelle poltrone del salotto, lo ascoltammo mentre raccontava una storia assurda e penosa che aveva trasformato il suo ultimo mese in un lungo incubo a occhi aperti. Tutto era cominciato poco dopo il trasferimento nella casa dello zio. Piccoli segni. Premonizioni a cui non aveva dato molta importanza. Una sera, rientrato da una cena, s’era infilato nella doccia. Sotto i getti caldi e vaporosi, ebbe la sensazione che ci fosse qualcuno nella casa. Quasi gli sembrò di scorgere un’ombra immobile oltre i vetri smerigliati. Temendo per un ladro, agguantò l’accappatoio ed esaminò ogni stanza, senza incontrare nessuno. Chiuse bene ogni finestra e controllò la serratura delle porte. Nessun segno di scasso. Solo una piccola pozza d’acqua fangosa appena davanti all’ingresso. Non diede molta importanza alla cosa, dopotutto quella sera aveva piovuto e poteva essere stato lui stesso a chiazzare il vestibolo. Ormai tranquillo, tornò in camera, si vestì, indossò la vestaglia e cercò il portasigarette d’argento da cui non si separava mai (fumava infatti solo una marca inglese d’importazione). Si accorse che l’oggetto era sparito, eppure ricordava di averlo lasciato sul tavolino del salotto. Lo cercò dappertutto, in ogni camera, nelle tasche dei vestiti che aveva indossato, ma il portasigarette era scomparso. Quella sera Dino s’addormentò incredulo, con una sensazione cupa e minacciosa a cui non sapeva trovare una risposta. I giorni seguenti cercò ancora il portasigarette d’argento, infine si convinse di averlo perso e se ne dimenticò. Passò un’altra settimana. Una sera, solo in casa, seduto in poltrona dinanzi al camino, con un buon giallo sulle ginocchia, Dino provò nuovamente la sensazione d’essere spiato. Da uomo di cultura non indugiò in pensieri bambineschi e nebulosi e ignorò quella sensazione. Poi percepì un rumore nel silenzio della casa. Un suono chiaro, improvviso, echeggiante e inconfondibile. Una risata smorzata. Dino spense subito la luce dell’abatjour e s’accostò a una delle finestre. Quel che vide lo lasciò senza fiato, sgretolando in un attimo tutta la sua razionalità.  Fuori, tra il folto di ramaglie e spine, nell’esiguo spazio di luce lasciato dalla nebbia fitta, scorse un’ombra che passeggiava nel giardino. Essa, quasi percependo lo sguardo del mio amico, si fermò per volgere il capo verso la finestra e mostrare un freddo sorriso di marmo. Il viso dell’intruso era remoto e pallido. Il freddo sorriso, quasi scolpito, brillava come un sudario lanuginoso. A quel punto Dino provò un dolore incontrollabile al petto e s’accasciò a terra. Quando rinvenne, parecchio tempo dopo, era già mattino. Tuttavia il fresco splendore del sole non riuscì a cancellare il ricordo orribile di quell’apparizione inconfondibile: l’uomo che passeggiava nel giardino era suo zio Quintino! Ricordo perfettamente i lineamenti pallidi e sbiancati del mio amico mentre ci riferiva di quell’incontro impossibile. Carlo, suo cugino, che tutto era fuorché un fautore del soprannaturale, si mostrò molto colpito da quella rivelazione e anch’io ebbi dei dubbi sulla salute del Barbero. Dino cercava di nasconderci l’orrore nel quale sentiva precipitare la sua vita, purtuttavia non era difficile scorgere nei suoi lineamenti contratti le stigmate di ciò che raccontava. Purtroppo per lui il racconto non era ancora finito. Il mattino in cui rinvenne, se ne accorse in seguito, il romanzo giallo che stava leggendo era sparito. Cercò di convincersi che s’era trattato di un incubo a occhi aperti, forse s’era addormentato mentre leggeva e aveva sognato tutto. Eppure il libro era svanito. Allora si ricordò del portasigarette d’argento e corse al vestibolo: un’altra pozza fangosa imbrattava l’ingresso principale! Questa volta per il mio amico fu più difficile riprendere il tranquillo tran tran quotidiano. Lo svenimento lo costrinse a rallentare i suoi ritmi di studio e a sottoporsi ad esami clinici dagli esiti infelici. Da tempo, infatti, Dino soffriva di una grave malattia al cuore, da cui solo i farmaci e gli effetti di una vita salubre avevano allontanato i pericoli. Nonostante tutto, riuscì a dimenticarsi dell’episodio. Non appena si sentì meglio si rituffò nei suoi impegni e cominciò la stesura del nuovo saggio accademico. L’entusiasmo per il lavoro lo portò a progettare una nuova trasmissione da proporre ai dirigenti della RAI di Torino. Insomma, nel giro di una settimana, il mio amico era tornato dinamico e allegro come sempre. Durò poco. Di ritorno da un’altra uscita con una nuova fiamma, Dino si ritirò nella sua casa nella brughiera desolata. La notte era appena rischiarata da uno spicchio di luna e una luce blu punteggiava le macchie d’erica. Lui si preparò per andare a letto e salì i primi gradini della scala, quando notò delle impronte di fango sugli scalini. Il terrore lo colpì alla nuca come un maglio. Il dolore al petto quasi gli fece girare la testa. Nonostante questo, riuscì ad aggrapparsi alla propria ragione e continuò a salire. In cima al ballatoio s’armò con quello che riuscì a trovare: una riproduzione di ferro della Tour Eiffel. Con quell’arma rudimentale, seguì le impronte fino alla soglia della sua stanza. Il chiarore giallastro dell’abatjour passava da sotto il filo della porta. Dino spalancò l’uscio. Nella penombra della stanza, seduto sul dondolo di legno accanto al letto, la sagoma pietrificata dello zio Quintino lo scrutava con quel suo sorriso pietrificato. Per Dino lo spavento fu quasi fatale. Rinvenne alcune ore dopo e a fatica riuscì a ricomporsi. Non avvisò nessuno, né la polizia (a cosa sarebbe servito se non a farsi dare del pazzo?), né i medici (non voleva farsi ricoverare in una clinica psichiatrica). Da solo, nelle ore più luminose della giornata, ripulì le impronte di fango e notò la scomparsa della riproduzione della torre Eiffel. Quelli erano i fatti.
Fuori, tra il folto di ramaglie e spine, nell’esiguo spazio di luce lasciato dalla nebbia fitta, scorse un’ombra che passeggiava nel giardino. Essa, quasi percependo lo sguardo del mio amico, si fermò per volgere il capo verso la finestra e mostrare un freddo sorriso di marmo. Il viso dell’intruso era remoto e pallido. Il freddo sorriso, quasi scolpito, brillava come un sudario lanuginoso. A quel punto Dino provò un dolore incontrollabile al petto e s’accasciò a terra. Quando rinvenne, parecchio tempo dopo, era già mattino. Tuttavia il fresco splendore del sole non riuscì a cancellare il ricordo orribile di quell’apparizione inconfondibile: l’uomo che passeggiava nel giardino era suo zio Quintino! Ricordo perfettamente i lineamenti pallidi e sbiancati del mio amico mentre ci riferiva di quell’incontro impossibile. Carlo, suo cugino, che tutto era fuorché un fautore del soprannaturale, si mostrò molto colpito da quella rivelazione e anch’io ebbi dei dubbi sulla salute del Barbero. Dino cercava di nasconderci l’orrore nel quale sentiva precipitare la sua vita, purtuttavia non era difficile scorgere nei suoi lineamenti contratti le stigmate di ciò che raccontava. Purtroppo per lui il racconto non era ancora finito. Il mattino in cui rinvenne, se ne accorse in seguito, il romanzo giallo che stava leggendo era sparito. Cercò di convincersi che s’era trattato di un incubo a occhi aperti, forse s’era addormentato mentre leggeva e aveva sognato tutto. Eppure il libro era svanito. Allora si ricordò del portasigarette d’argento e corse al vestibolo: un’altra pozza fangosa imbrattava l’ingresso principale! Questa volta per il mio amico fu più difficile riprendere il tranquillo tran tran quotidiano. Lo svenimento lo costrinse a rallentare i suoi ritmi di studio e a sottoporsi ad esami clinici dagli esiti infelici. Da tempo, infatti, Dino soffriva di una grave malattia al cuore, da cui solo i farmaci e gli effetti di una vita salubre avevano allontanato i pericoli. Nonostante tutto, riuscì a dimenticarsi dell’episodio. Non appena si sentì meglio si rituffò nei suoi impegni e cominciò la stesura del nuovo saggio accademico. L’entusiasmo per il lavoro lo portò a progettare una nuova trasmissione da proporre ai dirigenti della RAI di Torino. Insomma, nel giro di una settimana, il mio amico era tornato dinamico e allegro come sempre. Durò poco. Di ritorno da un’altra uscita con una nuova fiamma, Dino si ritirò nella sua casa nella brughiera desolata. La notte era appena rischiarata da uno spicchio di luna e una luce blu punteggiava le macchie d’erica. Lui si preparò per andare a letto e salì i primi gradini della scala, quando notò delle impronte di fango sugli scalini. Il terrore lo colpì alla nuca come un maglio. Il dolore al petto quasi gli fece girare la testa. Nonostante questo, riuscì ad aggrapparsi alla propria ragione e continuò a salire. In cima al ballatoio s’armò con quello che riuscì a trovare: una riproduzione di ferro della Tour Eiffel. Con quell’arma rudimentale, seguì le impronte fino alla soglia della sua stanza. Il chiarore giallastro dell’abatjour passava da sotto il filo della porta. Dino spalancò l’uscio. Nella penombra della stanza, seduto sul dondolo di legno accanto al letto, la sagoma pietrificata dello zio Quintino lo scrutava con quel suo sorriso pietrificato. Per Dino lo spavento fu quasi fatale. Rinvenne alcune ore dopo e a fatica riuscì a ricomporsi. Non avvisò nessuno, né la polizia (a cosa sarebbe servito se non a farsi dare del pazzo?), né i medici (non voleva farsi ricoverare in una clinica psichiatrica). Da solo, nelle ore più luminose della giornata, ripulì le impronte di fango e notò la scomparsa della riproduzione della torre Eiffel. Quelli erano i fatti.  A quel punto Dino si affidava a me e a Carlo. Ci aveva convocati a Lucedio per uno scopo preciso, l’unico ormai in grado di alleggerirgli l’anima: riesumare la salma dello zio! Ancora stupefatti da quel racconto, e impensieriti dallo stato di prostrazione in cui versava quella cara persona, non riuscimmo a trovare argomenti per opporci a quella follia. Carlo provò ad appigliarsi ad ogni ragionamento. Possibile che un morto potesse uscire dal suo sepolcro e passeggiare tranquillo nella baraggia? E per quale motivo avrebbe dovuto recarsi nella casa del nipote prediletto e rubargli un portasigarette, un libro e un oggetto di ferro? Per quale motivo avrebbe dovuto spaventarlo a morte? Ci sembrava tutto così assurdo e irreale e solo la paura evidente di Dino conferiva una concretezza a tutta quella storia. La salma di Quintino era stata tumulata a poche centinaia di metri dalla casa, nella cripta della famiglia Barbero, situata nel piccolo cimitero privato di Lucedio. Praticamente la cappella funeraria dei Barbero era l’unica in tutto il camposanto. Dino, abbandonando la consueta pacatezza, quasi ci pregò nell’aiutarlo in quell’ingrato compito, arrivando persino a proporci una ricompensa in denaro. Quasi sdegnati, pur di calmarlo ed evitargli altri colpi apoplettici, gli dovemmo promettere d’assisterlo in quel compito ingrato. Fu così che, abbandonando lo spazio confortevole del salotto, uscimmo nella notte, a respirare il freddo pungente. I primi petali di neve cominciarono a cadere. Dino e Carlo andarono alla rimessa dietro la villa e tornarono con dei picconi e una sbarra di ferro. Nel vedere quegli arnesi, rabbrividii. Ci incamminammo sotto il turbine dei fiocchi sempre più grossi. Nessuna luce rischiarava l’orizzonte, ad eccezione delle luci intermittenti sulle torri della centrale di Crescentino. L’intera pianura pareva abbandonata e spettrale, rifugio perfetto per qualche demonio dal cuore gonfio di odio. Meno di cinque minuti dopo arrivammo al vecchio cimitero di campagna. Nel varcare il vecchio cancello di ferro battuto e le colonnine di arenaria chiazzate di licheni, sentimmo subito il peso della notte. La paura e le superstizioni correvano per quei villaggi stretti, in quei luoghi deserti, visitati raramente da passanti distratti o ragazzotti in cerca di qualche forte emozione. L’interno quadrangolare del camposanto era occupato dai rovi. Con l’aiuto di una torcia elettrica, ci inoltrammo nella vegetazione, resa ancor più scivolosa dai fiocchi di neve. Un piccolo sentiero ci guidò verso la cappella funeraria dei Barbero. Entrammo in un vano di pietra. Lungo uno dei muri scorgemmo le lastre funerarie incastonate nei muri, istoriate da una serie di iscrizioni corrose dall’umidità. Sull’altro muro, una finestra ornata da alcuni vetri colorati. Speravo ancora si potesse evitare quella follia, ma Dino era concentrato nel suo delirio e osservava con occhi febbricitanti la lapide funeraria dello zio, quasi cercasse dei segni di forzatura o scasso. Anche Carlo controllò a lungo con la torcia. Non c’erano segni di manomissione. La lapide sembrava intatta. Li vidi mentre armeggiavano con la sbarra e facevano saltare la lastra. La adagiarono a terra, poi illuminarono il vano che conteneva la bara di legno scuro. Non senza timori, li aiutai nell’estrarla dal loculo. Alla luce della torcia ne esaminammo i bordi e ancora non trovammo alcun segno di manomissione. Nessuno l’aveva aperta e tantomeno aveva potuto uscirne! Cercai ancora di far ragionare il mio amico – appellandomi all’immagine che avevo di lui, mentre, abbagliato dalle luci degli studi televisivi, ci intratteneva spiegando con ironia i fatti insoliti del medioevo – però i suoi occhi annebbiati mi scoraggiarono dal continuare e rimasi spettatore inerte di quella macabra esumazione. Ci coprimmo il naso e la bocca con dei fazzoletti di stoffa, poi li osservai mentre armeggiavano coi picconi lungo i bordi della bara. Da fuori, scorgevo la neve cadere dal nulla e cancellare a poco a poco i cumuli di rovi. La punta delle piccozze scintillò sotto il fascio tenue di luce e raschiò sul legno. Lentamente la sepoltura cedette e dei gas invisibili si liberarono dall’interno, ammorbando l’ambiente d’una puzza insopportabile. Dovemmo fermarci per alcuni minuti e tornare fuori a respirare il balsamo freddo della notte. Dopo, Carlo e Dino scoperchiarono definitivamente la bara.
A quel punto Dino si affidava a me e a Carlo. Ci aveva convocati a Lucedio per uno scopo preciso, l’unico ormai in grado di alleggerirgli l’anima: riesumare la salma dello zio! Ancora stupefatti da quel racconto, e impensieriti dallo stato di prostrazione in cui versava quella cara persona, non riuscimmo a trovare argomenti per opporci a quella follia. Carlo provò ad appigliarsi ad ogni ragionamento. Possibile che un morto potesse uscire dal suo sepolcro e passeggiare tranquillo nella baraggia? E per quale motivo avrebbe dovuto recarsi nella casa del nipote prediletto e rubargli un portasigarette, un libro e un oggetto di ferro? Per quale motivo avrebbe dovuto spaventarlo a morte? Ci sembrava tutto così assurdo e irreale e solo la paura evidente di Dino conferiva una concretezza a tutta quella storia. La salma di Quintino era stata tumulata a poche centinaia di metri dalla casa, nella cripta della famiglia Barbero, situata nel piccolo cimitero privato di Lucedio. Praticamente la cappella funeraria dei Barbero era l’unica in tutto il camposanto. Dino, abbandonando la consueta pacatezza, quasi ci pregò nell’aiutarlo in quell’ingrato compito, arrivando persino a proporci una ricompensa in denaro. Quasi sdegnati, pur di calmarlo ed evitargli altri colpi apoplettici, gli dovemmo promettere d’assisterlo in quel compito ingrato. Fu così che, abbandonando lo spazio confortevole del salotto, uscimmo nella notte, a respirare il freddo pungente. I primi petali di neve cominciarono a cadere. Dino e Carlo andarono alla rimessa dietro la villa e tornarono con dei picconi e una sbarra di ferro. Nel vedere quegli arnesi, rabbrividii. Ci incamminammo sotto il turbine dei fiocchi sempre più grossi. Nessuna luce rischiarava l’orizzonte, ad eccezione delle luci intermittenti sulle torri della centrale di Crescentino. L’intera pianura pareva abbandonata e spettrale, rifugio perfetto per qualche demonio dal cuore gonfio di odio. Meno di cinque minuti dopo arrivammo al vecchio cimitero di campagna. Nel varcare il vecchio cancello di ferro battuto e le colonnine di arenaria chiazzate di licheni, sentimmo subito il peso della notte. La paura e le superstizioni correvano per quei villaggi stretti, in quei luoghi deserti, visitati raramente da passanti distratti o ragazzotti in cerca di qualche forte emozione. L’interno quadrangolare del camposanto era occupato dai rovi. Con l’aiuto di una torcia elettrica, ci inoltrammo nella vegetazione, resa ancor più scivolosa dai fiocchi di neve. Un piccolo sentiero ci guidò verso la cappella funeraria dei Barbero. Entrammo in un vano di pietra. Lungo uno dei muri scorgemmo le lastre funerarie incastonate nei muri, istoriate da una serie di iscrizioni corrose dall’umidità. Sull’altro muro, una finestra ornata da alcuni vetri colorati. Speravo ancora si potesse evitare quella follia, ma Dino era concentrato nel suo delirio e osservava con occhi febbricitanti la lapide funeraria dello zio, quasi cercasse dei segni di forzatura o scasso. Anche Carlo controllò a lungo con la torcia. Non c’erano segni di manomissione. La lapide sembrava intatta. Li vidi mentre armeggiavano con la sbarra e facevano saltare la lastra. La adagiarono a terra, poi illuminarono il vano che conteneva la bara di legno scuro. Non senza timori, li aiutai nell’estrarla dal loculo. Alla luce della torcia ne esaminammo i bordi e ancora non trovammo alcun segno di manomissione. Nessuno l’aveva aperta e tantomeno aveva potuto uscirne! Cercai ancora di far ragionare il mio amico – appellandomi all’immagine che avevo di lui, mentre, abbagliato dalle luci degli studi televisivi, ci intratteneva spiegando con ironia i fatti insoliti del medioevo – però i suoi occhi annebbiati mi scoraggiarono dal continuare e rimasi spettatore inerte di quella macabra esumazione. Ci coprimmo il naso e la bocca con dei fazzoletti di stoffa, poi li osservai mentre armeggiavano coi picconi lungo i bordi della bara. Da fuori, scorgevo la neve cadere dal nulla e cancellare a poco a poco i cumuli di rovi. La punta delle piccozze scintillò sotto il fascio tenue di luce e raschiò sul legno. Lentamente la sepoltura cedette e dei gas invisibili si liberarono dall’interno, ammorbando l’ambiente d’una puzza insopportabile. Dovemmo fermarci per alcuni minuti e tornare fuori a respirare il balsamo freddo della notte. Dopo, Carlo e Dino scoperchiarono definitivamente la bara.  A quel punto tutto precipitò, rendendo i miei stessi ricordi, per il bene della mia mente, fluttuanti e imprecisi. Nella relazione che stavo facendo al mio ex professore, Guglielmo Fragonard, cercai di alleggerire con le parole la valle d’inquietudine che si liberò dal sepolcro. Nessuno di noi parlò più e quando la torcia di Carlo illuminò quel che rimaneva dei poveri resti dello zio, fu subito chiaro che quella figura mummificata difficilmente avrebbe potuto passeggiare per la selva. Tuttavia un luccicare malefico attirò la nostra attenzione e quella di Dino in particolare: tre piccoli oggetti spuntavano da sotto il sudario. Come mesti fantasmi del passato, riconoscemmo il portasigarette d’argento, la copia sgualcita del romanzo e la riproduzione della torre Eiffel!
A quel punto tutto precipitò, rendendo i miei stessi ricordi, per il bene della mia mente, fluttuanti e imprecisi. Nella relazione che stavo facendo al mio ex professore, Guglielmo Fragonard, cercai di alleggerire con le parole la valle d’inquietudine che si liberò dal sepolcro. Nessuno di noi parlò più e quando la torcia di Carlo illuminò quel che rimaneva dei poveri resti dello zio, fu subito chiaro che quella figura mummificata difficilmente avrebbe potuto passeggiare per la selva. Tuttavia un luccicare malefico attirò la nostra attenzione e quella di Dino in particolare: tre piccoli oggetti spuntavano da sotto il sudario. Come mesti fantasmi del passato, riconoscemmo il portasigarette d’argento, la copia sgualcita del romanzo e la riproduzione della torre Eiffel!
Non so quanto tempo passò prima che sentimmo un orrido sghignazzo. Vidi Carlo volgersi verso il cugino e illuminargli il viso, sconvolto da una smorfia d’insuperabile follia. Ogni tentativo di aiuto fu vano. Dino iniziò a tossire, portandosi le mani al petto, poi la smorfia si tramutò in un rantolo e per lui fu finita.
Ciò che seguì, mentre la neve continuava a cadere silenziosa e montagnole di bianco scintillavano macabre come pallide tombe, fu irreale e inevitabile. Meno di un’ora dopo il cimitero era illuminato dai lampeggianti della polizia. Arrivò inutilmente un’autombulanza. Ormai Dino era morto, un attacco di cuore fulminante. Provarono per mezz’ora a rianimarlo, infine lo lasciarono a terra, coperto da un lenzuolo, accanto alla bara profanata dello zio. I poliziotti ascoltarono le deposizioni mie e di Carlo, e sembrarono sul punto di arrestarci. Poi arrivò un altro medico legale per controllare l’interno della bara. In seguito fummo condotti all’esterno, dove ci aspettava l’ispettore Lang. Ripetemmo il racconto di quell’orribile notte, rassegnati a passare il resto della notte in Questura. Lang era lontano dagli stereotipi del poliziotto irruento e ci ascoltò paziente, mentre ripetevamo quel che ci aveva spinto a violare la tomba. Non fece commenti ironici (ancora non sapevamo che a casa di Dino, sullo scrittoio, avrebbero trovato una lettera nella quale raccontava per filo e per segno delle apparizioni notturne) e non ci interruppe. Più tardi, il medico legale avrebbe confermato la morte istantanea di Dino. A quel punto, quasi congelati, coi visi blu, fummo accompagnati in città, per firmare i verbali. Durante il viaggio, Lang ci consolò, dicendo che difficilmente un magistrato avrebbe dato corso a una denuncia per vilipendio di cadavere. In fondo, lo avevamo fatto per aiutare un amico sull’orlo della follia.
Lo shock per la notte appena passata non era ancora finito e mi sentivo la testa pesante.
Fragonard mi osservava da dietro il fumo dell’ennesima sigaretta e sembrava compiaciuto da quel che gli avevo raccontato.
“Mi ascolti attentamente, la prego”, disse allungando un cioccolatino al gatto Belfagor.
“Quando accantoniamo il soprannaturale, dobbiamo ammettere che tutto è reale, e anche qui non vedo perché dovremmo fare un’eccezione. Non le pare?”
Un sorriso largo e rassicurante illuminò il volto del mio ex-maestro, facendomi sentire ancora una volta sui banchi di scuola del liceo. In lui c’era un modo di fare così rassicurante, da allontanare qualunque ombra di superstizione. Guglielmo Fragonard era un uomo che aveva dedicato tutta la sua vita all’esercizio della sapienza, avendo cura soltanto di aggiungere ogni epoca alla propria, coltivando la più stretta intimità con Socrate, Epicuro, Pitagora e le più disparate menti del passato. Mille volte, ascoltando anche un pezzetto d’un suo ragionamento, m’era parso di essere restituito dalle tenebre alla luce. E così accadeva anche in quel salottino confortevole, appena rischiarato dalle luci delicate delle abatjour. Le mie paure della notte, l’angoscia per la dipartita di Dino Barbero, l’inchiesta aperta dalla polizia e quella tomba aperta, quel corpo appena intravisto, putrefatto oltre ogni dubbio. Quegli oggetti deposti all’interno. Il portasigarette d’argento. La Tour Eiffel. Com’era stato possibile? Davvero i morti potevano alzarsi dai sepolcri e camminare indisturbati nella brughiera di Lucedio? La mia fragilità d’animo non riusciva a raccapezzarsi, a trovare una via d’uscita dal labirinto. Fragonard accarezzò Belfagor, poi fece segno d’attendere un momentino. Lo sentii andare nell’altro salotto, a piegare delle lenzuola con la moglie ciarliera. Quando tornò aveva tra le labbra un’altra sigaretta. La fumò per metà in silenzio, assaporando qualcosa che solo lui capiva. “Dicevamo. Il soprannaturale. Con che ironia ne parlava Leopardi, citando un’avventura capitata all’amico Ranieri, la fantasima. Ricorda? Non se ne abbia a male mio caro. Pochi avrebbero mantenuto i nervi saldi in una situazione come quella da lei vissuta. Una notte al gelo, sotto una tempesta di neve, con un fantasma briccone in vena di scherzi. No, non mi sto prendendo gioco di lei, conosce l’affetto e la stima che ci legano. Tuttavia provo a mettermi nei suoi panni e ragionare. Sbaglierò, ma non ho mai sentito di un morto che non voleva restarsene nel suo loculo. E quindi, mi dirà: com’è possibile che le cose siano andate come sono andate? Ebbene, non mi prenda per un fanfarone o un superbo, ma credo di poterle fornire un’altra ricostruzione, assai più plausibile. Lascerò alla polizia le noie del resto. Conosco per altre faccende l’ispettore Lang. E’ uomo preparato e mite, capirà e agirà”. Lo fissavo senza parole, come se quel che diceva potesse ricomporre l’ordine del mondo. “Dunque, mi ha detto che il povero Barbero si sentiva perseguitato dal fantasma dello zio. Questo fantasma avrebbe sottratto tre oggetti, poi ritrovati nella bara sigillata. L’inghippo direi che è tutto qui. Perché vede, il povero Dino non è morto per un semplice infarto provocato dalla paura, bensì è stato ucciso. E in un modo semplicissimo. Ora io sono partito da questa semplice osservazione: se davvero i morti non possono tornare dall’aldilà, allora come sono finiti quei tre oggetti nella cassa? E come mai Dino ha riconosciuto la figura dello zio per ben due volte? Andrò a braccio, ma sono sicuro che non le sarà difficile seguirmi. Dino era malato di cuore. Lo ha detto lei stesso. Inoltre aveva ereditato un’enorme fortuna. Le due cose potevano far gola a qualcuno, e non mi riferisco al mondo ultraterreno, dove l’accumulo di fortune servirebbe a poco. Se il sudario non ha tasche, allora chi ne ha? Lo vedremo tra poco. Torniamo alla salute cagionevole di Dino e al patrimonio. Come fare per risolvere la prima e avere la seconda? L’idea di un fantasma era l’ideale. Pensi a quella bara sigillata. Come erano potuti finirci dentro il portasigarette, il romanzo e la riproduzione della torre?  Pensandoci si tratta di tre oggetti comuni, facilmente duplicabili. E se, e qui avanzo la prima ipotesi, la persona interessata alla dipartita di Dino, li avesse sostituiti anzitempo, prima cioè di inscenare l’arcano. Sostituiti con degli oggetti identici, fatti poi sparire a loro volta. Il portasigarette mentre Dino era sotto la doccia. Il libro quando era svenuto, quasi morto per lo spavento di vedere lo zio aggirarsi nel giardino. L’ultima, la torre Eiffel, svanita nel nulla al secondo, quasi fatale, svenimento. Per poco l’assassino, se ce n’è uno, e vedrà che c’è, avrebbe potuto risparmiarsi la commedia dell’esumazione. Comunque gli oggetti sottratti durante le apparizioni dello “spettro” erano già delle copie: quelli originali si trovavano da tempo all’interno della bara dello zio. Saprà che anch’io conoscevo il professor Barbero: durante uno dei nostri ultimi incontri mi accennò qualcosa. Quando lo zio era morto lui si trovava altrove, per lavoro. Si occupò di tutto il cugino, quel Carlo Decovic, altro protagonista nella notte degli orrori. Ebbene, chi meglio di lui avrebbe potuto mettere i manufatti, precedentemente sottratti da una casa di cui facilmente poteva avere i duplicati delle chiavi, all’interno del sepolcro? Sapeva della malattia del cugino, ultimo ostacolo per ereditare una fortuna spaventosa. Lo zio Quintino, morto a sua volta per una “strana” gastrite, non gli aveva lasciato nulla, preferendogli il nipote studioso. Non mi guardi così. So già cosa vorrebbe obiettare. Il Decovic è un artista di successo, uno scultore di fama. Lo era. Da anni ha dilapidato il suo patrimonio, conducendo una bella vita fatta di macchine, donne e gioco d’azzardo. Non è mistero in città che sia stato costretto a vendere buona parte delle sue proprietà, per far fronte a debiti ingenti. Come vede avrebbe avuto il movente per accelerare la morte del caro cugino. Uno spavento più forte degli altri e nessuno si sarebbe fatto troppe domande. Vuol sapere dello spettro? Decovic è uno scultore. Tra i suoi primi lavori, ne comprai alcuni, vi erano delle meravigliose maschere mortuarie in cera. Come i keroplàstes dell’antichità greca, egli ha fatto un calco dello zio defunto, approfittando della salma quando ne ha gestito l’inumazione. Eccolo allora aggirarsi di notte attorno alla casa del Barbero, mascherato con un ghigno realistico e fisso, atteggiato in un eterno sorriso funebre. Dino quasi ne moriva di paura e ne ho pena per quel che deve aver provato. La sera in cui si è rivolto a voi, ormai il suo povero cuore era già al limite e l’assassino ben sapeva che l’apertura della cassa sarebbe stata letale. E così è stato”. Fragonard spazzolò della cenere inesistente dal camicione e mi offrì dello sherry. Fuori, la sera buia premeva sulla portafinestra del salottino. La neve aveva ricominciato a cadere fitta. Fragonard, con una notevole vena di galanteria vecchio stampo, versò lo sherry nel mio bicchiere, lasciandomi il tempo per assorbire quel che aveva detto. Tuttavia la stanchezza e la confusione mi impedirono di opporre alcuna resistenza. Solo mi sembrava impossibile credere che una persona squisita come Decovic avesse potuto pianificare una cosa tanto assurda e malvagia. Si poteva uccidere per denaro, certo, ma si poteva rimanere così cinici e indifferenti alla sofferenza di un altro essere umano? Ricordavo le stille di sudore e le mani tremanti di Dino mentre ci raccontava dei suoi incubi e di come Carlo lo avesse consolato affettuosamente. Fragonard parve intuire quei miei pensieri e allargò il petto in un profondo respiro. “Le prove, amico mio. Sono le prove quelle che vuole. Eccole. Anzitutto non sarà difficile per l’ispettore Lang verificare tutto quel che le ho detto. Decovic versava in condizioni finanziarie disastrose. Fu lui ad occuparsi della sepoltura dello zio. Credo che abbia fatto personalmente una copia del portasigarette e della torre. Difficilmente se ne ricaverà qualcosa. Per la maschera funeraria credo saremo più fortunati. Voi non avete prestato, comprensibilmente, molta attenzione al corpo di Quintino Barbero, cosa che invece faranno i periti della scientifica, rintracciando anche minuscole tracce di cera d’api sul bavero del colletto o tra i capelli del morto. A quel punto sarà uno scherzo confrontarla con quella utilizzata dal Decovic nel suo atelier. Poi…”. Ascoltai ancora per alcuni minuti il professore mentre sbriciolava il mondo notturno nel quale avevo passato le ultime 24 ore e impilando una serie di indizi a cui non avrei mai pensato, infine, senza accorgermene, ero sulla soglia a infilarmi le scarpe, pronto ad affrontare i soffici fiocchi che si ammonticchiavano sul mondo. Fragonard aveva premura di telefonare all’ispettore Lang e imbeccarlo.
Pensandoci si tratta di tre oggetti comuni, facilmente duplicabili. E se, e qui avanzo la prima ipotesi, la persona interessata alla dipartita di Dino, li avesse sostituiti anzitempo, prima cioè di inscenare l’arcano. Sostituiti con degli oggetti identici, fatti poi sparire a loro volta. Il portasigarette mentre Dino era sotto la doccia. Il libro quando era svenuto, quasi morto per lo spavento di vedere lo zio aggirarsi nel giardino. L’ultima, la torre Eiffel, svanita nel nulla al secondo, quasi fatale, svenimento. Per poco l’assassino, se ce n’è uno, e vedrà che c’è, avrebbe potuto risparmiarsi la commedia dell’esumazione. Comunque gli oggetti sottratti durante le apparizioni dello “spettro” erano già delle copie: quelli originali si trovavano da tempo all’interno della bara dello zio. Saprà che anch’io conoscevo il professor Barbero: durante uno dei nostri ultimi incontri mi accennò qualcosa. Quando lo zio era morto lui si trovava altrove, per lavoro. Si occupò di tutto il cugino, quel Carlo Decovic, altro protagonista nella notte degli orrori. Ebbene, chi meglio di lui avrebbe potuto mettere i manufatti, precedentemente sottratti da una casa di cui facilmente poteva avere i duplicati delle chiavi, all’interno del sepolcro? Sapeva della malattia del cugino, ultimo ostacolo per ereditare una fortuna spaventosa. Lo zio Quintino, morto a sua volta per una “strana” gastrite, non gli aveva lasciato nulla, preferendogli il nipote studioso. Non mi guardi così. So già cosa vorrebbe obiettare. Il Decovic è un artista di successo, uno scultore di fama. Lo era. Da anni ha dilapidato il suo patrimonio, conducendo una bella vita fatta di macchine, donne e gioco d’azzardo. Non è mistero in città che sia stato costretto a vendere buona parte delle sue proprietà, per far fronte a debiti ingenti. Come vede avrebbe avuto il movente per accelerare la morte del caro cugino. Uno spavento più forte degli altri e nessuno si sarebbe fatto troppe domande. Vuol sapere dello spettro? Decovic è uno scultore. Tra i suoi primi lavori, ne comprai alcuni, vi erano delle meravigliose maschere mortuarie in cera. Come i keroplàstes dell’antichità greca, egli ha fatto un calco dello zio defunto, approfittando della salma quando ne ha gestito l’inumazione. Eccolo allora aggirarsi di notte attorno alla casa del Barbero, mascherato con un ghigno realistico e fisso, atteggiato in un eterno sorriso funebre. Dino quasi ne moriva di paura e ne ho pena per quel che deve aver provato. La sera in cui si è rivolto a voi, ormai il suo povero cuore era già al limite e l’assassino ben sapeva che l’apertura della cassa sarebbe stata letale. E così è stato”. Fragonard spazzolò della cenere inesistente dal camicione e mi offrì dello sherry. Fuori, la sera buia premeva sulla portafinestra del salottino. La neve aveva ricominciato a cadere fitta. Fragonard, con una notevole vena di galanteria vecchio stampo, versò lo sherry nel mio bicchiere, lasciandomi il tempo per assorbire quel che aveva detto. Tuttavia la stanchezza e la confusione mi impedirono di opporre alcuna resistenza. Solo mi sembrava impossibile credere che una persona squisita come Decovic avesse potuto pianificare una cosa tanto assurda e malvagia. Si poteva uccidere per denaro, certo, ma si poteva rimanere così cinici e indifferenti alla sofferenza di un altro essere umano? Ricordavo le stille di sudore e le mani tremanti di Dino mentre ci raccontava dei suoi incubi e di come Carlo lo avesse consolato affettuosamente. Fragonard parve intuire quei miei pensieri e allargò il petto in un profondo respiro. “Le prove, amico mio. Sono le prove quelle che vuole. Eccole. Anzitutto non sarà difficile per l’ispettore Lang verificare tutto quel che le ho detto. Decovic versava in condizioni finanziarie disastrose. Fu lui ad occuparsi della sepoltura dello zio. Credo che abbia fatto personalmente una copia del portasigarette e della torre. Difficilmente se ne ricaverà qualcosa. Per la maschera funeraria credo saremo più fortunati. Voi non avete prestato, comprensibilmente, molta attenzione al corpo di Quintino Barbero, cosa che invece faranno i periti della scientifica, rintracciando anche minuscole tracce di cera d’api sul bavero del colletto o tra i capelli del morto. A quel punto sarà uno scherzo confrontarla con quella utilizzata dal Decovic nel suo atelier. Poi…”. Ascoltai ancora per alcuni minuti il professore mentre sbriciolava il mondo notturno nel quale avevo passato le ultime 24 ore e impilando una serie di indizi a cui non avrei mai pensato, infine, senza accorgermene, ero sulla soglia a infilarmi le scarpe, pronto ad affrontare i soffici fiocchi che si ammonticchiavano sul mondo. Fragonard aveva premura di telefonare all’ispettore Lang e imbeccarlo.  Nei giorni successivi avrei avuto conferma di tutto. Decovic fu arrestato, e, alla fine, confessò ogni cosa. Addirittura era stato così sicuro da conservare in casa la copia del giallo che aveva rubato a Dino e che il mio amico aveva avuto cura di autografare nella prima pagina. Il caso fece un certo scalpore e se ne parlò a lungo sulla stampa locale. Il mio nome, forse per le premure dell’ispettore, non venne quasi fuori e così quello di Fragonard. Alla fine, tornando a quella sera del 24 dicembre, mentre lasciavo l’appartamento di Fragonard e la neve cadeva quieta, velando le ordinate casette e i loro quieti giardini con luminarie intermittenti, ripensavo più di tutto all’ultima cosa che il professore mi aveva detto proprio sull’uscio, quasi come un epitaffio. Parlando di quella storia, non aveva potuto fare a meno di sottolineare come l’uomo fosse un animale dall’istinto predatorio innato, un istinto che non si sarebbe fermato davanti a nessuno. Purtuttavia esisteva qualcosa di ancor più pericoloso e malefico, un idolo astratto creato dall’immaginazione dell’uomo e a cui quest’ultimo aveva finito per sottomettersi: il denaro!
Nei giorni successivi avrei avuto conferma di tutto. Decovic fu arrestato, e, alla fine, confessò ogni cosa. Addirittura era stato così sicuro da conservare in casa la copia del giallo che aveva rubato a Dino e che il mio amico aveva avuto cura di autografare nella prima pagina. Il caso fece un certo scalpore e se ne parlò a lungo sulla stampa locale. Il mio nome, forse per le premure dell’ispettore, non venne quasi fuori e così quello di Fragonard. Alla fine, tornando a quella sera del 24 dicembre, mentre lasciavo l’appartamento di Fragonard e la neve cadeva quieta, velando le ordinate casette e i loro quieti giardini con luminarie intermittenti, ripensavo più di tutto all’ultima cosa che il professore mi aveva detto proprio sull’uscio, quasi come un epitaffio. Parlando di quella storia, non aveva potuto fare a meno di sottolineare come l’uomo fosse un animale dall’istinto predatorio innato, un istinto che non si sarebbe fermato davanti a nessuno. Purtuttavia esisteva qualcosa di ancor più pericoloso e malefico, un idolo astratto creato dall’immaginazione dell’uomo e a cui quest’ultimo aveva finito per sottomettersi: il denaro!
































