 IL REVERENDO CHE SCRIVEVA RACCONTI DEL TERRORE
IL REVERENDO CHE SCRIVEVA RACCONTI DEL TERRORE
(Introduzione a Il culto del teschio di Henry S. Whitehead, La Ponga 2016)
Sin dal tempo dei Latini sappiamo che Carmina non dant panem, cioè con la poesia e per estensione con la scrittura non si campa, e quindi gli autori, salvo eccezioni (per fortuna o per particolare abilità), fanno generalmente un altro lavoro. Se questo lavoro è in genere collegato comunque con la cultura, trattandosi di giornalisti, insegnanti, traduttori, redattori di case editrici e simili, non sono pochi i casi in cui la professione pour gagner è di tutt’altro genere, quasi opposto, come ingegneri o medici. Ma colpisce decisamente il fatto che Henry St. Clair Whitehead, passato alla storia come narratore horror, fosse un ecclesiastico.
Nato nel 1882 nel New Jersey, Whitehead studiò teologia nel Connecticut e fu ordinato diacono della Chiesa Episcopale nel 1912. Dal 1921 al 1929 esercitò il suo ufficio nelle Isole Vergini, e fu in questo periodo che, venuto in contatto con la cultura e il folklore locale, iniziò a scrivere riversando nelle sue opere quegli elementi di soprannaturale dei quali aveva una frequentazione quasi quotidiana. In realtà i suoi primissimi racconti pubblicati nel 1923 non appartenevano al genere gotico, ma già a partire dal terzo, “La porta” del 1924, iniziò una proficua collaborazione con la più famosa rivista di narrativa fantastica-orrorifica, Weird Tales (titolo letteralmente intraducibile in italiano, ma che si potrebbe rendere bene con “racconti perturbanti”) dove apparve la maggior parte delle sue storie, più di venti fino al 1933 (Whitehead era morto l’anno prima, ma aveva già spedito alcune sue opere) mentre alcuni uscirono su altre riviste, specialmente su Strange Tales. Qualche altro racconto fu pubblicato postumo nelle raccolte Jumbee and Other Uncanny Tales del 1944 e West India Lights del 1946, e altri ne sono stati individuati più recentemente. Ci riferiamo sempre ai racconti fantastici, perché il Nostro scrisse anche avventura, western, mainstream (cioè narrativa corrente) e gialli, collaborando a riviste ben note quali Adventure e la mitica Black Mask.
Grazie alla collaborazione con Weird Tales Whitehead venne in contatto con H. P. Lovecraft, che già da qualche anno era considerato l’autore di punta della rivista, il quale lo apprezzava molto e lo giudicava uno dei migliori collaboratori. Infatti nel 1933 ne scrisse – sempre sulla stessa – il necrologio, in cui tra l’altro sosteneva che
è per un genere di narrativa sovrannaturale di tono insinuante, realistico e sobriamente efficace che lo ricorderanno i lettori di questa rivista, in cui sotto stati pubblicati venticinque dei suoi più bei racconti. Profondamente versato nel cupo folklore delle Indie Occidentali, e delle Isole Vergini in particolare, egli seppe cogliere lo spirito più autentico delle superstizioni del luogo, infondendolo in racconti la cui accurata ambientazione regionale suscita una sbalorditiva illusione di autenticità. Le sue storie jumbee – popolarmente chiamate così a causa del frequente ricorso a una tipica credenza delle Isole Vergini – costituiscono un contributo durevole alla letteratura spettrale, mentre il suo frequente personaggio e narratore, Gerald Canevin (proiezione della sua personalità), sarà sempre ricordato come una figura affascinante e spontanea.
 Dopo aver corrisposto per qualche tempo, scambiandosi e discutendo le rispettive opere, i due si erano incontrati di persona nel 1931 quando Whitehead ospitò per qualche tempo il Visionario di Providence nella sua casa di Dunedin in Florida. Da questo soggiorno sarebbe nato un racconto, invero non eccezionale: La trappola, pubblicato nel 1931 su Strange Tales.
Dopo aver corrisposto per qualche tempo, scambiandosi e discutendo le rispettive opere, i due si erano incontrati di persona nel 1931 quando Whitehead ospitò per qualche tempo il Visionario di Providence nella sua casa di Dunedin in Florida. Da questo soggiorno sarebbe nato un racconto, invero non eccezionale: La trappola, pubblicato nel 1931 su Strange Tales.
Alcune cose che scrive Lovecraft nella sua commemorazione vanno esplicitate. Intanto il termine jumbee; versione anglofona del franco-haitiano zombie, anche se adesso è quest’ultimo a essere stato adottato dalla lingua inglese e a essersi diffuso in tutte le altre lingue. Con jumbee/zombie non si intendeva solo, come oggi, un cadavere riportato a una parvenza di vita, a volte sanguinario e cannibale, ma tutto l’insieme delle credenze della popolazione caraibica legate al voodoo: maledizioni e fatture, possessioni e reincarnazioni, stregonerie et similia. Di tutto questo Whitehead ebbe conoscenza diretta, scrisse anche un saggio a riguardo (ne scrisse diversi di vari generi, naturalmente molti di argomento teologico), e l’utilizzò nei suoi racconti; la breve trattazione in questione, “Obi nei Caraibi”, lo presentiamo in appendice (al libro da cui è tratta questa biografia, ndr) perché di indubbio interesse. Il tutto con molto rispetto per il folklore locale, che capiva anche se non poteva approvarlo: nei suoi racconti la religione cristiana, infatti, finisce col rivelarsi superiore a quella indigena, che pure ha una sua validità. Con un esame odierno per mezzo degli strumenti della psicologia, potremmo giungere alla conclusione che il voodoo ha effetto solo se uno ci crede veramente, a causa del notevole potere dell’autosuggestione.
 Un altro aspetto della comprensione della cultura caraibica si ha nel modo in cui Whitehead tratta gli indigeni: certo con sufficienza, anzi con paternalismo, perché lui è un uomo civilizzato in mezzo a dei quasi primitivi; ma non li riduce a macchiette come nei romanzi e nei film coevi (dove i negri parlano in maniera sgrammaticata e con accento gutturale: basti ricordare Via col vento) e non adopera mai il termine dispregiativo nigger (usato da molti, compreso a volte Lovecraft) ma il corretto negro (non si era ancora arrivati all’attuale coloured). Per questo nella nostra traduzione (sempre del libro in questione, ndr) abbiamo mantenuto “negro” senza cedere al falso “politicamente corretto” odierno che lo vorrebbe sostituito da “nero”.
Un altro aspetto della comprensione della cultura caraibica si ha nel modo in cui Whitehead tratta gli indigeni: certo con sufficienza, anzi con paternalismo, perché lui è un uomo civilizzato in mezzo a dei quasi primitivi; ma non li riduce a macchiette come nei romanzi e nei film coevi (dove i negri parlano in maniera sgrammaticata e con accento gutturale: basti ricordare Via col vento) e non adopera mai il termine dispregiativo nigger (usato da molti, compreso a volte Lovecraft) ma il corretto negro (non si era ancora arrivati all’attuale coloured). Per questo nella nostra traduzione (sempre del libro in questione, ndr) abbiamo mantenuto “negro” senza cedere al falso “politicamente corretto” odierno che lo vorrebbe sostituito da “nero”.
Il personaggio di Gerald Canevin è veramente un alter ego di Whitehead: come lui è un sofisticato gentiluomo di buone maniere (ma il reverendo era anche capace di imprecare in maniera colorita, come riporta lo stesso Lovecraft), sportivo ed elegante, vive nella finzione a Santa Cruz (mentre Whitehead aveva vissuto a St. Croix) e ascolta con curiosità e partecipazione i casi che gli vengono sottoposti, cosa che lo apparenta ai vari indagatori dell’incubo di cui la letteratura fantastica è piena, dal John Silence di Blackwood all’Hesselius di Sheridan Le Fanu al Jules de Grandin di Seaburv Quinn. Ma Canevin non è un vero investigatore, non cerca misteri da risolvere, vi si trova invece immischiato per caso e a volte li risolve mentre in altre occasioni si limita ad aspettare che la natura faccia il suo corso, che sia cioè la provvidenza divina ad affrontare la situazione, dimostrando – come si diceva poco sopra – la superiorità sia della religione cristiana sia dell’uomo bianco civilizzato nei confronti della cultura delle Indie Occidentali, cosa che non mitiga nella maniera più assoluta la genuina essenza horror dei suoi racconti, alcuni dei quali raccapriccianti e spaventosi, altri più in linea con la tradizione gotica dei racconti di fantasmi (in particolare quelli che vedono Canevin occasionalmente in trasferta, a Londra o negli Stati Uniti) ma ugualmente pieni di mistero e fascino morboso. Perché la prosa di Whitehead è scarna ma partecipata, molto realistica ma al contempo allusiva, in grado di avvincere il lettore ed evocare gli scenari descritti. Il periodo in cui il Nostro collaborò con Weird Tales è considerato il migliore nella storia della rivista (che avrebbe mantenuto questo alto standard solo per qualche anno ancora, fino alle soglie della Seconda Guerra Mondiale) grazie alla costante collaborazione di tre scrittori – Lovecraft, Robert E. Howard e Clark Ashton Smith – i quali per questo furono definiti “i Tre Moschettieri di Weird Tales“. Ebbene, Whitehead potrebbe essere il Quarto, il D’Artagnan della situazione!
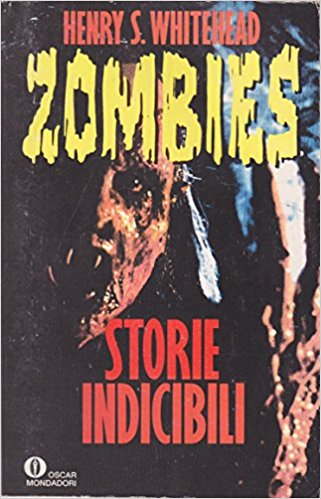 Di H.S. Whitehead in Italia era uscito molto poco, un paio di racconti sparsi in antologie miscellanee dedicate ai vampiri o altri esseri soprannaturali e una raccolta, Zombies – Storie indicibili (traduzione di quella americana del 1944, a cura di Giuseppe Lippi), apparsa negli Oscar Mondadori nell’ormai lontano 1992. La lacuna è stata parzialmente colmata con Terrore nero, pubblicata nel 2015 da Fratini Editore, con introduzione di Walter Catalano, che ripropone i due migliori racconti apparsi nella precedente ma ne ha aggiunti altri dieci completamente inediti, tutti facenti parte della serie di Gerald Canevin. Tuttavia altri ne mancavano all’appello, e sono degni di interesse: li pubblichiamo in ordine cronologico di stesura per meglio seguire l’evoluzione tematica e stilistica dell’Autore. Intanto “Le luci delle Antille” e “La Pavana di Ravel” che sono altri due episodi con protagonista Canevin e che quindi contribuiscono ad accrescere la conoscenza di questa simpatica figura (che è presente anche in un romanzo breve ancora inedito, “The Great Circle”, troppo lungo per essere qui inserito e tutto sommato non particolarmente riuscito oltre che inconsueto perché fuori dal canone antillano in quanto è la storia della scoperta di una civiltà perduta sulla falsariga di alcune opere di Haggard, Merrit e tanti altri). Poi “La porta”, non eccezionale ma comunque un buon racconto per aprire il volume; un gioiellino quale “Il culto del teschio”; il buffo ma sorprendente “Il tabernacolo”; l’assolutamente atipico “La meridiana lunare” – che è l’unico non orrorifico, un fantasy esotico di ambientazione orientale. Gli altri sono obiettivamente minori e non hanno superato il passare del tempo, troppo legati al periodo in cui furono scritti, ma in realtà l’unico vero difetto è quello di apparire troppo ripetitivi, troppo ispirati a modelli meglio conosciuti dal lettore odierno: “La tigre del mare”, per esempio, sembra influenzato da William Hope Hodgson, “Nessun testimone oculare” dallo stesso Lovecraft, altri da Marion Crawford, Robert Howard, eccetera.
Di H.S. Whitehead in Italia era uscito molto poco, un paio di racconti sparsi in antologie miscellanee dedicate ai vampiri o altri esseri soprannaturali e una raccolta, Zombies – Storie indicibili (traduzione di quella americana del 1944, a cura di Giuseppe Lippi), apparsa negli Oscar Mondadori nell’ormai lontano 1992. La lacuna è stata parzialmente colmata con Terrore nero, pubblicata nel 2015 da Fratini Editore, con introduzione di Walter Catalano, che ripropone i due migliori racconti apparsi nella precedente ma ne ha aggiunti altri dieci completamente inediti, tutti facenti parte della serie di Gerald Canevin. Tuttavia altri ne mancavano all’appello, e sono degni di interesse: li pubblichiamo in ordine cronologico di stesura per meglio seguire l’evoluzione tematica e stilistica dell’Autore. Intanto “Le luci delle Antille” e “La Pavana di Ravel” che sono altri due episodi con protagonista Canevin e che quindi contribuiscono ad accrescere la conoscenza di questa simpatica figura (che è presente anche in un romanzo breve ancora inedito, “The Great Circle”, troppo lungo per essere qui inserito e tutto sommato non particolarmente riuscito oltre che inconsueto perché fuori dal canone antillano in quanto è la storia della scoperta di una civiltà perduta sulla falsariga di alcune opere di Haggard, Merrit e tanti altri). Poi “La porta”, non eccezionale ma comunque un buon racconto per aprire il volume; un gioiellino quale “Il culto del teschio”; il buffo ma sorprendente “Il tabernacolo”; l’assolutamente atipico “La meridiana lunare” – che è l’unico non orrorifico, un fantasy esotico di ambientazione orientale. Gli altri sono obiettivamente minori e non hanno superato il passare del tempo, troppo legati al periodo in cui furono scritti, ma in realtà l’unico vero difetto è quello di apparire troppo ripetitivi, troppo ispirati a modelli meglio conosciuti dal lettore odierno: “La tigre del mare”, per esempio, sembra influenzato da William Hope Hodgson, “Nessun testimone oculare” dallo stesso Lovecraft, altri da Marion Crawford, Robert Howard, eccetera.
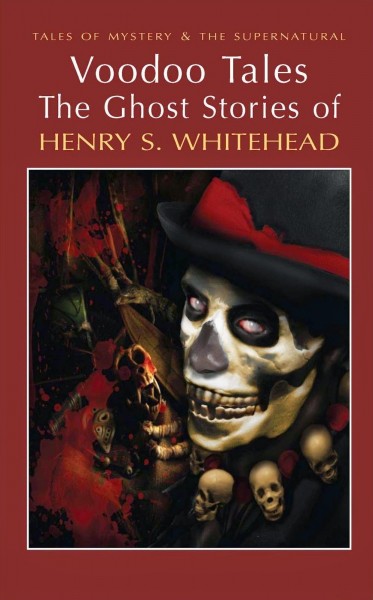 Un discorso a parte merita “Bothon”, pubblicato postumo nel 1946 con il nome di Whitehead ma recentemente attribuito almeno in parte a H.P Lovecraft e presentato come una loro collaborazione, sebbene vi sia persino chi sostenga (A. Langly Searles) si tratti invece di un’opera scritta totalmente da August Derleth. Secondo la An H. P. Lovecraft Encyclopedia di S.T. Joshi e David E. Schultz (2001) Whitehead nel 1932 si era visto rifiutare da Strange Tales una storia intitolata “The Bruise”, su un personaggio in preda a strane visioni dopo aver subito un colpo in testa, e Lovecraft gli aveva consigliato di riscriverla inserendo il ricorso a una memoria ancestrale proveniente dall’epoca del perduto continente di Mu (forse fornendogli anche una scaletta e collegandolo in qualche modo ai suoi “Miti di Cthulhu“). Data la successiva morte di Whitehead lo stesso HPL non seppe mai se il suo consiglio fosse stato seguito, ma quando nel 1946 “Bothon” venne pubblicato fu evidente che si tratta di quel racconto, anche se non si può dire se e quanto vi sia di Lovecraft, tanto che nel canone delle sue opere complete non è mai stato inserito (al contrario di quanto avvenuto con “La trappola”, unica altra collaborazione tra i due). In effetti lo stile non è quello di Lovecraft ma quello pesante e prolisso delle peggiori opere di Whitehead, ma nel dubbio abbiamo preferito metterlo, certi di fare cosa gradita agli appassionati lovecraftiani, sempre alla ricerca di eventuali inediti, di curiosità, di redazioni originali delle opere di HPL.
Un discorso a parte merita “Bothon”, pubblicato postumo nel 1946 con il nome di Whitehead ma recentemente attribuito almeno in parte a H.P Lovecraft e presentato come una loro collaborazione, sebbene vi sia persino chi sostenga (A. Langly Searles) si tratti invece di un’opera scritta totalmente da August Derleth. Secondo la An H. P. Lovecraft Encyclopedia di S.T. Joshi e David E. Schultz (2001) Whitehead nel 1932 si era visto rifiutare da Strange Tales una storia intitolata “The Bruise”, su un personaggio in preda a strane visioni dopo aver subito un colpo in testa, e Lovecraft gli aveva consigliato di riscriverla inserendo il ricorso a una memoria ancestrale proveniente dall’epoca del perduto continente di Mu (forse fornendogli anche una scaletta e collegandolo in qualche modo ai suoi “Miti di Cthulhu“). Data la successiva morte di Whitehead lo stesso HPL non seppe mai se il suo consiglio fosse stato seguito, ma quando nel 1946 “Bothon” venne pubblicato fu evidente che si tratta di quel racconto, anche se non si può dire se e quanto vi sia di Lovecraft, tanto che nel canone delle sue opere complete non è mai stato inserito (al contrario di quanto avvenuto con “La trappola”, unica altra collaborazione tra i due). In effetti lo stile non è quello di Lovecraft ma quello pesante e prolisso delle peggiori opere di Whitehead, ma nel dubbio abbiamo preferito metterlo, certi di fare cosa gradita agli appassionati lovecraftiani, sempre alla ricerca di eventuali inediti, di curiosità, di redazioni originali delle opere di HPL.
Con questo volume possiamo considerare concluso il recupero delle opere fantastiche di Henry St. Clair Whitehead. Certo manca ancora, oltre a “The Great Circle”, un pugno di racconti (ad esempio “Sea Change”, un’avventura di mare più fantastica che horror troppo simile a “La tigre del mare”, che invece abbiamo inserito) ma sono sicuramente minori e troppo datati e in fondo meritevoli di oblio. In ogni caso bastano queste, per provare i brividi dell’avventura, del mistero e delle maledizioni voodoo!






























