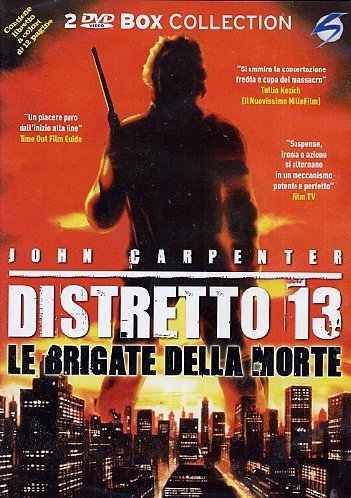Il latino sta all’italiano come il western sta al cinema americano; ergo: il western è la lingua morta – ma sempre produttiva come humus – del cinema americano.
Due citazioni
“I film si muovono – M-O-V-I-M-E-N-T-O – essi muovono. Montaggio, movimento di camera, ecco cosa sono i film” (1). L’intera l’ideologia discorsiva di Distretto 13 – Le brigate della morte si desume da – e passa attraverso – una rigorosa visività, o a voler essere più precisi da mezzi esclusivamente cinematografici: se per esempio possiamo dire che un certo tipo di violenza massacratrice della polizia equivale a quella della banda criminale, l’affermazione trova un puntuale riscontro negli identici dettagli del fucile dell’agente che sporge dall’alto e di quello dell’assassino che esce dal finestrino dell’auto in cerca di una vittima; anzi, con il solo aiuto dell’immagine è possibile addirittura misurare la distanza che separa la violenza dei Thunder Streets da quella di Bishop e soci: nella prima occasione è la casualità a farla da padrona, in soggettiva: spariamo alla massaia che torna a casa dopo aver fatto la spesa o al senzatetto ubriacone? Nel secondo, sempre in soggettiva, il nostro obiettivo è preciso: colpire la nitroglicerina per uccidere il maggior numero possibile di assalitori.
E tuttavia l’affermazione precedente viene subito così corretta, secondo una sorta di legge non scritta del cinema americano, dallo stesso Carpenter: “Allo stesso tempo la tecnica non è fine a se stessa, è il mezzo attraverso cui raggiungi il pubblico. Non voglio fare un film in cui la storia sia subordinata alla tecnica…” (2). L’intera vicenda è centripeta: il Distretto 13, come un magnete potentissimo, attira a sé il tenente, i condannati a morte, l’uomo che ha vendicato la figlia e, sulle tracce di quest’ultimo, la banda di giovani criminali; per questo le riprese partono – secondo una logica molto piana, molto cartesiana, che non presenta particolari sorprese espressive – da panoramiche in campo lungo anche ampie (quella del quartiere degradato, della strada in cui si aggira la banda in auto e del distretto dall’esterno) e quindi convergono sempre più verso campi medi (all’interno del posto di polizia, con l’eccezione dei campi lunghi quando gli assaliti guardano all’esterno il piazzale), piani americani (le sparatorie, naturalmente), primi piani (durante i momenti di discussione fra gli assediati) e infine verso un dettaglio gigantesco: la lastra dietro la quale si riparano i tre superstiti durante l’ultimo assalto sulla quale sta parzialmente scritto “Support your local police”.
“Support your local police”, in sostanza, è poi il messaggio di fondo del film, ideologico non meno che ironico: per estensione un invito rivolto alla società civile a riprendersi palmo a palmo le città, innanzitutto con mezzi militari vista la situazione estrema, o forse, viste le scarse forze in campo dalla parte della legge (oltre al poliziotto, un’impiegata e un condannato a morte), a battere in ritirata senza tentare di resistere al potere delle bande. Se vogliamo prenderlo sul serio, per spiegarlo meglio occorre rifarsi a un altro slogan. La differenza minima nelle frasi “Dulce et decorum est pro patria mori” e “Dulce et decorum est mori”, fa degli Street Thunder dei criminali (e la loro divisa è enunciata proprio in questi precisi termini da Wells: “Dicono che morire sia bello”) e degli assediati degli individui che rispettano le regole sociali dovunque si trovino, se necessario anche in un distretto di polizia sul punto di essere abbandonato: un uomo chiede aiuto e dovere delle forze della legge, di Bishop nel caso particolare, è quello di aiutarlo, costi quel che costi. Ma dov’è l’ordinamento americano se lo stato è scomparso e al suo posto c’è un quartiere dove nessuno sente niente né sa che ci sono morti dappertutto perché i cadaveri sono stati fatti scomparire? Eppure “non siamo in un deserto, siamo a Los Angeles.” Dopo un più che legittimo attimo di smarrimento la risposta di Bishop è comunque senza tentennamenti: “Questa è una stazione di polizia ed è qui che lui è venuto: gli daremo tutto l’aiuto di cui ha bisogno.” Ovvero, il Distretto 13 è l’America, l’ordinamento americano vive nel cuore e nella testa del tenente; lui, Leigh e Napoleon sono l’intero corpo di polizia; i suoi gradi, infine, fanno di lui il potere degli Stati Uniti.
 Da parte loro, comunque, i giovani criminali – all’apparenza male totalmente esterno e monodimensionale, come quello dei pellerossa di Ombre rosse secondo la razzista ideologia fordiana che vuole l’assoluta alterità degli indigeni rispetto ai colonizzatori – non sono privi di un proprio ordine, ne hanno semplicemente uno diverso da quello ortodosso, ma pur sempre basato su leggi ataviche (ormai dimenticate): il patto di sangue (letterale, col rito del Cholo al quale si accenna solo fugacemente nella versione inglese del film), la vendetta e un io collettivo – una mentalità che si potrebbe complessivamente definire magica, e come tale giudicata deviante ed eretica con ottime ragioni dalla nostra società. A loro modo i Thunder Street vogliono rifondare da zero la politica eliminando con la forza delle armi le decrepite istituzioni esistenti ed è forse per questo che essi tornano in forma incosciente, comunità che non conosce la fonte dei propri impulsi, a quelle che sono le origini della politica; tali origini si rinvengono nell’appartenenza a un gruppo e nello scontro fisico inteso come “gioco”, “senza” motivazioni ideologiche e quasi a prescindere dalla reale importanza e giustezza delle cause per le quali ci si batte, proprio come se si trattasse di gruppi di hooligans o dei ragazzi della via Pal, che badano a conservare il controllo sul proprio territorio e possibilmente a estenderlo (rispettivamente le prime forme di politica interna e di politica estera). In tale prospettiva tornano utili le riflessioni di Ortega y Gasset (3) secondo le quali l’origine dello Stato è sportiva: per il filosofo spagnolo sono proprio le bande di ragazzi in lotta fra loro, e disposte a ogni sorta di azione violenta, a gettare le fondamenta della politica. Al loro interno, tali gruppi sono cementati da un forte senso di solidarietà fra i membri (si ricordi il patto iniziale), uniti dalla segretezza e dagli ideali della caccia (l’inseguimento di Lawson per le strade di Los Angeles, selvaggina tristemente metaforica), della guerra e del piacere (elementi che formano un tutt’uno per la banda): i nostri capi multirazziali degli Street Thunder non avrebbero da aggiungere una virgola a questa idea di politica come club atletico. Per concludere, il desiderio di ritornare a una società arcaica nasce quando e dove una società e suoi modelli non funzionano, come testimonia il proliferare dei gruppi di giovani delinquenti negli Stati Uniti – e non solo lì – ai nostri giorni: in ciò sta l’involontario valore profetico dell’opera di Carpenter. Lui, per parte sua, voleva fare solo un film western di serie B, sia pure fuori tempo massimo.
Da parte loro, comunque, i giovani criminali – all’apparenza male totalmente esterno e monodimensionale, come quello dei pellerossa di Ombre rosse secondo la razzista ideologia fordiana che vuole l’assoluta alterità degli indigeni rispetto ai colonizzatori – non sono privi di un proprio ordine, ne hanno semplicemente uno diverso da quello ortodosso, ma pur sempre basato su leggi ataviche (ormai dimenticate): il patto di sangue (letterale, col rito del Cholo al quale si accenna solo fugacemente nella versione inglese del film), la vendetta e un io collettivo – una mentalità che si potrebbe complessivamente definire magica, e come tale giudicata deviante ed eretica con ottime ragioni dalla nostra società. A loro modo i Thunder Street vogliono rifondare da zero la politica eliminando con la forza delle armi le decrepite istituzioni esistenti ed è forse per questo che essi tornano in forma incosciente, comunità che non conosce la fonte dei propri impulsi, a quelle che sono le origini della politica; tali origini si rinvengono nell’appartenenza a un gruppo e nello scontro fisico inteso come “gioco”, “senza” motivazioni ideologiche e quasi a prescindere dalla reale importanza e giustezza delle cause per le quali ci si batte, proprio come se si trattasse di gruppi di hooligans o dei ragazzi della via Pal, che badano a conservare il controllo sul proprio territorio e possibilmente a estenderlo (rispettivamente le prime forme di politica interna e di politica estera). In tale prospettiva tornano utili le riflessioni di Ortega y Gasset (3) secondo le quali l’origine dello Stato è sportiva: per il filosofo spagnolo sono proprio le bande di ragazzi in lotta fra loro, e disposte a ogni sorta di azione violenta, a gettare le fondamenta della politica. Al loro interno, tali gruppi sono cementati da un forte senso di solidarietà fra i membri (si ricordi il patto iniziale), uniti dalla segretezza e dagli ideali della caccia (l’inseguimento di Lawson per le strade di Los Angeles, selvaggina tristemente metaforica), della guerra e del piacere (elementi che formano un tutt’uno per la banda): i nostri capi multirazziali degli Street Thunder non avrebbero da aggiungere una virgola a questa idea di politica come club atletico. Per concludere, il desiderio di ritornare a una società arcaica nasce quando e dove una società e suoi modelli non funzionano, come testimonia il proliferare dei gruppi di giovani delinquenti negli Stati Uniti – e non solo lì – ai nostri giorni: in ciò sta l’involontario valore profetico dell’opera di Carpenter. Lui, per parte sua, voleva fare solo un film western di serie B, sia pure fuori tempo massimo.
 L’io collettivo, a dire il vero, è forse l’unico valore condiviso da assedianti e assediati (con l’eccezione di Julie, pronta a consegnare il povero catatonico Lawson alla banda perché sospenda l’assedio), ma tale ideale di sacrificio è precisamente quello che una società disgregata come quella statunitense – composta perlopiù di individualità monadiche ben lontane dal venir meno al loro privato egoismo per la salvezza di qualcun altro – ha sgozzato sull’altare di una forbice sociale che provoca i disastri ben noti, anche ai nostri giorni, a livello di comunità. Esser meno di un io è da intendersi in senso positivo tanto per i pellirossa-zombie spinti a morire per un principio di vendetta, fiduciosi nel loro sacrificio di lemmings e di quelli che verranno dopo – solo per estinguersi allo stesso modo – pur di raggiungere l’obiettivo della loro comunità, quanto per Bishop e i suoi compagni, animati dallo spirito della difesa a oltranza di Alamo (d’altro canto, The Anderson Alamo era il primo titolo di lavorazione del film); e ciò nonostante gli assediati sappiano bene quanto sia vero quel che dice Leigh: “…E tutto per un uomo che non conosciamo neanche e non sappiamo cos’ha fatto e che non ci dirà neanche grazie.”
L’io collettivo, a dire il vero, è forse l’unico valore condiviso da assedianti e assediati (con l’eccezione di Julie, pronta a consegnare il povero catatonico Lawson alla banda perché sospenda l’assedio), ma tale ideale di sacrificio è precisamente quello che una società disgregata come quella statunitense – composta perlopiù di individualità monadiche ben lontane dal venir meno al loro privato egoismo per la salvezza di qualcun altro – ha sgozzato sull’altare di una forbice sociale che provoca i disastri ben noti, anche ai nostri giorni, a livello di comunità. Esser meno di un io è da intendersi in senso positivo tanto per i pellirossa-zombie spinti a morire per un principio di vendetta, fiduciosi nel loro sacrificio di lemmings e di quelli che verranno dopo – solo per estinguersi allo stesso modo – pur di raggiungere l’obiettivo della loro comunità, quanto per Bishop e i suoi compagni, animati dallo spirito della difesa a oltranza di Alamo (d’altro canto, The Anderson Alamo era il primo titolo di lavorazione del film); e ciò nonostante gli assediati sappiano bene quanto sia vero quel che dice Leigh: “…E tutto per un uomo che non conosciamo neanche e non sappiamo cos’ha fatto e che non ci dirà neanche grazie.”
Il silenzio e la politica culturale
“Avete sentito niente?” “Andiamo!”, dice uno dei criminali che verranno uccisi dalla polizia a inizio film; e prima di cominciare il rituale, i capi: “Dai, cominciamo!”, “Sono pronto.”, “Anch’io.” I membri della banda sono praticamente muti: quelli che abbiamo appena citato sono gli unici brandelli di dialogo che vengono pronunciati da loro durante tutto il film. Persino le loro armi sono dotate di silenziatore e la cosa viene sottolineata nel corso del primo attacco, che proprio per tale ragione appare quasi girato al rallentatore (4). Se vogliamo tentare un’altra strada interpretativa per quanto riguarda gli Street Thunder intendendoli come una delle tante manifestazioni del male, potremmo forse affermare quanto segue: il loro male è muto perché non ha politica culturale, niente triade riflessione-dibattito-compromesso che impedisce, almeno per la durata del pensiero e della discussione, l’accadere di qualcosa; al contrario, tutto è già pura vita immediata ed esperienza cieca, tutto è già stato deciso a priori una volta per sempre, o meglio si è semplicemente affermato con la forza, e non ci si torna più sopra. Per parte sua, potremmo azzardare, Carpenter – proprio in quanto intellettuale – non può non avere orrore di un’esistenza senza filosofia e forse, insieme, il male gli è distante nelle sue dinamiche interne: perciò con molta onestà si limita a rappresentarlo dall’esterno, quasi in astratto, senza offrire spiegazioni psicologiche o d’altro genere, d’ostacolo innanzitutto sotto il profilo della snellezza narrativa, che idee a parte è quanto gli sta maggiormente a cuore come cineasta. A proposito di snellezza, secondo un procedimento abbastanza tipico dell’autore, l’intera vicenda si svolge in una ristretta unità di tempo (dalle prime ore mattutine alla serata di un sabato) senza fare ricorso a flash-back, ma solo a un iniziale montaggio alternato, dello stesso Carpenter sotto pseudonimo, che progressivamente lascia il posto a una vera e propria, aristotelica, unità di tempo, luogo e azione condita da un tema musicale tanto spartano quanto sinistro e minaccioso (all’incirca quanto dice un acuto commentatore internetiano di esso).
 Sul fronte degli assediati, esattamente all’opposto degli Street Thunder, i dialoghi sono invece secchi e taglienti, non di rado infarciti di battute in pieno stile western; in particolare, ci piace ricordare per l’assurdità della situazione il momento della conta per stabilire chi debba tentare di uscire alla ricerca di aiuto: un momento distensivo che tuttavia non viene meno neanche per un attimo alla drammaticità della situazione in quanto a essa strettamente collegato.
Sul fronte degli assediati, esattamente all’opposto degli Street Thunder, i dialoghi sono invece secchi e taglienti, non di rado infarciti di battute in pieno stile western; in particolare, ci piace ricordare per l’assurdità della situazione il momento della conta per stabilire chi debba tentare di uscire alla ricerca di aiuto: un momento distensivo che tuttavia non viene meno neanche per un attimo alla drammaticità della situazione in quanto a essa strettamente collegato.
Più in generale il film è anche un film sull’interruzione della comunicazione: il padre della bambina, motore immobile dell’intera vicenda, non riesce a spiegare cosa gli sia accaduto (e la cosa risulta molto verosimile dato il doppio shock che ha dovuto subire nell’arco di poche ore); la società dei telefoni e quella della luce contribuiscono in maniera determinante e paradossale ad accentuare ulteriormente la tensione interrompendo l’erogazione dei loro servizi; infine, ciliegina sulla torta, le case vicine al distretto non sono abitate.
Misto alla vaniglia
Distretto 13 è un film composito e sincretico nei generi, com’è ben noto fondato sull’asse portante di Un dollaro d’onore e de La notte dei morti viventi a livello macrostrutturale: da un lato il posto di polizia da difendere a ogni costo e i numerosi dettagli presi pari pari dal film di Hawks – il lancio del fucile di Bishop a Napoleon e la sequenza finale in cui Bishop spara all’esplosivo tanto per citarne due (5) -, dall’altro la caratterizzazione, soprattutto nell’ultimo attacco, dei Thunder Street come una sorta di esercito zombie che avanza in massa con le modalità tipiche dei morti viventi (solo un po’ più velocemente) e il protagonista di colore. Oltre queste due pellicole possiamo però trovarvi, a livello di citazione magmatica, molto altro cinema, dal libro di Truffaut su Hitchcock – nella sequenza in cui il tenente rievoca l’episodio della sua infanzia in cui entrò per la prima volta nel posto di polizia (6) – al riferimento a Non aprite quella porta con i movimenti avversi alla Terra che stanno producendosi nei cieli (le macchie solari che determinano l’aumento degli atti criminali di cui parlano prima la radio e poi Bishop, scherzosamente, al capitano). Più importante di Hitchcock e di Hooper (e delle fin troppe citazioni extradiegetiche, perlopiù puramente onomastiche, che costellano l’opera) è tuttavia il ricordo di un altro film di cui parleremo fra breve.
 Al suo apparire, il futuro assassino della piccola Kathy è caratterizzato da un gesto: lo schiaffo che dà al proprio braccio come fosse quello di un altro per far venire alla superficie la vena da incidere per partecipare al rito di sangue; un piccolo dettaglio che mostra contemporaneamente la crudeltà dell’essere umano e la legge dalla quale essa è regolata tanto a livello biografico quanto storico: facciamo agli altri ciò che abbiamo già subito per mano nostra (non a caso i primi a finire nei lager nazisti furono proprio i tedeschi oppositori di Hitler).
Al suo apparire, il futuro assassino della piccola Kathy è caratterizzato da un gesto: lo schiaffo che dà al proprio braccio come fosse quello di un altro per far venire alla superficie la vena da incidere per partecipare al rito di sangue; un piccolo dettaglio che mostra contemporaneamente la crudeltà dell’essere umano e la legge dalla quale essa è regolata tanto a livello biografico quanto storico: facciamo agli altri ciò che abbiamo già subito per mano nostra (non a caso i primi a finire nei lager nazisti furono proprio i tedeschi oppositori di Hitler).
Non c’è dubbio che la sequenza dell’assassinio della bambina venne studiata con estrema accuratezza per creare il massimo dell’attesa e insieme della sorpresa: uno stato di climax (i criminali passano e ripassano vicino al furgoncino dei gelati mentre la ragazzina si fa dare i soldi per comprare un cono dal padre, poco attento perché impegnato al telefono), poi di – falso – anticlimax (i criminali tornano quando lei se ne è andata) e infine, proprio quando lo spettatore ha ormai tirato un sospiro di sollievo, ecco la spannung (Kathy ritorna dal gelataio perché questi non le ha fatto il cono coi gusti richiesti e viene immediatamente uccisa). Strano a dirsi, ma il meccanismo retorico che presiede a questo episodio è lo stesso di certi momenti comici dei cartoni animati, quando per esempio un Vile Coyote, tranquillizzatosi dell’inoffensività di una bomba, viene colto in pieno da un’esplosione ritardata. Da notare, fra l’altro, che l’infanticidio (un ricordo dell’Hitchcock di Sabotaggio?) viene mostrato apertamente, mentre, per non depotenziare in alcun modo la sequenza distogliendo fosse pure per un attimo l’attenzione della sala, non lo è l’uccisione del gelataio. L’assassino compie il suo gesto con la stessa impassibilità con la quale schiaccerebbe soprappensiero una formica, la vittima muore fra l’incoscienza (non ha neppure il tempo di rendersi conto di quel che sta accadendo) e l’innocenza (non ha neppure avuto il tempo di vivere); Carpenter, ben sapendo quanto già fosse cruda la scena in se stessa, non schiaccia il pedale degli effetti truculenti: lo spettatore vede soltanto un soffio rosso quasi delicato allargarsi sul petto della ragazzina.
Dopo aver recuperato la pistola del gelataio, al padre basta un breve inseguimento per trovarsi di fronte all’assassino e ucciderlo: l’espressione di quest’ultimo – in perfetta linea col processo di reificazione che aveva già subito – resta quella di una cosa tanto da carnefice quanto da vittima. In termini più crudi, non dà la minima soddisfazione a chi lo ammazza. Si tratta senza dubbio di una delle catarsi più rapide della storia del cinema, talmente veloce da rivelarsi quasi deludente per il pubblico, all’epoca abituato a uccisioni e vendette che si articolavano, inasprivano e prolungavano per interi film, come nel caso de L’ultima casa a sinistra. Ci pare che qui il riferimento di Carpenter proprio alla pellicola di Craven sia evidente, quasi ne fosse una epitome ridotta ai suoi termini essenziali (a esclusione dello stupro), e insieme un punto di partenza per superarlo – dimenticarlo? – con l’aiuto formale di un genere, il western metropolitano, ancora tutto da codificare (I guerrieri della notte, per esempio, sono di là da venire) e però fin da subito in grado di tenere a bada i tremendi fantasmi evocati da Craven grazie al suo immediato caratterizzarsi in quanto prodotto di finzione tranquillizzante: per questo basta la coloritura psicologica da vecchio West, e quindi ovviamente portatrice di valori positivi, dei protagonisti; in particolare, non dimentichiamolo, Napoleon è un assassino ma non certo di bambini, se no – possiamo giurarlo – non avrebbe tratti così nobili e non direbbe frasi così autenticamente romantiche: “Io sono nato fuori tempo”, affermazione che si potrebbe estendere senza alcun problema anche alla pellicola.
 E’ noto che la sequenza sulla quale ci siamo diffusi creò al regista parecchi problemi di ordine censorio anche sul versante critico – non a caso il film “venne recensito dal New York Times tre anni dopo Halloween: la notte delle streghe” (7) -, e possiamo immaginare quanti in più gliene creerebbe oggi, momento storico nel quale, mentre non ci si sogna neppure di mettere fuori legge l’ossessiva iterazione pubblicitaria, atto criminale che influisce in maniera determinante su una mutazione antropologica che nessuno potrà indagare in futuro perché tutti saranno già mutati nel profondo, un ipotetico successore del Carpenter di Distretto 13 verrebbe guardato con puritano sospetto come un pericoloso sadico pornopedofilo, senza più distinguere fra chi produce immagini, anche della specie più crudele, nel campo della finzione e chi realmente agisce come sadico o come pedofilo; abbiamo l’impressione, inoltre, che persino nello scherzoso tormentone di Wilson (quel “Qualcuno ha da fumare?” rivolto a chiunque) si vedrebbe una pericolosa istigazione al vizio (8): d’altra parte l’isteria collettiva e lo scimmiottamento alla moda della virtù non sono certo fra gli ultimi effetti, bensì fra i più tipici, dell’igiene mentale totalitario-pubblicitaria. Ma questa, come si dice con frase anodina, è un’altra storia: proprio di Carpenter, è Essi vivono.
E’ noto che la sequenza sulla quale ci siamo diffusi creò al regista parecchi problemi di ordine censorio anche sul versante critico – non a caso il film “venne recensito dal New York Times tre anni dopo Halloween: la notte delle streghe” (7) -, e possiamo immaginare quanti in più gliene creerebbe oggi, momento storico nel quale, mentre non ci si sogna neppure di mettere fuori legge l’ossessiva iterazione pubblicitaria, atto criminale che influisce in maniera determinante su una mutazione antropologica che nessuno potrà indagare in futuro perché tutti saranno già mutati nel profondo, un ipotetico successore del Carpenter di Distretto 13 verrebbe guardato con puritano sospetto come un pericoloso sadico pornopedofilo, senza più distinguere fra chi produce immagini, anche della specie più crudele, nel campo della finzione e chi realmente agisce come sadico o come pedofilo; abbiamo l’impressione, inoltre, che persino nello scherzoso tormentone di Wilson (quel “Qualcuno ha da fumare?” rivolto a chiunque) si vedrebbe una pericolosa istigazione al vizio (8): d’altra parte l’isteria collettiva e lo scimmiottamento alla moda della virtù non sono certo fra gli ultimi effetti, bensì fra i più tipici, dell’igiene mentale totalitario-pubblicitaria. Ma questa, come si dice con frase anodina, è un’altra storia: proprio di Carpenter, è Essi vivono.
Gianfranco Galliano
NOTE
(1) J. Carpenter, citato da F. Liberti, John Carpenter, Milano, Il Castoro, 2003, pag. 5.
(2) Ibidem.
(3) J. Ortega y Gasset, L’origine sportiva dello Stato e altri saggi da “Lo spettatore”, Milano SE, 2007.
(4) F. Liberti, op. cit., pag. 26.
(5) F. Liberti, op. cit., pag. 25.
(6) F. Liberti, op. cit., pag. 26.
(7) F. Liberti, op. cit. pag. 25.
(8) Se a qualcuno quest’affermazione appare troppo apocalittica, ricordiamo un documentario della RAI su Gigi Riva (“Sfide”), che si concludeva con la domanda scherzosa del campione rivolta al giornalista: “Adesso andiamo a fumarci una sigaretta?”; tale congedo – espressivamente assai efficace perché del tutto in tono con il momento comunicativo e il personaggio – venne in un secondo momento censurato.
FONTI NON CITATE NEL TESTO
Assault on Precinct 13, The Internet Movie Database; Assault on Precinct 13, AllMovie; Assault on Precinct 13, Wikipedia; Distretto 13: le brigate della morte, Wikipedia; Shoxploitation, Wikipedia; John Carpenter, Wikipedia.