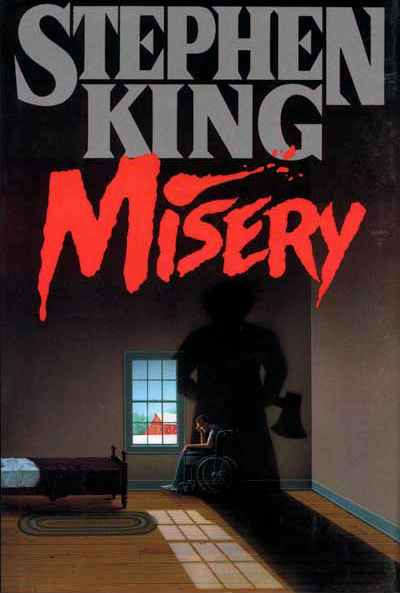 Con Misery, Stephen King ci ha dato un vero manuale di scrittura nella forma del metaromanzo: detta così, oltre che troppo assertiva, la frase suona un po’ pedante, vetero-avanguardistica e per addetti ai lavori, ma il fatto è che l’autore ha coscientemente impastato la teoria con la pratica, o meglio la teoria con il più pragmatico dei romanzi d’azione (di sopravvivenza, per esser più precisi) come – occorre dirlo – solo gli americani sanno fare.
Con Misery, Stephen King ci ha dato un vero manuale di scrittura nella forma del metaromanzo: detta così, oltre che troppo assertiva, la frase suona un po’ pedante, vetero-avanguardistica e per addetti ai lavori, ma il fatto è che l’autore ha coscientemente impastato la teoria con la pratica, o meglio la teoria con il più pragmatico dei romanzi d’azione (di sopravvivenza, per esser più precisi) come – occorre dirlo – solo gli americani sanno fare.
(Ulteriore difficoltà: la storia si svolge sostanzialmente – flash-back, anticipazioni e sogni a parte – all’interno di un solo luogo, la casa di Annie Wilkes; della lezione claustrofobica King si rammenterà anche con quel gioiellino di alto artigianato che è Il gioco di Gerald restringendo ulteriormente il suo campo d’azione a una sola stanza).
In effetti, che cos’è Il ritorno di Misery se non un romanzo nel romanzo? Che cosa sono gli accenni alle schede di concordanza (in cui lo scrittore raccoglie personaggi, luoghi, cronologie e riferimenti storici della serie di Misery con indici incrociati per evitare errori nei propri riferimenti), al paradigma del pubblico, allo scrittore come dio (e al lettore che minaccia realmente di morte l’autore come se il primo fosse un dio ancora superiore al secondo), alla lealtà rispetto alle leggi creative che l’artista stesso si impone e alle quali non può derogare senza tradire con ciò la sua opera e il suo pubblico, al deus ex machina, alla suspense, ai riferimenti semiautobiografici riguardo alla tipologia di letterato (ovviamente “popolare”) in cui si inseriscono tanto Paul Sheldon che Stephen King, a come nasce l’idea di creazione, a quali sono le condizioni ideali per scrivere (tutte e nessuna, dato che nelle condizioni peggiori possibili Sheldon elabora il suo miglior romanzo), alla parentesi di sociologia letteraria riguardo alla ricezione degli eroi – che il pubblico non concede al loro creatore di uccidere perché fanno ormai parte dell’essenza stessa della sua vita e non semplicemente dei suoi innocui passatempi, alla capacità degli scrittori di ricordare e saper eternare ogni loro trauma, anche il più piccolo, e infine al fatto che spesso neanche l’autore sa come il romanzo terminerà? Che cosa sono tutti questi elementi che compongono il nostro lungo elenco se non lezioni di pura tecnica letteraria? Eppure non annoiano mai perché sono sempre necessarie allo svolgimento dell’azione e nel contempo danno preziosissimi suggerimenti – asistematici naturalmente, ma non potrebbe essere altrimenti – a chi voglia imparare a scrivere.
 I personaggi: inevitabilmente, più di Paul (nei panni del quale King si trova per così dire a casa sua), colpisce l’approfondimento della mostruosa serial killer-infermiera Anne Wilkes, sia sotto il profilo della sua descrizione clinica (i momenti in cui si astrae totalmente dalla realtà circostante, per esempio) che della sua crudeltà (per molti aspetti, anche fisici, ricorda da vicino Ilse Koch, la “strega di Buchenwald”, e come i nazisti distrugge col fuoco il libro che non le piace). Entrambi i protagonisti, insomma, si inscrivono entro un orizzonte di assoluta verosimiglianza, così come è verosimile e dettagliatissima l’intera vicenda: persino la catarsi finale non è poi così catartica, ma rientra per l’aspetto della sua credibilità in quello che potrebbe essere un finto true-crime piuttosto che un classico romanzo d’azione, nel quale spesso viene favorita l’avventura a discapito delle spiegazioni logiche e razionali.
I personaggi: inevitabilmente, più di Paul (nei panni del quale King si trova per così dire a casa sua), colpisce l’approfondimento della mostruosa serial killer-infermiera Anne Wilkes, sia sotto il profilo della sua descrizione clinica (i momenti in cui si astrae totalmente dalla realtà circostante, per esempio) che della sua crudeltà (per molti aspetti, anche fisici, ricorda da vicino Ilse Koch, la “strega di Buchenwald”, e come i nazisti distrugge col fuoco il libro che non le piace). Entrambi i protagonisti, insomma, si inscrivono entro un orizzonte di assoluta verosimiglianza, così come è verosimile e dettagliatissima l’intera vicenda: persino la catarsi finale non è poi così catartica, ma rientra per l’aspetto della sua credibilità in quello che potrebbe essere un finto true-crime piuttosto che un classico romanzo d’azione, nel quale spesso viene favorita l’avventura a discapito delle spiegazioni logiche e razionali.
Utilizzando con naturalezza il fatto che il proprio protagonista è uno scrittore, King non esita a svelare al pubblico quale sia la sua fonte: è Paul a rivelarci che l’origine di Misery è Le mille e una notte, sia pure con una variante: “Sheherazade non era Annie: era lui. E se fosse stato abbastanza abile nello scrivere, se lei non avesse osato ucciderlo prima d’aver saputo come andava a finire la storia, per quanto tenacemente e affannosamente i suoi istinti animaleschi le gridassero di farlo, le gridassero che doveva farlo… Non gli si sarebbe aperta una possibilità?”. L’inversione dei sessi (com’è noto, nel capolavoro della novellistica orientale Sheherazade è la moglie del crudelissimo sultano Shahryàr, che riesce con la sua eccezionale abilità di narratrice a rimandare all’infinito la propria esecuzione), probabilmente è legata a diversi fattori: innanzitutto al fatto che era difficile immaginare un uomo così stregato da una serie letteraria (a parte l’eccezione storicamente documentata di Sherlock Holmes), poi al desiderio di coniugare novelty con facility (serial killer, ma donna – personaggio non così frequente neppure nella storia criminale) e infine all’oggettiva emancipazione femminile che negli USA arriva a sfiorare una sorta di matriarcato rispetto al resto del mondo, se si escludono alcune nazioni occidentali.
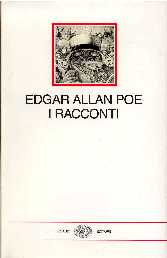 D’altra parte, forse nella prima stesura appena abbozzata de Il ritorno di Misery, bocciata tanto da Anne che in seguito anche da Paul, c’è un ricordo de La millesima seconda notte di Sheherazade di Poe, in cui il raccontare, sia pure in forma straniata e all’apparenza inverosimile, la realtà (e quindi il venir meno alle leggi del fiabesco che la narratrice de Le mille e una notte si era data) le costa la vita. La stessa cosa accadrebbe a Sheldon se non riuscisse a riportare in vita Misery senza truffare, come dice Annie, il lettore. Quindi, ricapitolando, si potrebbe dire che King/Sheldon parte dalla Sheherazade di Poe e arriva a quella di Le mille e una notte. Lo scrittore del Maine inoltre dimostra ancora una volta di essere affascinato dal problema autore-opera: lo aveva affrontato in precedenza col celeberrimo Shining e, dopo Misery, ci tornerà di nuovo con La metà oscura. Da un lato, quindi, il fruitore si trova di fronte a un rapporto fra scrittore di primo grado (King) e di secondo grado (Sheldon), e dall’altro a un’altrettanta stratificata relazione fra lettore di primo grado (quello delle opere kinghiane) e lettrice di secondo grado (l’infermiera folle rapita dai testi di Sheldon che hanno per protagonista Misery). Questa sorta di mise en abîme è esattamente ciò che la donna, stavo per scrivere la tifosa, non potrebbe mai comprendere, in quanto per lei Misery è un’eroina in carne e ossa, con in più la qualità inumana propria di ogni personaggio: l’immortalità.
D’altra parte, forse nella prima stesura appena abbozzata de Il ritorno di Misery, bocciata tanto da Anne che in seguito anche da Paul, c’è un ricordo de La millesima seconda notte di Sheherazade di Poe, in cui il raccontare, sia pure in forma straniata e all’apparenza inverosimile, la realtà (e quindi il venir meno alle leggi del fiabesco che la narratrice de Le mille e una notte si era data) le costa la vita. La stessa cosa accadrebbe a Sheldon se non riuscisse a riportare in vita Misery senza truffare, come dice Annie, il lettore. Quindi, ricapitolando, si potrebbe dire che King/Sheldon parte dalla Sheherazade di Poe e arriva a quella di Le mille e una notte. Lo scrittore del Maine inoltre dimostra ancora una volta di essere affascinato dal problema autore-opera: lo aveva affrontato in precedenza col celeberrimo Shining e, dopo Misery, ci tornerà di nuovo con La metà oscura. Da un lato, quindi, il fruitore si trova di fronte a un rapporto fra scrittore di primo grado (King) e di secondo grado (Sheldon), e dall’altro a un’altrettanta stratificata relazione fra lettore di primo grado (quello delle opere kinghiane) e lettrice di secondo grado (l’infermiera folle rapita dai testi di Sheldon che hanno per protagonista Misery). Questa sorta di mise en abîme è esattamente ciò che la donna, stavo per scrivere la tifosa, non potrebbe mai comprendere, in quanto per lei Misery è un’eroina in carne e ossa, con in più la qualità inumana propria di ogni personaggio: l’immortalità.
Con questi presupposti, è chiaro che la lettrice – capace di esser viva soltanto attraverso la compulsiva lettura del prodotto artificiale costituito dal romanzetto rosa a scadenza più o meno fissa – sentirà la morte di Misery (ovvero il segnalarsi di essa, dal suo punto di vista, come umana) alla stregua di un vero e proprio tradimento dell’autore nei confronti della sua creatura, e soprattutto come una sentenza di morte nei propri, dal momento che l’infermiera è soltanto quando si immedesima senza riserve nella saga di Sheldon. A una minaccia di tale portata si reagisce in unico modo: con altrettanta violenza, difendendosi con altrettanta ferocia affinché la Sheherazade riluttante rappresentata da Paul non smetta di narrare la sola storia che la folle infermiera vuole sentirsi raccontare senza interruzione, per essere continuamente cullata in una vita che non è vita e che le permetta di non svegliarsi mai più, fino al momento in cui arriverà per lei una morte assai prossima a un trapasso eutanasico. Il patetismo evidente in questa soluzione data al problema esistenziale (patetismo, straziante per definizione, che in qualche modo affiora sempre nella demenza) non risparmierà comunque dal porci un interrogativo ben altrimenti inquietante per la cultura occidentale: non è eccessivo lo spazio concesso all’empatia – beninteso nei luoghi sbagliati, quelli della finzione – in essa? Miserie dell’immedesimazione, si dirà, ovvero ogni cultura ha i propri vizi legati indissolubilmente alle proprie virtù.
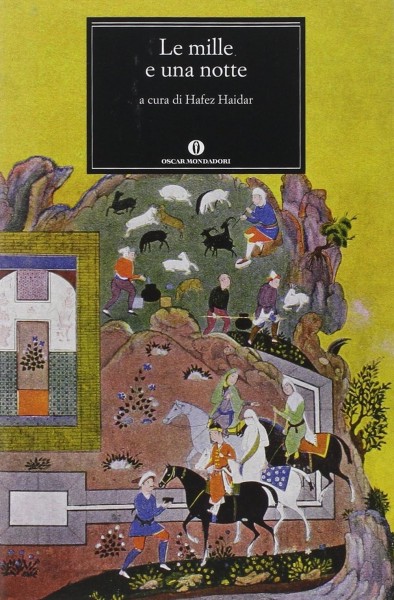 Forse. O forse no, dato che anche la cultura occidentale come tutte le altre può essere modificata: proprio Le mille e una notte riescono in questo senso a fornirci un modello mescolando fantastico (le avventure raccontate da Sheherazade) e politico (tali avventure servono a rimandare non solo la sentenza di morte della donna, bensì di tutte le donne insieme a lei) in maniera tale da farci veramente gridare al capolavoro e soprattutto senza richiedere al lettore nessuna forma di immedesimazione. Se c’è un solo motivo per schierarsi dalla parte del fantastico (in tutte le sue forme e declinazioni) basterebbe questo libro. Dato che l’offeso dal tradimento della moglie, Shahryàr, è un sultano, quindi un uomo di grande potere, Le mille e una notte diventa immediatamente romanzo politico: dopo aver fatto uccidere l’infedele consorte, infatti, “persuaso che non vi erano donne oneste, per prevenire l’infedeltà di quelle che avrebbe preso nel futuro, decise di sposarne una per notte e di farla poi strangolare il giorno seguente. Promulgata questa legge [corsivo nostro] crudele, giurò di osservarla immediatamente dopo la partenza del re di Tartaria”. Al gran visir tale legge ripugna, anche se è costretto a sottomettervisi; allo stesso modo “la fama di tanta mancanza di umanità senza precedenti suscitò una generale costernazione in città […] cosicché invece delle lodi e benedizioni che sino allora erano state tributate al sultano, tutti i suoi sudditi non facevano che imprecare contro di lui.” In poche parole, Shahryàr legalizza il femminicidio (bisognerà pur usarla questa neoplasia linguistica). Ma ancora non basta: oltre la denuncia, di grande raffinatezza è la soluzione offerta per cancellare tale norma infame. Mentre Shahazamàn, il re di Tartaria, uccide la moglie e il suo amante nel sonno – senza avere cioè la benché minima opposizione, fisica o dialettica: non c’è transizione fra pensiero e atto senza ritorno, né riflessione – Sheherazade vuole creare nel proprio marito esattamente un tale prolungato momento di riflessione. Ella, che “aveva molto letto, e possedeva una memoria prodigiosa, che non aveva dimenticato nulla” diventa la moglie del sultano con il preciso scopo di fermare i femminicidi contando sulla curiosità del DEVO SAPERE COME VA A FINIRE IL RACCONTO che lei comincia o prolunga sera dopo sera, “perché si continua a vivere per scoprire cosa succede dopo “, come dice King. Alla fine, “…Mille e una notte erano passate in questi innocenti passatempi e in questo tempo il sultano aveva avuto occasione di cambiare idea a proposito della fedeltà delle donne. Il suo spirito si era addolcito […] ‘Vedo’, le disse, ‘cara Sheherazade, che i tuoi racconti sono senza limiti e ormai da molto tempo mi diverti con essi, sei riuscita a placare la mia ira e rinuncio volentieri, per amor tuo, alla legge crudele che mi ero imposto. Tu sei la salvatrice di tutte le fanciulle che avrebbero dovuto essere sacrificate al mio giusto risentimento’.”.
Forse. O forse no, dato che anche la cultura occidentale come tutte le altre può essere modificata: proprio Le mille e una notte riescono in questo senso a fornirci un modello mescolando fantastico (le avventure raccontate da Sheherazade) e politico (tali avventure servono a rimandare non solo la sentenza di morte della donna, bensì di tutte le donne insieme a lei) in maniera tale da farci veramente gridare al capolavoro e soprattutto senza richiedere al lettore nessuna forma di immedesimazione. Se c’è un solo motivo per schierarsi dalla parte del fantastico (in tutte le sue forme e declinazioni) basterebbe questo libro. Dato che l’offeso dal tradimento della moglie, Shahryàr, è un sultano, quindi un uomo di grande potere, Le mille e una notte diventa immediatamente romanzo politico: dopo aver fatto uccidere l’infedele consorte, infatti, “persuaso che non vi erano donne oneste, per prevenire l’infedeltà di quelle che avrebbe preso nel futuro, decise di sposarne una per notte e di farla poi strangolare il giorno seguente. Promulgata questa legge [corsivo nostro] crudele, giurò di osservarla immediatamente dopo la partenza del re di Tartaria”. Al gran visir tale legge ripugna, anche se è costretto a sottomettervisi; allo stesso modo “la fama di tanta mancanza di umanità senza precedenti suscitò una generale costernazione in città […] cosicché invece delle lodi e benedizioni che sino allora erano state tributate al sultano, tutti i suoi sudditi non facevano che imprecare contro di lui.” In poche parole, Shahryàr legalizza il femminicidio (bisognerà pur usarla questa neoplasia linguistica). Ma ancora non basta: oltre la denuncia, di grande raffinatezza è la soluzione offerta per cancellare tale norma infame. Mentre Shahazamàn, il re di Tartaria, uccide la moglie e il suo amante nel sonno – senza avere cioè la benché minima opposizione, fisica o dialettica: non c’è transizione fra pensiero e atto senza ritorno, né riflessione – Sheherazade vuole creare nel proprio marito esattamente un tale prolungato momento di riflessione. Ella, che “aveva molto letto, e possedeva una memoria prodigiosa, che non aveva dimenticato nulla” diventa la moglie del sultano con il preciso scopo di fermare i femminicidi contando sulla curiosità del DEVO SAPERE COME VA A FINIRE IL RACCONTO che lei comincia o prolunga sera dopo sera, “perché si continua a vivere per scoprire cosa succede dopo “, come dice King. Alla fine, “…Mille e una notte erano passate in questi innocenti passatempi e in questo tempo il sultano aveva avuto occasione di cambiare idea a proposito della fedeltà delle donne. Il suo spirito si era addolcito […] ‘Vedo’, le disse, ‘cara Sheherazade, che i tuoi racconti sono senza limiti e ormai da molto tempo mi diverti con essi, sei riuscita a placare la mia ira e rinuncio volentieri, per amor tuo, alla legge crudele che mi ero imposto. Tu sei la salvatrice di tutte le fanciulle che avrebbero dovuto essere sacrificate al mio giusto risentimento’.”.
In sostanza, Sheherazade dilata il tempo fra pensiero (la legge che prevede la propria esecuzione e quella di tutte le altre future mogli) e azione (l’uccisione reale) attraverso la curiosità. Si tratta dell’essenza stessa della politica culturale: una dilazione che permetta all’individuo di non agire in base a un raptus, ma piuttosto di discutere fra sé e sé e con altri prima di passare all’atto. La cultura popolare non ci dice forse di contare fino a dieci prima di agire? E d’altra parte, qual è la differenza fra uno schiaffo e una carezza? Solo la velocità. (1)
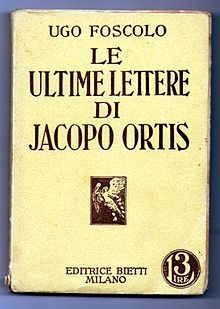 Se vogliamo avere un altro esempio del valore rappresentato da questo libro sacro del fantastico nella nostra cultura, possiamo prendere spunto dalla letteratura italiana più classica, addirittura dal primo romanzo politico d’Europa, com’è facile immaginare un voluto esempio di assoluta verosimiglianza. In esso, qualcun altro ben prima di King, e cioè Foscolo, aveva utilizzato in forma esplicita il modello delle Mille e una notte: ne Le ultime lettere di Jacopo Ortis, infatti, è il protagonista stesso ad affermare: “Tu sei stato – e ancora sei – Sheherazade per te stesso.” Nell’Ortis, Jacopo è Sheherazade per se stesso in tre modi: illudendosi di avere delle ragioni per vivere attraverso Teresa (l’amore), il viaggio (la cultura e la politica) e le lettere che scrive all’amico Lorenzo Alderani (la scrittura come documento-monumento). All’inizio del romanzo, proprio la redazione delle lettere lo tiene in vita per un filo sottilissimo, anche se fin dal principio della sua fuga da Venezia sa già che lo aspetta il suicidio. Si ucciderà per ragioni politiche, non amorose: l’amore (anche se privo di speranze, poiché sa che la donna che glielo ispira è fidanzata a un altro) è semmai ciò che più di ogni altra cosa prolunga la sua esistenza. Una volta che Teresa gli viene a mancare per il ritorno del futuro sposo Odoardo, si diverte (in senso etimologico) viaggiando, ma quando al suo rientro viene a conoscenza del matrimonio fra i due, il suicidio non è più procrastinabile. Secondo De Sanctis, l’esordio del romanzo sembra collocarsi alla fine del quinto atto di una tragedia: il disastro per il patriota veneto è già avvenuto (la cessione di Venezia agli austriaci da parte di Napoleone), quindi… si vive per vedere ciò che accade dopo, per esempio “lo spettacolo della bellezza” che “basta forse ad addormentare in noi tristi mortali tutti i dolori”. In essa Jacopo vede “una sorgente di vita”, come dimostra la lettera in cui si perde nella passione amorosa esaltata dalla primavera. Più oltre, e sia pure in un tono assai più malinconico, dimentica se stesso visitando le tombe di Galileo, Machiavelli e Michelangelo – ma subito torna la realtà di un’Italia nella quale ogni italiano è straniero nella propria terra e il colloquio con Parini conferma il suo proposito di farla finita: per lui è anche l’unica maniera per restare integro, a dispetto dei compromessi tragici a cui la politica lo mette di fronte. Le favole, per Jacopo, sono finite. Ma senza le favole che ci raccontiamo e che altri ci raccontano, per l’appunto, non c’è vita. Un monito di cui la cultura occidentale dovrebbe tenere più conto.
Se vogliamo avere un altro esempio del valore rappresentato da questo libro sacro del fantastico nella nostra cultura, possiamo prendere spunto dalla letteratura italiana più classica, addirittura dal primo romanzo politico d’Europa, com’è facile immaginare un voluto esempio di assoluta verosimiglianza. In esso, qualcun altro ben prima di King, e cioè Foscolo, aveva utilizzato in forma esplicita il modello delle Mille e una notte: ne Le ultime lettere di Jacopo Ortis, infatti, è il protagonista stesso ad affermare: “Tu sei stato – e ancora sei – Sheherazade per te stesso.” Nell’Ortis, Jacopo è Sheherazade per se stesso in tre modi: illudendosi di avere delle ragioni per vivere attraverso Teresa (l’amore), il viaggio (la cultura e la politica) e le lettere che scrive all’amico Lorenzo Alderani (la scrittura come documento-monumento). All’inizio del romanzo, proprio la redazione delle lettere lo tiene in vita per un filo sottilissimo, anche se fin dal principio della sua fuga da Venezia sa già che lo aspetta il suicidio. Si ucciderà per ragioni politiche, non amorose: l’amore (anche se privo di speranze, poiché sa che la donna che glielo ispira è fidanzata a un altro) è semmai ciò che più di ogni altra cosa prolunga la sua esistenza. Una volta che Teresa gli viene a mancare per il ritorno del futuro sposo Odoardo, si diverte (in senso etimologico) viaggiando, ma quando al suo rientro viene a conoscenza del matrimonio fra i due, il suicidio non è più procrastinabile. Secondo De Sanctis, l’esordio del romanzo sembra collocarsi alla fine del quinto atto di una tragedia: il disastro per il patriota veneto è già avvenuto (la cessione di Venezia agli austriaci da parte di Napoleone), quindi… si vive per vedere ciò che accade dopo, per esempio “lo spettacolo della bellezza” che “basta forse ad addormentare in noi tristi mortali tutti i dolori”. In essa Jacopo vede “una sorgente di vita”, come dimostra la lettera in cui si perde nella passione amorosa esaltata dalla primavera. Più oltre, e sia pure in un tono assai più malinconico, dimentica se stesso visitando le tombe di Galileo, Machiavelli e Michelangelo – ma subito torna la realtà di un’Italia nella quale ogni italiano è straniero nella propria terra e il colloquio con Parini conferma il suo proposito di farla finita: per lui è anche l’unica maniera per restare integro, a dispetto dei compromessi tragici a cui la politica lo mette di fronte. Le favole, per Jacopo, sono finite. Ma senza le favole che ci raccontiamo e che altri ci raccontano, per l’appunto, non c’è vita. Un monito di cui la cultura occidentale dovrebbe tenere più conto.
Gianfranco Galliano
(1) Sulla questione si veda anche il mio W. S. Burroughs e la scrittura creativa, “La Zona Morta”, 13/01/2017.






























