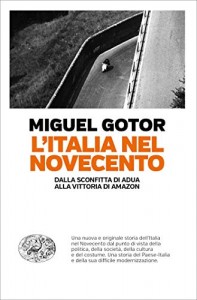 Un po’ annoiato dalla letteratura horror di oggi (e dagli editor, classifiche di Tuttolibri, personaggi che si atteggiano, cinema di genere, tarantinismi modaioli ecc), mi sono chiesto (così di punto in bianco, perché non sapevo dove sbattere la testa, mentre leggevo il saggio di Miguel Gotor “L’Italia del ‘900, dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon”, Einaudi 2019) se il fumetto, o come si dice oggi (perché del formato Bonelli non voglio nemmeno sentir parlare) la graphic novel (uso il termine in modo approssimativo ed errato, includendo anche in questa breve rassegna delle serie regolari a fumetti che non andrebbero considerate come romanzi a fumetti; la graphic dovrebbe essere un vero e proprio romanzo disegnato, quindi una storia lunga, articolata e con dei personaggi psicologicamente ben delineati), aveva qualcosa in più da offrire. Così, oltre a cercare un paio di cose che già avevo in casa, mi sono fatto la mia bella ricerca su internet e ho scovato un po’ di materiale. Le conoscerete già di sicuro, lo ripeto non sono un grande appassionato di fumetti, però potrebbe giovare lo sguardo di un lettore compulsivo di letteratura e saggistica.
Un po’ annoiato dalla letteratura horror di oggi (e dagli editor, classifiche di Tuttolibri, personaggi che si atteggiano, cinema di genere, tarantinismi modaioli ecc), mi sono chiesto (così di punto in bianco, perché non sapevo dove sbattere la testa, mentre leggevo il saggio di Miguel Gotor “L’Italia del ‘900, dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon”, Einaudi 2019) se il fumetto, o come si dice oggi (perché del formato Bonelli non voglio nemmeno sentir parlare) la graphic novel (uso il termine in modo approssimativo ed errato, includendo anche in questa breve rassegna delle serie regolari a fumetti che non andrebbero considerate come romanzi a fumetti; la graphic dovrebbe essere un vero e proprio romanzo disegnato, quindi una storia lunga, articolata e con dei personaggi psicologicamente ben delineati), aveva qualcosa in più da offrire. Così, oltre a cercare un paio di cose che già avevo in casa, mi sono fatto la mia bella ricerca su internet e ho scovato un po’ di materiale. Le conoscerete già di sicuro, lo ripeto non sono un grande appassionato di fumetti, però potrebbe giovare lo sguardo di un lettore compulsivo di letteratura e saggistica.
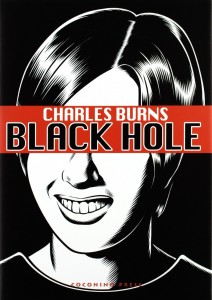 Parto un po’ a caso, comincio da Charles Burns e dal suo “Black Hole”, edito per la prima volta da noi tra il 2003 e il 2004 per l’editore Coconino. Si tratta, almeno nella prima edizione, di tre volumi di grande formato e tavole interne in bianco e nero. Burns, lo deduco dalla lunga intervista in fondo al terzo volume fatta dall’editore, viene dall’underground americano, si è formato sulle tavole di riviste come “Mad”, o nella nostalgia dei fumetti della EC; a queste suggestioni unisce letture che spaziano da Tintin, i supereroi, fino l’esperienza maturata sulla rivista “Raw” di Art Spiegelman e tanta gavetta nell’underground di Seattle (con un’esperienza anche in Italia, negli anni ’80, con Carpentieri, Igort, Tamburini, ecc). “Black Hole” ha una trama polifonica che sembra pescare anche dalla soap opera alla “Twin Peaks”, ma le assonanze con Lynch sono tante e numerose, non solo dal punto di vista narrativo. Burns ha un segno grafico nitido e pulitissimo, capace di disegnare nudi femminili stupefacenti e mai volgari. La storia e i disegni costruiscono con precisione un’America probabilmente fine anni ‘70, con hippy, ex hippy, capelloni, adolescenti confusi e malinconici, stonati dalla droga, dalle ultime esperienze comunitarie e fricchettone e ormai assorbiti in una scuola superiore anonima e pulitina, ormai prossima a quella digitalizzata e incolore di oggi. Tra storie d’amore che nascono e prime delusioni sentimentali, Burns insinua tra le bellissime tavole (credo sia il disegnatore che più mi ha colpito e fatto innamorare di un nuovo modo di concepire il fumetto, lontano dagli standard bonelliani, ma altrettanto lontano dagli istinti puttaneschi ed esagerati del pornofumetto italiano degli anni ’70) un’inquietudine spesso non spiegata, lasciando in sospeso molte delle vicende che racconta. In breve, un virus sconosciuto, che si trasmette per via sessuale, sta contagiando i giovani adolescenti di una cittadina che ricorda molto la Seattle boscosa dell’autore.
Parto un po’ a caso, comincio da Charles Burns e dal suo “Black Hole”, edito per la prima volta da noi tra il 2003 e il 2004 per l’editore Coconino. Si tratta, almeno nella prima edizione, di tre volumi di grande formato e tavole interne in bianco e nero. Burns, lo deduco dalla lunga intervista in fondo al terzo volume fatta dall’editore, viene dall’underground americano, si è formato sulle tavole di riviste come “Mad”, o nella nostalgia dei fumetti della EC; a queste suggestioni unisce letture che spaziano da Tintin, i supereroi, fino l’esperienza maturata sulla rivista “Raw” di Art Spiegelman e tanta gavetta nell’underground di Seattle (con un’esperienza anche in Italia, negli anni ’80, con Carpentieri, Igort, Tamburini, ecc). “Black Hole” ha una trama polifonica che sembra pescare anche dalla soap opera alla “Twin Peaks”, ma le assonanze con Lynch sono tante e numerose, non solo dal punto di vista narrativo. Burns ha un segno grafico nitido e pulitissimo, capace di disegnare nudi femminili stupefacenti e mai volgari. La storia e i disegni costruiscono con precisione un’America probabilmente fine anni ‘70, con hippy, ex hippy, capelloni, adolescenti confusi e malinconici, stonati dalla droga, dalle ultime esperienze comunitarie e fricchettone e ormai assorbiti in una scuola superiore anonima e pulitina, ormai prossima a quella digitalizzata e incolore di oggi. Tra storie d’amore che nascono e prime delusioni sentimentali, Burns insinua tra le bellissime tavole (credo sia il disegnatore che più mi ha colpito e fatto innamorare di un nuovo modo di concepire il fumetto, lontano dagli standard bonelliani, ma altrettanto lontano dagli istinti puttaneschi ed esagerati del pornofumetto italiano degli anni ’70) un’inquietudine spesso non spiegata, lasciando in sospeso molte delle vicende che racconta. In breve, un virus sconosciuto, che si trasmette per via sessuale, sta contagiando i giovani adolescenti di una cittadina che ricorda molto la Seattle boscosa dell’autore.  Il virus trasforma psicologicamente e fisicamente i ragazzi, facendo esplodere le loro insicurezze e le loro fragilità, costringendo i contagiati a rifugiarsi nei silenzi della foresta, in luoghi impenetrabili e attinti da un’energia quasi cosmica. Tra le tavole di questo autore americano aleggia una sorta di sortilegio mai veramente disvelato, un fantastico quotidiano molto prossimo al mondo consumistico degli anni ’80 e alle sue trasformazioni socio-economiche. Burns inizia a disegnare questa epopea nel 1991 e completa il lavoro solo nel 2003, in coincidenza con la bella traduzione italiana approntata da Elena Fattoretto e la cura certosina di tutta la Coconino Press. “Black Hole” scorre via tra le dita lasciando un senso di incompletezza e fragilità, la sensazione stonata che ci sia stato detto qualcosa di troppo intimo e personale perché potessimo capirlo. In quella tristezza, in quegli intensi momenti di gioia e libertà inseguiti dai giovani protagonisti della vicenda (mai intaccati dalla presenza degli adulti, quasi a voler sottolineare un universo alternativo e in opposizione ai valori predefiniti e standard dei grandi), sembra di ritrovare pillole perdute di ciò che ognuno di noi è stato davanti all’incertezza del primo rapporto sessuale e alle paure e le conseguenze dello stesso. Il sesso, mai volgare o sbandierato, di “Black Hole” è un virus disgregante, un palpitare cellulare di emoglobina, foglie e schegge di vetro; c’è tra le bellissime tavole di questo capolavoro (letterario in tutto e per tutto, superiore a qualunque scemenza propinata da Stephen King o dai suoi sodali) quasi un sentimento di riflusso, un ripiegamento nella sfera personale che mi ricorda gli anni di plastica, i nostri ’80, quando i protagonisti della stagione dei movimenti evaporano dinanzi a nuove generazioni disincantate da qualunque ideologia e imbevuti di una generale sfiducia nell’impegno politico e sociale. I giovani protagonisti di “Black Hole” sono appartenenti in fuga di un ceto medio prigioniero di un rampantismo e un edonismo che nel fumetto si percepisce appena.
Il virus trasforma psicologicamente e fisicamente i ragazzi, facendo esplodere le loro insicurezze e le loro fragilità, costringendo i contagiati a rifugiarsi nei silenzi della foresta, in luoghi impenetrabili e attinti da un’energia quasi cosmica. Tra le tavole di questo autore americano aleggia una sorta di sortilegio mai veramente disvelato, un fantastico quotidiano molto prossimo al mondo consumistico degli anni ’80 e alle sue trasformazioni socio-economiche. Burns inizia a disegnare questa epopea nel 1991 e completa il lavoro solo nel 2003, in coincidenza con la bella traduzione italiana approntata da Elena Fattoretto e la cura certosina di tutta la Coconino Press. “Black Hole” scorre via tra le dita lasciando un senso di incompletezza e fragilità, la sensazione stonata che ci sia stato detto qualcosa di troppo intimo e personale perché potessimo capirlo. In quella tristezza, in quegli intensi momenti di gioia e libertà inseguiti dai giovani protagonisti della vicenda (mai intaccati dalla presenza degli adulti, quasi a voler sottolineare un universo alternativo e in opposizione ai valori predefiniti e standard dei grandi), sembra di ritrovare pillole perdute di ciò che ognuno di noi è stato davanti all’incertezza del primo rapporto sessuale e alle paure e le conseguenze dello stesso. Il sesso, mai volgare o sbandierato, di “Black Hole” è un virus disgregante, un palpitare cellulare di emoglobina, foglie e schegge di vetro; c’è tra le bellissime tavole di questo capolavoro (letterario in tutto e per tutto, superiore a qualunque scemenza propinata da Stephen King o dai suoi sodali) quasi un sentimento di riflusso, un ripiegamento nella sfera personale che mi ricorda gli anni di plastica, i nostri ’80, quando i protagonisti della stagione dei movimenti evaporano dinanzi a nuove generazioni disincantate da qualunque ideologia e imbevuti di una generale sfiducia nell’impegno politico e sociale. I giovani protagonisti di “Black Hole” sono appartenenti in fuga di un ceto medio prigioniero di un rampantismo e un edonismo che nel fumetto si percepisce appena.
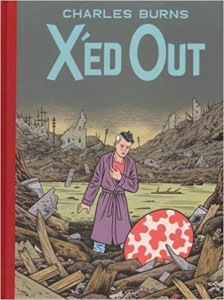 Su tematiche simili l’autore sarebbe tornato con l’opera successiva, ancora divisa in tre volumi, “X’Ed Out”, “The Hive” e “Sugar Skull”, edite in italiano da Rizzoli Lizard. Questa volta però Burns costruisce un romanzo che poco aggiunge al lavoro precedente; si tratta di una storia monocorde e depressiva, oltre che banale (i soliti ambienti alternativi anni ’80, umanità varia di tossici, artisti da strapazzo, musicisti e un tizio che si innamora di una tizia e viene massacrato di botte dall’ex violento di lei, decidendo così di mollarla e sparire per anni, senza curarsi del bambino che lei sta aspettando).
Su tematiche simili l’autore sarebbe tornato con l’opera successiva, ancora divisa in tre volumi, “X’Ed Out”, “The Hive” e “Sugar Skull”, edite in italiano da Rizzoli Lizard. Questa volta però Burns costruisce un romanzo che poco aggiunge al lavoro precedente; si tratta di una storia monocorde e depressiva, oltre che banale (i soliti ambienti alternativi anni ’80, umanità varia di tossici, artisti da strapazzo, musicisti e un tizio che si innamora di una tizia e viene massacrato di botte dall’ex violento di lei, decidendo così di mollarla e sparire per anni, senza curarsi del bambino che lei sta aspettando).
Meglio allora andare alle radici dell’arte grafica di questo grande artista, grazie a due volumi editati da Oblomov – La nave di Teseo nel 2018: parlo di “Skin Deep” (raccolta di storie brevi pubblicate in originale tra il 1988 e il 1991) e la raccolta delle avventure di “El Borbah”, pubblicate in origine su varie riviste di fumetti degli anni ’80 (Raw, Alter Alter, Hard-Boiled Detective Stories): “El Borbah” è un omaggio alla letteratura hard boiled e ai lottatori di wrestling messicani, miscelati in storie brevi e fulminanti che descrivono una suburra popolata di tossici, scienziati pazzi, spacciatori e donne fatali pronte a seminare morti; l’ironia, qui pungente ed efficacissima di Burns, è lontana anni luce dalle malinconie adolescenziali di “Black Hole” e sembra ricordare il mondo post-umano descritto da Stefano Tamburini per il primo Ranxerox pubblicato su “Cannibale” e disegnato dal medesimo Tamburini con la collaborazione di Tanino Liberatore e Andrea Pazienza).
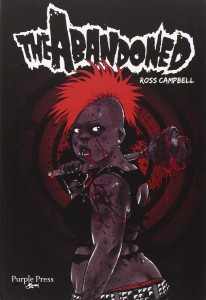 Qualche anno dopo, nel 2008, l’editore di fumetti Purple Press edita “The Abandoned” del fumettista americano Ross Campbell (giovane illustratore e autore per Oni Press e DC Comics). L’opera originale, tradotta dall’inglese da Micol Arianna Beltramini, è del 2006. Ho sempre cercato di capire se i libri di Tiziano Sclavi siano mai stati tradotti in inglese, in particolare “Dellamorte Dellamore”, uno dei suoi ultimi lavori, scritto nel 1983 e lasciato nel cassetto fino al 1991, quando viene pubblicato in edizione rilegata (con tavole aggiunte di Angelo Stano) da Camunia (ma una prima versione del libro la si era potuta leggere nel luglio del 1989 con l’uscita del terzo speciale estivo di Dylan Dog, Orrore nero, sorta di ripescaggio del romanzo del 1983). Dico questo perché in “The Abandoned” i richiami al libro di Sclavi sono molto forti. Anche Campbell divide la storia in capitoli narrativi preceduti da una piccola poesia dai delicati toni oltretombali, inoltre la cittadina americana in cui è ambientata la storia si chiama proprio Buffalora e la cosa pare un po’ troppo strana per essere una coincidenza. Anche “The Abandoned” è una meravigliosa graphic novel di zombi, un racconto dolente e malinconico non dissimile dalla malinconia dell’autore di Pavia. Campbell ha un tratto che ricorda molto lo stile manga e racconta di un gruppo di adolescenti di questo paese del profondo sud degli Stati Uniti, un non luogo popolato di catapecchie, distributori automatici e vecchi senescenti a un passo dalla consunzione. L’aria che tira è quella di un’eterna recessione economica da cui non si uscirà più.
Qualche anno dopo, nel 2008, l’editore di fumetti Purple Press edita “The Abandoned” del fumettista americano Ross Campbell (giovane illustratore e autore per Oni Press e DC Comics). L’opera originale, tradotta dall’inglese da Micol Arianna Beltramini, è del 2006. Ho sempre cercato di capire se i libri di Tiziano Sclavi siano mai stati tradotti in inglese, in particolare “Dellamorte Dellamore”, uno dei suoi ultimi lavori, scritto nel 1983 e lasciato nel cassetto fino al 1991, quando viene pubblicato in edizione rilegata (con tavole aggiunte di Angelo Stano) da Camunia (ma una prima versione del libro la si era potuta leggere nel luglio del 1989 con l’uscita del terzo speciale estivo di Dylan Dog, Orrore nero, sorta di ripescaggio del romanzo del 1983). Dico questo perché in “The Abandoned” i richiami al libro di Sclavi sono molto forti. Anche Campbell divide la storia in capitoli narrativi preceduti da una piccola poesia dai delicati toni oltretombali, inoltre la cittadina americana in cui è ambientata la storia si chiama proprio Buffalora e la cosa pare un po’ troppo strana per essere una coincidenza. Anche “The Abandoned” è una meravigliosa graphic novel di zombi, un racconto dolente e malinconico non dissimile dalla malinconia dell’autore di Pavia. Campbell ha un tratto che ricorda molto lo stile manga e racconta di un gruppo di adolescenti di questo paese del profondo sud degli Stati Uniti, un non luogo popolato di catapecchie, distributori automatici e vecchi senescenti a un passo dalla consunzione. L’aria che tira è quella di un’eterna recessione economica da cui non si uscirà più.  Gli adulti non esistono nemmeno e quei pochi rimasti diverranno morti viventi. Solo Rylie, l’eroina sovrappeso, di colore, lesbica e punk del fumetto, e il suo gruppo di amici adolescenti, dovrà provare a sopravvivere in un regno di morti (come in Scalvi, Campbell non spiega granché cosa origini l’epidemia, conferendo al racconto un taglio sospeso, indefinito, direi stranito). “The Abandoned”, come “Dellamorte Dellamore” è una riflessione sulle paure e le ansie dell’adolescenza, sulla paura del futuro, i cambiamenti legati ai primi rapporti sentimentali importanti, il lavoro, ecc. Rylie e i suoi amici in questo non sono diversi da Francesco Dellamorte, il becchino romantico prigioniero del suo piccolo mondo antico, nascosto tra le lapidi e i teschi di plastica del suo piccolo cimitero di campagna. Dopotutto, le ansie di questo fumetto mi hanno rimandato alle mie ansie di tardo adolescente italiano, terrorizzato all’idea di entrare in un mondo del lavoro dai contorni sempre più para-schiavistici e asettici, un gigantesco non luogo iperreale in cui smarrirsi. Era la prima metà degli anni Zero, il centrosinistra aveva riportato una risicata vittoria sullo schieramento di Berlusconi, ma sarebbe durato poco, perché già nel 2008 Berlusconi sarebbe tornato al governo, almeno fino al 2011, quando la spaventosa bolla della crisi economica lo costrinse alle dimissioni forzate. “The Abandoned” è uno degli ultimi fumetti di zombi classici, una vicenda sentimentale e intimistica che guarda a Romero (per il modello narrativo dell’assedio de “La notte dei morti viventi”, o per il bisogno di rifornirsi di cibo, le incursioni dei protagonisti in un minimarket) e a Sclavi (per il luogo chiuso, per l’idea di una apocalisse tascabile – lontana dalle abrasioni sociali di tanto King o di Robert Kirkman e del suo “The Walking Dead” fumetto e serie Tv – per il sapore adolescenziale del tutto, la paura di crescere, di sbloccarsi dei vari personaggi, prigionieri del loro piccolo mondo antico, delle loro fragilità) di cui probabilmente Campbell aveva come modello la versione cinematografica del libro; infatti la pellicola di Soavi uscì negli USA nell’aprile del 1996, col titolo “Cemetery man”), anticipando l’imminente moda dilagante di questo tipo di narrazioni apocalittiche, plausibili trasposizioni delle ansie economiche e sociali di un mondo occidentale globalizzato; per rimanere al mio paese, alla mia Buffalora, quando Ross Campbell pubblicava per la TokyoPop Inc. il suo fumetto, da noi, nel 2006, vinse per un pugno di voti l’Unione di Romano Prodi. Poi tornò Berlusconi, poi l’economia mondiale e nazionale inciampò sull’orlo di un baratro.
Gli adulti non esistono nemmeno e quei pochi rimasti diverranno morti viventi. Solo Rylie, l’eroina sovrappeso, di colore, lesbica e punk del fumetto, e il suo gruppo di amici adolescenti, dovrà provare a sopravvivere in un regno di morti (come in Scalvi, Campbell non spiega granché cosa origini l’epidemia, conferendo al racconto un taglio sospeso, indefinito, direi stranito). “The Abandoned”, come “Dellamorte Dellamore” è una riflessione sulle paure e le ansie dell’adolescenza, sulla paura del futuro, i cambiamenti legati ai primi rapporti sentimentali importanti, il lavoro, ecc. Rylie e i suoi amici in questo non sono diversi da Francesco Dellamorte, il becchino romantico prigioniero del suo piccolo mondo antico, nascosto tra le lapidi e i teschi di plastica del suo piccolo cimitero di campagna. Dopotutto, le ansie di questo fumetto mi hanno rimandato alle mie ansie di tardo adolescente italiano, terrorizzato all’idea di entrare in un mondo del lavoro dai contorni sempre più para-schiavistici e asettici, un gigantesco non luogo iperreale in cui smarrirsi. Era la prima metà degli anni Zero, il centrosinistra aveva riportato una risicata vittoria sullo schieramento di Berlusconi, ma sarebbe durato poco, perché già nel 2008 Berlusconi sarebbe tornato al governo, almeno fino al 2011, quando la spaventosa bolla della crisi economica lo costrinse alle dimissioni forzate. “The Abandoned” è uno degli ultimi fumetti di zombi classici, una vicenda sentimentale e intimistica che guarda a Romero (per il modello narrativo dell’assedio de “La notte dei morti viventi”, o per il bisogno di rifornirsi di cibo, le incursioni dei protagonisti in un minimarket) e a Sclavi (per il luogo chiuso, per l’idea di una apocalisse tascabile – lontana dalle abrasioni sociali di tanto King o di Robert Kirkman e del suo “The Walking Dead” fumetto e serie Tv – per il sapore adolescenziale del tutto, la paura di crescere, di sbloccarsi dei vari personaggi, prigionieri del loro piccolo mondo antico, delle loro fragilità) di cui probabilmente Campbell aveva come modello la versione cinematografica del libro; infatti la pellicola di Soavi uscì negli USA nell’aprile del 1996, col titolo “Cemetery man”), anticipando l’imminente moda dilagante di questo tipo di narrazioni apocalittiche, plausibili trasposizioni delle ansie economiche e sociali di un mondo occidentale globalizzato; per rimanere al mio paese, alla mia Buffalora, quando Ross Campbell pubblicava per la TokyoPop Inc. il suo fumetto, da noi, nel 2006, vinse per un pugno di voti l’Unione di Romano Prodi. Poi tornò Berlusconi, poi l’economia mondiale e nazionale inciampò sull’orlo di un baratro.  Seguì la coalizione di Bersani, il governo Letta, quello Renzi (che eliminò per i nuovi assunti l’articolo 18 dello Statuto del Lavoratori), fino alla frantumazione completa del mercato del lavoro e alle profezie (tutte avverate) di Jeff Bezos e di un virtuale negozio mondiale. Sarò fissato, per carità non voglio aver ragione a tutti i costi, ma i poveri zombi caracollanti di Campbell, così come i suoi dolenti e confusi adolescenti, somigliano tanto a un mondo di non vivi e non morti schiacciati dal peso di una produttività che ormai non ha più nulla di umano, annullati da giornate sempre uguali, scandite dai movimenti cronometrati dagli algoritmi del lavoro interinale. Uomini e donne con la mente svuotata, annullata dall’assenza di una via d’uscita dai reparti di un qualche lager lavorativo. Il tutto sullo sfondo di un paese che si è lasciato alle spalle tutto, l’operosità degli anni del dopoguerra, le migrazioni interne, le violenze e le rivendicazioni, la speranza e le ambizioni, lasciandosi andare nelle comode sacche di una palude descritta nei più minimi dettagli da Luca Ricolfi ne “La società signorile di massa” (La nave di Teseo, 2019); una palude di gente che non lavora, trascorre fine settimana in villeggiatura nelle spa, invade le spiagge della penisola, invade i ristoranti, gli outlet, i locali all’ultima moda, una società opulenta che ha smesso di crescere e divora se stessa e i beni accumulati in attesa di una catastrofe sempre rimandata a domani…
Seguì la coalizione di Bersani, il governo Letta, quello Renzi (che eliminò per i nuovi assunti l’articolo 18 dello Statuto del Lavoratori), fino alla frantumazione completa del mercato del lavoro e alle profezie (tutte avverate) di Jeff Bezos e di un virtuale negozio mondiale. Sarò fissato, per carità non voglio aver ragione a tutti i costi, ma i poveri zombi caracollanti di Campbell, così come i suoi dolenti e confusi adolescenti, somigliano tanto a un mondo di non vivi e non morti schiacciati dal peso di una produttività che ormai non ha più nulla di umano, annullati da giornate sempre uguali, scandite dai movimenti cronometrati dagli algoritmi del lavoro interinale. Uomini e donne con la mente svuotata, annullata dall’assenza di una via d’uscita dai reparti di un qualche lager lavorativo. Il tutto sullo sfondo di un paese che si è lasciato alle spalle tutto, l’operosità degli anni del dopoguerra, le migrazioni interne, le violenze e le rivendicazioni, la speranza e le ambizioni, lasciandosi andare nelle comode sacche di una palude descritta nei più minimi dettagli da Luca Ricolfi ne “La società signorile di massa” (La nave di Teseo, 2019); una palude di gente che non lavora, trascorre fine settimana in villeggiatura nelle spa, invade le spiagge della penisola, invade i ristoranti, gli outlet, i locali all’ultima moda, una società opulenta che ha smesso di crescere e divora se stessa e i beni accumulati in attesa di una catastrofe sempre rimandata a domani…
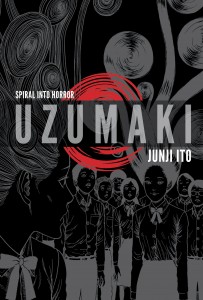 Di poco precedente è il manga “Uzumaki” di Junji Ito, sorta di Stephen King mangaka. “Uzumaki” è un fumetto torrenziale (di oltre 600 pagine, divise in due volumi pubblicati dalla STAR Comics nel maggio del 2018), uscito in patria su “Big Comic Spirits”, tra il 1998 e il 2000). Junji Ito è uno degli autori più noti e tradotti anche da noi; ha debuttato su “Monthly Halloween” dell’editore Sonorama nel 1986 e ha scritto e disegnato numerosi manga di successo. “Uzumaki” è stato (parzialmente) trasposto anche in una pellicola dal medesimo titolo del 2000. Il manga attinge a piene mani dalla tradizione del fumetto giapponese, ma anche da autori come Lovecraft, oltre che una certa aria stranita che rimanda a certo Lynch o a derive body horror dal sapore anni ’80. La trama: un paesino del Giappone, Kurouzu, inventato dall’autore, precipita in un gorgo senza fine di follia; i suoi abitanti incominciano ad impazzire uno a uno, ossessionati da qualunque oggetto con la forma di una spirale. Attraverso lo sguardo dolce e rassicurante di Kirie, giovane studentessa delle superiori nata e cresciuta a Kurouzu, Ito dipana una vicenda lunga e articolata, un manga horror attraversato da pulsioni anarcoidi e critica sociale del Giappone moderno, sorta di apologo distruttivo su cosa potrebbe accadere quando le persone diventano succubi delle spirali, ossia della forza disumanizzante del capitale e del capitalismo più spinto e disaggregante (e qui, in anticipo di oltre dieci anni, “Uzumaki” sembra in alcuni momenti prefigurare le lotte intestine tra le varie piccole comunità agricole sopravvissute all’apocalisse di “The Walking Dead”).
Di poco precedente è il manga “Uzumaki” di Junji Ito, sorta di Stephen King mangaka. “Uzumaki” è un fumetto torrenziale (di oltre 600 pagine, divise in due volumi pubblicati dalla STAR Comics nel maggio del 2018), uscito in patria su “Big Comic Spirits”, tra il 1998 e il 2000). Junji Ito è uno degli autori più noti e tradotti anche da noi; ha debuttato su “Monthly Halloween” dell’editore Sonorama nel 1986 e ha scritto e disegnato numerosi manga di successo. “Uzumaki” è stato (parzialmente) trasposto anche in una pellicola dal medesimo titolo del 2000. Il manga attinge a piene mani dalla tradizione del fumetto giapponese, ma anche da autori come Lovecraft, oltre che una certa aria stranita che rimanda a certo Lynch o a derive body horror dal sapore anni ’80. La trama: un paesino del Giappone, Kurouzu, inventato dall’autore, precipita in un gorgo senza fine di follia; i suoi abitanti incominciano ad impazzire uno a uno, ossessionati da qualunque oggetto con la forma di una spirale. Attraverso lo sguardo dolce e rassicurante di Kirie, giovane studentessa delle superiori nata e cresciuta a Kurouzu, Ito dipana una vicenda lunga e articolata, un manga horror attraversato da pulsioni anarcoidi e critica sociale del Giappone moderno, sorta di apologo distruttivo su cosa potrebbe accadere quando le persone diventano succubi delle spirali, ossia della forza disumanizzante del capitale e del capitalismo più spinto e disaggregante (e qui, in anticipo di oltre dieci anni, “Uzumaki” sembra in alcuni momenti prefigurare le lotte intestine tra le varie piccole comunità agricole sopravvissute all’apocalisse di “The Walking Dead”).  Tuttavia, il tema di fondo mi pare ancora quello della postmodernità; “Uzumaki” scava nel quotidiano, lo fa esplodere, ne esplora l’immondizia, le contraddizioni e le ansie, perché ormai la paura, a un passo dagli anni 0, è una merce come un’altra, buona per titillare i nervi, farci saltare sulla sedia, un viagra cardiaco per risvegliarci brevemente dal surplus di sicurezze e di protezioni anestetizzanti della società frantumata in cui viviamo. Le paure di “Uzumaki”, più che dai mostri repellenti, scaturiscono dalla banalità di un’esistenza in cui le identità collettive si fanno sempre più incerte e labili…
Tuttavia, il tema di fondo mi pare ancora quello della postmodernità; “Uzumaki” scava nel quotidiano, lo fa esplodere, ne esplora l’immondizia, le contraddizioni e le ansie, perché ormai la paura, a un passo dagli anni 0, è una merce come un’altra, buona per titillare i nervi, farci saltare sulla sedia, un viagra cardiaco per risvegliarci brevemente dal surplus di sicurezze e di protezioni anestetizzanti della società frantumata in cui viviamo. Le paure di “Uzumaki”, più che dai mostri repellenti, scaturiscono dalla banalità di un’esistenza in cui le identità collettive si fanno sempre più incerte e labili…
 Nel 2015, Robert Kirkman (sceneggiatore e creatore della serie a fumetti “The Walking Dead”) propone nella collana “Skybound” della Image Comics la nuova serie horror “Outcast” (da noi prontamente tradotta da Saldapress già nell’aprile del 2016 in brossura e in edizione cartonata): i disegni sono di Paul Azaceta, i colori di Elisabeth Breitweiser. “Outcast” è una storia molto innovativa, che riscrive i canoni della possessione demoniaca, seguendo le avventure di Kyle Barnes, giovane disadattato di un piccolo paese del West Virginia, e del reverendo Anderson. I due si trovano a fronteggiare i demoni del loro passato (la madre di Kyle, in seguito a un tremendo esorcismo è ridotta come un vegetale in un letto) e una nuova serie di strani casi di possessioni; individui all’apparenza normali che non manifestano i sintomi isterici a cui ci ha abituato il cinema horror degli anni ‘70, ma che si integrano e si mescolano agli altri abitanti. Si tratta di un’invasione silenziosa di anime dannate? Qual è il loro scopo? Kirkman e Azaceta costruiscono un fumetto crudo e compatto, molto atmosferico, immergendo i loro personaggi in un’America da crisi permanente, un misero non luogo di supermercati solitari, stazioni di rifornimento, case e locali in rarefazione, insegne luminose nelle strade buie e silenziose, poveri, disoccupati di massa, dissanguamento economico e demografico.
Nel 2015, Robert Kirkman (sceneggiatore e creatore della serie a fumetti “The Walking Dead”) propone nella collana “Skybound” della Image Comics la nuova serie horror “Outcast” (da noi prontamente tradotta da Saldapress già nell’aprile del 2016 in brossura e in edizione cartonata): i disegni sono di Paul Azaceta, i colori di Elisabeth Breitweiser. “Outcast” è una storia molto innovativa, che riscrive i canoni della possessione demoniaca, seguendo le avventure di Kyle Barnes, giovane disadattato di un piccolo paese del West Virginia, e del reverendo Anderson. I due si trovano a fronteggiare i demoni del loro passato (la madre di Kyle, in seguito a un tremendo esorcismo è ridotta come un vegetale in un letto) e una nuova serie di strani casi di possessioni; individui all’apparenza normali che non manifestano i sintomi isterici a cui ci ha abituato il cinema horror degli anni ‘70, ma che si integrano e si mescolano agli altri abitanti. Si tratta di un’invasione silenziosa di anime dannate? Qual è il loro scopo? Kirkman e Azaceta costruiscono un fumetto crudo e compatto, molto atmosferico, immergendo i loro personaggi in un’America da crisi permanente, un misero non luogo di supermercati solitari, stazioni di rifornimento, case e locali in rarefazione, insegne luminose nelle strade buie e silenziose, poveri, disoccupati di massa, dissanguamento economico e demografico.  L’inferno di Kirkman sembra già qui, ora, sulla terra, quasi che i fantasmi e i demoni siano legati al fallimento individuale di conformarsi ai sogni oscuri del capitalismo di massa, all’incapacità di godere dei benefici illimitati del consumo. Gli anti-eroi di Kirkman sono disillusi e solitari, tormentati e fragili, simili ai loro corrispettivi nel serial apocalittico di “The Walking Dead”, altra grande parabola contemporanea della civiltà urbana. “Outcast” è un grande horror rurale su una società in declino, demograficamente e amministrativamente assottigliata, priva di servizi pubblici, assistenziali, pulizia delle strade, degrado, gang e reietti nelle strade. Un senso di collasso e sconfitta si respira in ogni tavola e nemmeno la parola di Dio (o le consuete tecniche di esorcismo) sembrano avere alcun effetto. In fondo anche “Outcast” parla di un’apocalisse, solo di un’apocalisse al rallentatore, di cui nessuno si è accorto; i posseduti prefigurano l’avvento di un nuovo mondo e un capovolgimento dei fronti, infatti con l’andare dei numeri le cose prendono una piega inaspettata e nella cittadina di Rome (ideale non luogo della West Virginia della saga gotica e rurale di Kirkman & Azaceta) sono i non posseduti a doversi rifugiare nella campagna e nei boschi e lasciare ai reincarnati (così vengono denominati gli individui posseduti, in cui ancora sopravvivono barlumi di ricordi dell’esistenza umana) il controllo della società.
L’inferno di Kirkman sembra già qui, ora, sulla terra, quasi che i fantasmi e i demoni siano legati al fallimento individuale di conformarsi ai sogni oscuri del capitalismo di massa, all’incapacità di godere dei benefici illimitati del consumo. Gli anti-eroi di Kirkman sono disillusi e solitari, tormentati e fragili, simili ai loro corrispettivi nel serial apocalittico di “The Walking Dead”, altra grande parabola contemporanea della civiltà urbana. “Outcast” è un grande horror rurale su una società in declino, demograficamente e amministrativamente assottigliata, priva di servizi pubblici, assistenziali, pulizia delle strade, degrado, gang e reietti nelle strade. Un senso di collasso e sconfitta si respira in ogni tavola e nemmeno la parola di Dio (o le consuete tecniche di esorcismo) sembrano avere alcun effetto. In fondo anche “Outcast” parla di un’apocalisse, solo di un’apocalisse al rallentatore, di cui nessuno si è accorto; i posseduti prefigurano l’avvento di un nuovo mondo e un capovolgimento dei fronti, infatti con l’andare dei numeri le cose prendono una piega inaspettata e nella cittadina di Rome (ideale non luogo della West Virginia della saga gotica e rurale di Kirkman & Azaceta) sono i non posseduti a doversi rifugiare nella campagna e nei boschi e lasciare ai reincarnati (così vengono denominati gli individui posseduti, in cui ancora sopravvivono barlumi di ricordi dell’esistenza umana) il controllo della società. 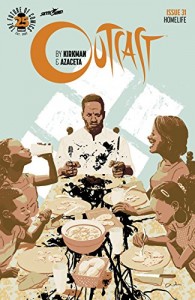 Insomma, “Outcast” comincia per assomigliare a certe riflessioni di “The Walking Dead” e il confine tra il bene e il male diventa difficile da cogliere; splendidi i numeri in cui (dal 31 al 36 della serie regolare americana) Kyle Barnes e il reverendo Anderson (sempre più fuori controllo, accecato da una fede cieca e incrollabile, quasi un Jim Jones dell’esercito di Cristo) aggregano intorno a sé una nuova comunità di fedeli, quasi un nuovo credo, una nuova fede che prega sotto i tendoni di una sorta di chiesa itinerante che fa molto southern gotic, presa poi d’assedio dalla polizia, in un geniale ribaltamento dei ruoli in cui i “buoni” (o quelli che si presume dovrebbero esserlo) sono socialmente emarginati, considerati come una setta religiosa di invasati, ultimo baluardo a un mondo ormai posseduto da demoni individualisti, nuovi bravi cittadini che “apericenano”, trascorrono splendidi fine settimana in villeggiatura, forse se ne andranno pure a Cortina o a invadere le spiagge, protetti dalle loro famiglie, dalle case di proprietà accumulate dai loro predecessori, abbastanza liberi dal lavoro (o liberi del tutto) per dedicarsi al proprio corpo, alle spa, ai centrimassaggi, liberi anche da qualunque dubbio esistenziale (e per quelli poi basterebbe qualche farmaco). Un altro elemento che rende “Outcast” una delle migliori serie horror in circolazione è Elizabeth Breitweiser, la colorista della serie, dotata di un dono innato. Le tavole brillano sotto le sue luci “emotive” e in molti momenti della serie raggiungono livelli visivi d’impensabile sintesi grafica, bellezza e originalità.
Insomma, “Outcast” comincia per assomigliare a certe riflessioni di “The Walking Dead” e il confine tra il bene e il male diventa difficile da cogliere; splendidi i numeri in cui (dal 31 al 36 della serie regolare americana) Kyle Barnes e il reverendo Anderson (sempre più fuori controllo, accecato da una fede cieca e incrollabile, quasi un Jim Jones dell’esercito di Cristo) aggregano intorno a sé una nuova comunità di fedeli, quasi un nuovo credo, una nuova fede che prega sotto i tendoni di una sorta di chiesa itinerante che fa molto southern gotic, presa poi d’assedio dalla polizia, in un geniale ribaltamento dei ruoli in cui i “buoni” (o quelli che si presume dovrebbero esserlo) sono socialmente emarginati, considerati come una setta religiosa di invasati, ultimo baluardo a un mondo ormai posseduto da demoni individualisti, nuovi bravi cittadini che “apericenano”, trascorrono splendidi fine settimana in villeggiatura, forse se ne andranno pure a Cortina o a invadere le spiagge, protetti dalle loro famiglie, dalle case di proprietà accumulate dai loro predecessori, abbastanza liberi dal lavoro (o liberi del tutto) per dedicarsi al proprio corpo, alle spa, ai centrimassaggi, liberi anche da qualunque dubbio esistenziale (e per quelli poi basterebbe qualche farmaco). Un altro elemento che rende “Outcast” una delle migliori serie horror in circolazione è Elizabeth Breitweiser, la colorista della serie, dotata di un dono innato. Le tavole brillano sotto le sue luci “emotive” e in molti momenti della serie raggiungono livelli visivi d’impensabile sintesi grafica, bellezza e originalità.
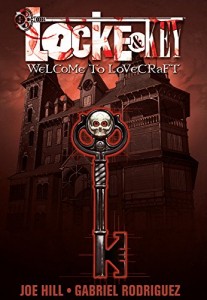 Interessante anche la saga americana di “Locke & Key”, scritta da Joe Hill (il figlio di Stephen King, ndr) e disegnata da un ispiratissimo Gabriel Rodriguez; si tratta di una lunga storia a fumetti (pubblicata in originale nel 2009 e tradotta da noi da Magic Press nel 2016 in sette volumi) che mescola horror e fantasy, omaggiando l’universo onirico del primo e più intimistico Lovecraft (in particolare quello de “La chiave d’argento”, racconto del 1926 sulla ricerca struggente delle visioni e dei sogni dell’adolescenza, contrapposti all’aridità del mondo adulto), fino ai film di Lucio Fulci o all’universo onirico di autori come Gaiman, Morrison ed Ennis. La storia di “Locke & Key” segue le peripezie di una famiglia americana passata attraverso un terribile lutto e decisa a tornare a vivere nella cittadina di Lovecraft, in una vecchia magione gotica popolata di ombre e creature mentali, piena di corridoi e porte aperte sul passato e antri popolati da creature malvagie. Ogni componente della famiglia dovrà confrontarsi con le proprie paure e i propri demoni, senza perdere appunto quello sguardo da sognatore fantastico di cui parlava proprio Lovecraft. Hill è uno scrittore attento e calibrato, capace di costruire personaggi verosimili e interessanti, e ha un’attenzione geografica per un Massachusetts che oscilla tra un luogo della fantasia e uno reale; comunque Hill recupera anche la lezione paterna di Stephen King, rimandando neanche troppo alla lontana alla polifonia narrativa di “It” e a una storia costruita su un arco di tempo che coinvolge più generazioni e rimarca il bisogno di preservare i sogni dell’adolescenza dalle crudeltà della vita adulta.
Interessante anche la saga americana di “Locke & Key”, scritta da Joe Hill (il figlio di Stephen King, ndr) e disegnata da un ispiratissimo Gabriel Rodriguez; si tratta di una lunga storia a fumetti (pubblicata in originale nel 2009 e tradotta da noi da Magic Press nel 2016 in sette volumi) che mescola horror e fantasy, omaggiando l’universo onirico del primo e più intimistico Lovecraft (in particolare quello de “La chiave d’argento”, racconto del 1926 sulla ricerca struggente delle visioni e dei sogni dell’adolescenza, contrapposti all’aridità del mondo adulto), fino ai film di Lucio Fulci o all’universo onirico di autori come Gaiman, Morrison ed Ennis. La storia di “Locke & Key” segue le peripezie di una famiglia americana passata attraverso un terribile lutto e decisa a tornare a vivere nella cittadina di Lovecraft, in una vecchia magione gotica popolata di ombre e creature mentali, piena di corridoi e porte aperte sul passato e antri popolati da creature malvagie. Ogni componente della famiglia dovrà confrontarsi con le proprie paure e i propri demoni, senza perdere appunto quello sguardo da sognatore fantastico di cui parlava proprio Lovecraft. Hill è uno scrittore attento e calibrato, capace di costruire personaggi verosimili e interessanti, e ha un’attenzione geografica per un Massachusetts che oscilla tra un luogo della fantasia e uno reale; comunque Hill recupera anche la lezione paterna di Stephen King, rimandando neanche troppo alla lontana alla polifonia narrativa di “It” e a una storia costruita su un arco di tempo che coinvolge più generazioni e rimarca il bisogno di preservare i sogni dell’adolescenza dalle crudeltà della vita adulta.
 Altra cosa “Il vampiro che ride” di Suehiro Maruo, autore di manga fantastico-horror, pubblicato in due volumi (e per la prima volta in edizione integrale rispetto alla prima edizione di alcuni anni fa) da Coconino nell’ottobre del 2014; l’opera originale è stata pubblicata a puntate su “Young champion” a partire dal 1998. Si tratta di un manga che mescola demoni centenari assetati di sangue, con studentesse delle scuole medie che si prostituiscono con vecchi laidi, gang giovanili dedite a droga e violenze, onanismo necrofilo e l’ombra disturbante e pedofila di Pogo il clown, sorta di omaggio onirico a un universo malato e grottesco che Maruo spinge fino al limite della sopportabilità, il tutto in un Giappone moderno e dissacrato su cui pesa ancora l’ombra apocalittica delle esplosioni atomiche e le alterazioni genetiche. Maruo costruisce un’opera grafica di grande impatto che, fin dalla meravigliosa copertina del primo volume Coconino, sembra rimandare ai brividi erotici di tanti pornofumetti dell’orrore italiani degli anni ’70; Maruo gioca coi medesimi elementi, mescolando terrore e sesso, esplorando qualunque tipo di perversione o desiderio e calcando la mano sullo splatter e il cattivo gusto, forse senza quell’ironia un po’ ignorante e fine a se stessa dei tascabili italiani. Ne esce un fumetto raro, forse non per tutti i palati, capace comunque di rileggere una figura assai inflazionata come quella del vampiro e della vampira, qui recuperati dalla tradizione occidentale dei vari Jacula e Oltretomba. Notevole poi la cura editoriale della Coconino, l’adattamento e la traduzione, con le onomatopee e gli ideogrammi mantenuti nella versione originale. Il secondo voluminoso volume continua a raccontare le peripezie sanguinarie dei due vampiri adolescenti Luna e Konosuke, arricchendo ulteriormente una saga manga horror che vuole fare da ponte tra la cultura giapponese e quella occidentale. Maruo infatti si rifà più volte a certo cinema horror americano, omaggiando direttamente il “Dracula” di Browning o il “Phantom of the Opera” di Lon Chaney, mescolando queste derive grafiche con sesso perverso, bondage estremo, pornografia e una poetica necrofila piuttosto insistita e compiaciuta.
Altra cosa “Il vampiro che ride” di Suehiro Maruo, autore di manga fantastico-horror, pubblicato in due volumi (e per la prima volta in edizione integrale rispetto alla prima edizione di alcuni anni fa) da Coconino nell’ottobre del 2014; l’opera originale è stata pubblicata a puntate su “Young champion” a partire dal 1998. Si tratta di un manga che mescola demoni centenari assetati di sangue, con studentesse delle scuole medie che si prostituiscono con vecchi laidi, gang giovanili dedite a droga e violenze, onanismo necrofilo e l’ombra disturbante e pedofila di Pogo il clown, sorta di omaggio onirico a un universo malato e grottesco che Maruo spinge fino al limite della sopportabilità, il tutto in un Giappone moderno e dissacrato su cui pesa ancora l’ombra apocalittica delle esplosioni atomiche e le alterazioni genetiche. Maruo costruisce un’opera grafica di grande impatto che, fin dalla meravigliosa copertina del primo volume Coconino, sembra rimandare ai brividi erotici di tanti pornofumetti dell’orrore italiani degli anni ’70; Maruo gioca coi medesimi elementi, mescolando terrore e sesso, esplorando qualunque tipo di perversione o desiderio e calcando la mano sullo splatter e il cattivo gusto, forse senza quell’ironia un po’ ignorante e fine a se stessa dei tascabili italiani. Ne esce un fumetto raro, forse non per tutti i palati, capace comunque di rileggere una figura assai inflazionata come quella del vampiro e della vampira, qui recuperati dalla tradizione occidentale dei vari Jacula e Oltretomba. Notevole poi la cura editoriale della Coconino, l’adattamento e la traduzione, con le onomatopee e gli ideogrammi mantenuti nella versione originale. Il secondo voluminoso volume continua a raccontare le peripezie sanguinarie dei due vampiri adolescenti Luna e Konosuke, arricchendo ulteriormente una saga manga horror che vuole fare da ponte tra la cultura giapponese e quella occidentale. Maruo infatti si rifà più volte a certo cinema horror americano, omaggiando direttamente il “Dracula” di Browning o il “Phantom of the Opera” di Lon Chaney, mescolando queste derive grafiche con sesso perverso, bondage estremo, pornografia e una poetica necrofila piuttosto insistita e compiaciuta.
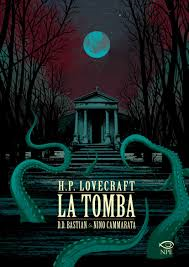 Colpisce l’interesse che un autore come H.P. Lovecraft continua a rivestire in questi ultimi anni per il mondo del fumetto professionale. In particolare l’editore Nicola Pesce ha approntato degli splendidi volumi a partire dagli 80 anni della morte del maestro delle apocalissi di Providence (a questo proposito segnalo anche il bel volume rilegato de “La Tomba” di Bastian & Cammarata, graphic novel raffinatissima e onirica ispirata a uno dei primi racconti gotici e necrofili dello scrittore americano, ancora lontano dalle derive allucinatorie e megalitiche dei racconti della maturità). In particolare segnalo il recentissimo “H.P. Lovecraft – La musica di Erich Zann e altri racconti” di D.D. Bastian e Sergio Vanello, editato da Nicola Pesce nel 2019. Si tratta di uno splendido volume cartonato e di grandi dimensioni che contiene tre storie a fumetti che esplorano le atmosfere del narratore americano, illustrando alcuni racconti poco adattati a fumetti. Una è una trasposizione assai ispirata ed espressionista di “La musica di Erich Zann”, racconto del febbraio del 1922, pubblicato prima per “The National Amateur” e poi nel 1925 per “Weird Tales”; l’altro racconto è l’insolito “Un’illustrazione e una vecchia casa”, racconto di passaggio del 1920, dove abbiamo il primo accenno alla città di Arkham e ai suoi boschi, geografia sfuggente e solitaria che lievita negli acquerelli di Sergio Vanello, resi splendidamente dalle dimensioni del volume. Il terzo racconto è una divagazione originale opera del solo Vanello; ne esce un volume originale e diverso dal solito, dove le atmosfere lovecraftiane si distanziano dai lavori precedenti di altri grandi illustratori e sembrano trovare nuove ispirazioni dalle novelle pulp di un autore verboso e lontanissimo dagli standard di oggi.
Colpisce l’interesse che un autore come H.P. Lovecraft continua a rivestire in questi ultimi anni per il mondo del fumetto professionale. In particolare l’editore Nicola Pesce ha approntato degli splendidi volumi a partire dagli 80 anni della morte del maestro delle apocalissi di Providence (a questo proposito segnalo anche il bel volume rilegato de “La Tomba” di Bastian & Cammarata, graphic novel raffinatissima e onirica ispirata a uno dei primi racconti gotici e necrofili dello scrittore americano, ancora lontano dalle derive allucinatorie e megalitiche dei racconti della maturità). In particolare segnalo il recentissimo “H.P. Lovecraft – La musica di Erich Zann e altri racconti” di D.D. Bastian e Sergio Vanello, editato da Nicola Pesce nel 2019. Si tratta di uno splendido volume cartonato e di grandi dimensioni che contiene tre storie a fumetti che esplorano le atmosfere del narratore americano, illustrando alcuni racconti poco adattati a fumetti. Una è una trasposizione assai ispirata ed espressionista di “La musica di Erich Zann”, racconto del febbraio del 1922, pubblicato prima per “The National Amateur” e poi nel 1925 per “Weird Tales”; l’altro racconto è l’insolito “Un’illustrazione e una vecchia casa”, racconto di passaggio del 1920, dove abbiamo il primo accenno alla città di Arkham e ai suoi boschi, geografia sfuggente e solitaria che lievita negli acquerelli di Sergio Vanello, resi splendidamente dalle dimensioni del volume. Il terzo racconto è una divagazione originale opera del solo Vanello; ne esce un volume originale e diverso dal solito, dove le atmosfere lovecraftiane si distanziano dai lavori precedenti di altri grandi illustratori e sembrano trovare nuove ispirazioni dalle novelle pulp di un autore verboso e lontanissimo dagli standard di oggi.
 Fedele a Lovecraft è anche il maestro Gou Tanabe, autore di un bellissimo volume della BD nella collana J-POP, parlo di “L’abitatore del buio” (2016), tascabile manga che contiene una versione del racconto “Dagon” e una magnifica versione del racconto del 1935 che dà appunto il titolo al tascabile. Tanabe rimane molto fedele al racconto originale, conferendo ai suoi disegni una grafica originalissima che oscilla tra le xilografie ottocentesche e il segno grafico del fumetto giapponese, concedendosi anche citazioni visive a certo cinema horror contemporaneo che si è misurato col maestro di Providence. Ne esce un volume in bianco e nero permeato di grigi e saturato da atmosfere soffocanti e oniriche, abitazioni fatiscenti, cattedrali aguzze e tentacoli appiccicosi, in una mescolanza che è già figlia di quel post-modernismo di tanti videogiochi lovecraftiani…
Fedele a Lovecraft è anche il maestro Gou Tanabe, autore di un bellissimo volume della BD nella collana J-POP, parlo di “L’abitatore del buio” (2016), tascabile manga che contiene una versione del racconto “Dagon” e una magnifica versione del racconto del 1935 che dà appunto il titolo al tascabile. Tanabe rimane molto fedele al racconto originale, conferendo ai suoi disegni una grafica originalissima che oscilla tra le xilografie ottocentesche e il segno grafico del fumetto giapponese, concedendosi anche citazioni visive a certo cinema horror contemporaneo che si è misurato col maestro di Providence. Ne esce un volume in bianco e nero permeato di grigi e saturato da atmosfere soffocanti e oniriche, abitazioni fatiscenti, cattedrali aguzze e tentacoli appiccicosi, in una mescolanza che è già figlia di quel post-modernismo di tanti videogiochi lovecraftiani…
Mi concedo una veloce citazione italiana alla Bonelli (nonostante tutto). Ho comprato, più per i disegni, il volume della Bao di “Mater Dolorosa”, graphic novel di Roberto Recchioni e Gigi Cavenago del 2017. Si tratta di un’edizione meticolosa di un albo della serie regolare di Dylan Dog, ripensato persino nel lettering dal gruppo della Bao e pubblicato in un formato cartonato e gigante che rende appieno merito alle splendide tavole di Cavenago. Il volume poi è arricchito da una serie di contributi filologici che illustrano la genesi della trama e delle illustrazioni. Recchioni, autore dei testi, ci ricorda il lavoro certosino per cucire insieme una serie di personaggi, situazioni e spunti da alcuni albi storici della serie regolare, evidenziando rimandi inaspettati che abbisognano di un atlante narrativo. “Mater Dolorosa” è una sorta di alfa e omega della saga regolare dell’indagatore dell’incubo, un volume che raccoglie l’eredità narrativa di Sclavi e riporta le lancette a quel numero 100 che nelle intenzioni dell’autore pavese avrebbe dovuto essere una sorta di ultimo numero. Recchioni cita sé stesso, rimandando a personaggi e situazioni di “Mater Morbi”, numero 280 della serie regolare a sua volta rieditato con cura filologica certosina da Bao Publishing. 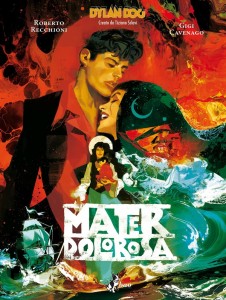 La scrittura spazia da galeoni di pirati, vascelli fantasma, madri dolorose pesantemente prese dal cinema più fantastico e puro di Argento (queste madri dolorose in corsetti di pelle nera, stivali da bucaniere, gli occhi rigati di sangue, immerse nei colori rossi e gialli di Cavenago mi fanno pensare a tutto quello che avrebbe potuto essere – e non è stato – “La terza madre” di Argento, quasi mi fanno pensare che quelle pellicole altro non siano state che un eco di queste tavole, di questi dipinti meravigliosi dispersi nei marosi di un mare perennemente in tempesta di colori), fino a micro-citazioni da alcuni momenti di “Dellamorte Dellamore” di Sclavi (Dylan Dog che vive in un mondo popolato da zombi inoffensivi e caracollanti, zombi da lui uccisi più per noia, come già faceva Francesco Dellamorte, sia nel romanzo che nel film di Soavi, che nel fumetto Speciale Dylan Dog n. 3, “Orrore nero”), o ad albi seminali della serie regolare come “Morgana”, “Storia di nessuno” e “La storia di Dylan Dog”. Su questo lavoro di taglia e cuci narrativo (a tratti affascinante, a tratti un po’ ruffiano, adolescenziale e tormentato), arrivano le tavole pittoriche e sperimentali, soprattutto nell’uso dei colori, fluidi, che inghiottono la linea dei disegni e prendono corpo in forme brillanti e sature che rompono le griglie abitudinarie della Bonelli e strabordano in delle splash page da rimirare a bocca aperta. Cavenago si dimostra un maestro indiscusso del disegno e soprattutto del colore, capace di mescolare tra loro citazioni grafiche da Klimt, Picasso, Bacon, Pinter e Karel Thole, senza dimenticare i lavori più personali di Angelo Stano e conferendo così al volume un pregio artistico di livello altissimo, forse tra le cose più belle che abbia visto in questi ultimi anni (mi riferisco in particolare alle prove finali per le copertine alternative del volume).
La scrittura spazia da galeoni di pirati, vascelli fantasma, madri dolorose pesantemente prese dal cinema più fantastico e puro di Argento (queste madri dolorose in corsetti di pelle nera, stivali da bucaniere, gli occhi rigati di sangue, immerse nei colori rossi e gialli di Cavenago mi fanno pensare a tutto quello che avrebbe potuto essere – e non è stato – “La terza madre” di Argento, quasi mi fanno pensare che quelle pellicole altro non siano state che un eco di queste tavole, di questi dipinti meravigliosi dispersi nei marosi di un mare perennemente in tempesta di colori), fino a micro-citazioni da alcuni momenti di “Dellamorte Dellamore” di Sclavi (Dylan Dog che vive in un mondo popolato da zombi inoffensivi e caracollanti, zombi da lui uccisi più per noia, come già faceva Francesco Dellamorte, sia nel romanzo che nel film di Soavi, che nel fumetto Speciale Dylan Dog n. 3, “Orrore nero”), o ad albi seminali della serie regolare come “Morgana”, “Storia di nessuno” e “La storia di Dylan Dog”. Su questo lavoro di taglia e cuci narrativo (a tratti affascinante, a tratti un po’ ruffiano, adolescenziale e tormentato), arrivano le tavole pittoriche e sperimentali, soprattutto nell’uso dei colori, fluidi, che inghiottono la linea dei disegni e prendono corpo in forme brillanti e sature che rompono le griglie abitudinarie della Bonelli e strabordano in delle splash page da rimirare a bocca aperta. Cavenago si dimostra un maestro indiscusso del disegno e soprattutto del colore, capace di mescolare tra loro citazioni grafiche da Klimt, Picasso, Bacon, Pinter e Karel Thole, senza dimenticare i lavori più personali di Angelo Stano e conferendo così al volume un pregio artistico di livello altissimo, forse tra le cose più belle che abbia visto in questi ultimi anni (mi riferisco in particolare alle prove finali per le copertine alternative del volume).
 Gli zombi, in questi ultimi dieci anni, sono diventati un fenomeno mediatico che non ha confini. Dalla cultura occidentale a quella orientale, passando anche per l’Africa. E dire che agli inizi degli anni Zero il genere sembrava ormai morto e sepolto, solo qualche film horror di seconda categoria distribuito direttamente in DVD e nulla di più. Gli editori italiani non volevano nemmeno sentire parlare della parola “zombi” (senza la “e” nella traduzione italiana) e nemmeno con un dito avrebbero toccato novelle di cotale genere (ne sa qualcosa il sottoscritto, grande fan degli zombi, che ha scritto nel 2000 e qualcosa un romanzo fiume sui morti viventi, avendo anche l’ardire di mescolarci dentro le stragi di mafia degli anni ’90, il rapimento Moro, i truschi mafiosi di Berlusconi, lottatori di wrestling amatoriale e un gruppo di adolescenti che sembravano usciti da un romanzo di Giuseppe Culicchia, il tutto condito con un’orda di morti viventi cannibali che scorrazzavano nella Padana superiore!!!!). Poi venne il successo della pellicola di “Resident Evil” e a seguire il bellissimo action live di Zack Snyder “L’alba dei morti viventi”, grande successo ai botteghini di tutto il mondo nel 2004.
Gli zombi, in questi ultimi dieci anni, sono diventati un fenomeno mediatico che non ha confini. Dalla cultura occidentale a quella orientale, passando anche per l’Africa. E dire che agli inizi degli anni Zero il genere sembrava ormai morto e sepolto, solo qualche film horror di seconda categoria distribuito direttamente in DVD e nulla di più. Gli editori italiani non volevano nemmeno sentire parlare della parola “zombi” (senza la “e” nella traduzione italiana) e nemmeno con un dito avrebbero toccato novelle di cotale genere (ne sa qualcosa il sottoscritto, grande fan degli zombi, che ha scritto nel 2000 e qualcosa un romanzo fiume sui morti viventi, avendo anche l’ardire di mescolarci dentro le stragi di mafia degli anni ’90, il rapimento Moro, i truschi mafiosi di Berlusconi, lottatori di wrestling amatoriale e un gruppo di adolescenti che sembravano usciti da un romanzo di Giuseppe Culicchia, il tutto condito con un’orda di morti viventi cannibali che scorrazzavano nella Padana superiore!!!!). Poi venne il successo della pellicola di “Resident Evil” e a seguire il bellissimo action live di Zack Snyder “L’alba dei morti viventi”, grande successo ai botteghini di tutto il mondo nel 2004. 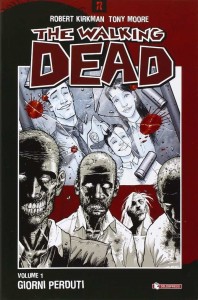 Quelle pellicole aprirono la strada ai fumetti di Robert Kirkman con la serie di “The Walking Dead” e la successiva serializzazione televisiva, venduta praticamente ovunque. Di questo insperato revival zombesco ne ha beneficiato anche il grande escluso del cinema americano, nonché papà a tutti gli effetti del genere, ossia George Romero. In quegli anni Zero Romero ha la possibilità di tornare a girare altri tre film sui morti viventi, due dei quali da indipendente. L’ultima pellicola era del 2009, e Romero sarebbe morto purtroppo nel luglio del 2017 (e credetemi se vi dico che la cosa ancora adesso mi addolora molto, l’idea insomma che quel simpatico e bonario omone con gli occhiali enormi e fuori moda non sia più qui a cercare di resistere assieme a tutti noi alla stupidità dei potenti di questo povero pianeta) senza più dirigere alcunché. Per fortuna la Marvel, nel 2012 lo aveva contattato per portare avanti le sue idee sull’apocalisse di zombi e tra il marzo e il giugno del 2014 erano usciti 5 numeri, disegnati da Alex Maleev. “L’impero dei morti” è un fumetto incompleto, forse interrotto dalla morte del suo autore, tuttavia si tratta del testamento creativo del papà degli zombi. Romero riprende di peso le atmosfere del film “La terra dei morti viventi”, spostando la vicenda in una New York gotica e oscura (quasi una Gotham City, una suburra del noir); la critica sociale romeriana è sempre affilata e precisa nel descrivere un’umanità agonizzante e sempre arrogante, coi ricchi che vivono nelle parti protette della city, lasciando il resto dei viventi a sopravvivere in squallide periferie degradate, tra fumi tossici e morti viventi che hanno iniziato da tempo un lento percorso di consapevolezza.
Quelle pellicole aprirono la strada ai fumetti di Robert Kirkman con la serie di “The Walking Dead” e la successiva serializzazione televisiva, venduta praticamente ovunque. Di questo insperato revival zombesco ne ha beneficiato anche il grande escluso del cinema americano, nonché papà a tutti gli effetti del genere, ossia George Romero. In quegli anni Zero Romero ha la possibilità di tornare a girare altri tre film sui morti viventi, due dei quali da indipendente. L’ultima pellicola era del 2009, e Romero sarebbe morto purtroppo nel luglio del 2017 (e credetemi se vi dico che la cosa ancora adesso mi addolora molto, l’idea insomma che quel simpatico e bonario omone con gli occhiali enormi e fuori moda non sia più qui a cercare di resistere assieme a tutti noi alla stupidità dei potenti di questo povero pianeta) senza più dirigere alcunché. Per fortuna la Marvel, nel 2012 lo aveva contattato per portare avanti le sue idee sull’apocalisse di zombi e tra il marzo e il giugno del 2014 erano usciti 5 numeri, disegnati da Alex Maleev. “L’impero dei morti” è un fumetto incompleto, forse interrotto dalla morte del suo autore, tuttavia si tratta del testamento creativo del papà degli zombi. Romero riprende di peso le atmosfere del film “La terra dei morti viventi”, spostando la vicenda in una New York gotica e oscura (quasi una Gotham City, una suburra del noir); la critica sociale romeriana è sempre affilata e precisa nel descrivere un’umanità agonizzante e sempre arrogante, coi ricchi che vivono nelle parti protette della city, lasciando il resto dei viventi a sopravvivere in squallide periferie degradate, tra fumi tossici e morti viventi che hanno iniziato da tempo un lento percorso di consapevolezza. 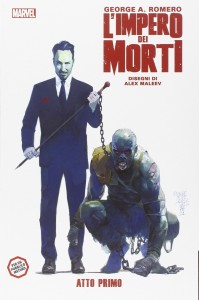 Qui, alla testa di questi morti viventi (simbolo di tutti gli straccioni, senzatetto, ultimi degli ultimi) c’è una soldatessa morta, una swat dai capelli corti e color platino che pare recuperare parzialmente i ricordi della sua esistenza precedente (un po’ come faceva già il simpatico Bud in “Il giorno degli zombi”) e si lega alle vicende di una bella dottoressa e di un mercenario idealista (anche questo personaggio sembra ricordare i tratti del Riley di Simon Baker sempre ne “La terra dei morti viventi”). A complicare le cose un perfido sindaco di New York che ha trasformato il Central Park in un Circo Massimo di zombi e umani e sembra appartenere (così come tutti i ricchi e potenti sopravvissuti) a una razza di vampiri succhia-sangue, mostri aristocratici del gotico classico a cui Romero aveva dedicato una variante psycothriller col bellissimo “Wampir” del 1977. Ed è questo inserimento dei vampiri nel contesto classico e romeriano dei morti viventi a costituire forse la novità più significativa rispetto all’estetica degli ultimi film zombeschi del regista di Pittsburgh. “L’impero dei morti” sembra insomma un gustoso omaggio che Romero fa a se stesso e un tentativo, attraverso il linguaggio della narrativa sequenziale, di continuare a esprimersi nonostante i mille veti di Hollywood al suo talento.
Qui, alla testa di questi morti viventi (simbolo di tutti gli straccioni, senzatetto, ultimi degli ultimi) c’è una soldatessa morta, una swat dai capelli corti e color platino che pare recuperare parzialmente i ricordi della sua esistenza precedente (un po’ come faceva già il simpatico Bud in “Il giorno degli zombi”) e si lega alle vicende di una bella dottoressa e di un mercenario idealista (anche questo personaggio sembra ricordare i tratti del Riley di Simon Baker sempre ne “La terra dei morti viventi”). A complicare le cose un perfido sindaco di New York che ha trasformato il Central Park in un Circo Massimo di zombi e umani e sembra appartenere (così come tutti i ricchi e potenti sopravvissuti) a una razza di vampiri succhia-sangue, mostri aristocratici del gotico classico a cui Romero aveva dedicato una variante psycothriller col bellissimo “Wampir” del 1977. Ed è questo inserimento dei vampiri nel contesto classico e romeriano dei morti viventi a costituire forse la novità più significativa rispetto all’estetica degli ultimi film zombeschi del regista di Pittsburgh. “L’impero dei morti” sembra insomma un gustoso omaggio che Romero fa a se stesso e un tentativo, attraverso il linguaggio della narrativa sequenziale, di continuare a esprimersi nonostante i mille veti di Hollywood al suo talento.
 Gli zombi hanno trionfato anche nel fumetto asiatico nella bella serie (22 numeri nell’edizione italiana della GP Manga) di Kengo Hanazawa “I am a hero”, uscita nel 2009 in Giappone e tradotta da noi a partire dal luglio del 2011. “I am a hero” è un manga seriale che trasporta l’apocalisse zombi in Giappone, raccontando le vicende di Hideo, un disegnatore di manga un po’ nerd. Il primo numero gioca molto sull’attesa e segue le giornate monotone e sempre uguali del suo protagonista, un ex giovane di 35 anni che vive ancora come un ragazzino, insegue il sogno di sfondare coi fumetti e lavora, sfruttato, per piccole case editrici. La descrizione del mondo dei fumetti giapponesi è assai intrigante e caratterizza con originalità il mondo in cui si muove Hideo. A queste tribolazioni narrative, Kengo Hanazawa aggiunge delle specifiche idiosincrasie del protagonista, che, una volta rientrato in casa, si barrica dentro per trascorrere la notte, assediato da paure e fobie notturne prese di peso dai J-horror degli anni ’90. Hanazawa descrive anche con mano felice la relazione amorosa e sessuale di Hideo con la sua ragazza, anch’essa nel mondo dei comics. La storia procede lentamente, giocando nei punti giusti le prime avvisaglie di un’epidemia zombesca che sembra richiamar di peso la variante del film di Zack Snyder del 2004 con gli zombi che corrono e scattano come centometristi (a questa pellicola e al fumetto di Hanazawa si rifarà anche il coreano Sang-ho Yeon per il bellissimo “Train to Busan” del 2016 e per il precedente film di animazione “Seul Station”, recentemente editati insieme dalla Midnight Factory in un ottimo combo Blu-ray).
Gli zombi hanno trionfato anche nel fumetto asiatico nella bella serie (22 numeri nell’edizione italiana della GP Manga) di Kengo Hanazawa “I am a hero”, uscita nel 2009 in Giappone e tradotta da noi a partire dal luglio del 2011. “I am a hero” è un manga seriale che trasporta l’apocalisse zombi in Giappone, raccontando le vicende di Hideo, un disegnatore di manga un po’ nerd. Il primo numero gioca molto sull’attesa e segue le giornate monotone e sempre uguali del suo protagonista, un ex giovane di 35 anni che vive ancora come un ragazzino, insegue il sogno di sfondare coi fumetti e lavora, sfruttato, per piccole case editrici. La descrizione del mondo dei fumetti giapponesi è assai intrigante e caratterizza con originalità il mondo in cui si muove Hideo. A queste tribolazioni narrative, Kengo Hanazawa aggiunge delle specifiche idiosincrasie del protagonista, che, una volta rientrato in casa, si barrica dentro per trascorrere la notte, assediato da paure e fobie notturne prese di peso dai J-horror degli anni ’90. Hanazawa descrive anche con mano felice la relazione amorosa e sessuale di Hideo con la sua ragazza, anch’essa nel mondo dei comics. La storia procede lentamente, giocando nei punti giusti le prime avvisaglie di un’epidemia zombesca che sembra richiamar di peso la variante del film di Zack Snyder del 2004 con gli zombi che corrono e scattano come centometristi (a questa pellicola e al fumetto di Hanazawa si rifarà anche il coreano Sang-ho Yeon per il bellissimo “Train to Busan” del 2016 e per il precedente film di animazione “Seul Station”, recentemente editati insieme dalla Midnight Factory in un ottimo combo Blu-ray).
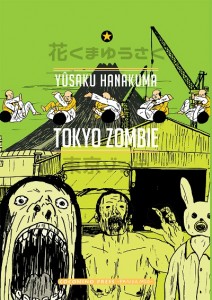 Agli zombi guarda anche lo splendido volume editato da Coconino Press – Fandango nel 2018 di Yusaku Hanakuma “Tokyo zombie”, con postfazione seminale di Juan Scassa. Hanakuma è un artista hetauma, corrente del fumetto giapponese che risale agli anni ’70 ed è contraddistinta da un tratto grafico che non ha nulla del manga classico ed è invece un disegno rozzo, infantile e approssimativo, caratterizzato da testi caricaturali, anarcoidi e politicamente scorretti. “Tokyo zombie” non fa eccezione: la trama parla di un monte Fuji riempito di rifiuti inquinanti, un luogo in cui vengono seppellite anche le persone e dove far sparire cadaveri senza troppe grane. Chissà come, i morti risorgono e due lottatori giapponesi di wrestling brasiliano (nonché operai con le loro belle tute da lavoro) dovranno affrontare la fine di un mondo che saprà riorganizzarsi benissimo; in modo assai simile alle distopie romeriane, il Giappone post-zombi diventa un luogo in cui i ricchi sfruttano i poveri, utilizzandoli per ogni loro capriccio, costringendo gli schiavi a battersi con degli zombi mascherati da lottatori di wrestling. Ovviamente i miserabili capiranno presto l’antifona e si metteranno alla testa di una rivolta integrale del sistema. Gli scarabocchi di Hanakuma (lo stile essenziale e punk del fumetto hetauma), la trama simile alle follie di un film Troma, gli eccessi grafici, lo splatter e puntatine (mai sgradite dal sottoscritto) in una pornografia che sembra rifarsi a pellicole estreme come “Le notti erotiche dei morti viventi” di Joe D’Amato, fanno di “Tokyo zombie” un capolavoro inaspettato e necessario, una graphic novel mai scontata ed essenziale per resistere alle banalità e alle stupidità di un mercato editoriale sempre più conformato agli ultimi libri di qualche vincitore di talent o opinioniste sul nulla…
Agli zombi guarda anche lo splendido volume editato da Coconino Press – Fandango nel 2018 di Yusaku Hanakuma “Tokyo zombie”, con postfazione seminale di Juan Scassa. Hanakuma è un artista hetauma, corrente del fumetto giapponese che risale agli anni ’70 ed è contraddistinta da un tratto grafico che non ha nulla del manga classico ed è invece un disegno rozzo, infantile e approssimativo, caratterizzato da testi caricaturali, anarcoidi e politicamente scorretti. “Tokyo zombie” non fa eccezione: la trama parla di un monte Fuji riempito di rifiuti inquinanti, un luogo in cui vengono seppellite anche le persone e dove far sparire cadaveri senza troppe grane. Chissà come, i morti risorgono e due lottatori giapponesi di wrestling brasiliano (nonché operai con le loro belle tute da lavoro) dovranno affrontare la fine di un mondo che saprà riorganizzarsi benissimo; in modo assai simile alle distopie romeriane, il Giappone post-zombi diventa un luogo in cui i ricchi sfruttano i poveri, utilizzandoli per ogni loro capriccio, costringendo gli schiavi a battersi con degli zombi mascherati da lottatori di wrestling. Ovviamente i miserabili capiranno presto l’antifona e si metteranno alla testa di una rivolta integrale del sistema. Gli scarabocchi di Hanakuma (lo stile essenziale e punk del fumetto hetauma), la trama simile alle follie di un film Troma, gli eccessi grafici, lo splatter e puntatine (mai sgradite dal sottoscritto) in una pornografia che sembra rifarsi a pellicole estreme come “Le notti erotiche dei morti viventi” di Joe D’Amato, fanno di “Tokyo zombie” un capolavoro inaspettato e necessario, una graphic novel mai scontata ed essenziale per resistere alle banalità e alle stupidità di un mercato editoriale sempre più conformato agli ultimi libri di qualche vincitore di talent o opinioniste sul nulla…






























