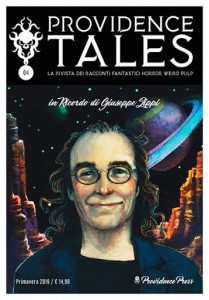 In questi ultimi tempi mi diletto sul weird, ascolto playlist di Italian Occult Psychedelia, cerco e scopro nuovi piccoli editori. Leggendo proprio il “Providence Tales” n. 4 della primavera 2019, mi imbatto in un interessante articolo di Francesco Corigliano, docente e studioso di weird fiction. Nelle sue conclusioni (e nelle note), Corigliano si lascia scappare le considerazioni più interessanti. Il weird (concetto sfuggente come pochi) è una forza narrativa che svuota il “reale”. Subito dopo riporta le critiche di alcuni autori weird a certo “new weird”, visto come una moda editoriale. Poi accenna a un incerto weird italico, rimandando a un articolo di Vanni Santoni pubblicato sul Foglio il 12 novembre 2018. Non conoscevo l’esistenza di una scena weird al di fuori delle piccole riviste specializzate come Studi Lovecraftiani, Hypnos, Providence Press, ecc.
In questi ultimi tempi mi diletto sul weird, ascolto playlist di Italian Occult Psychedelia, cerco e scopro nuovi piccoli editori. Leggendo proprio il “Providence Tales” n. 4 della primavera 2019, mi imbatto in un interessante articolo di Francesco Corigliano, docente e studioso di weird fiction. Nelle sue conclusioni (e nelle note), Corigliano si lascia scappare le considerazioni più interessanti. Il weird (concetto sfuggente come pochi) è una forza narrativa che svuota il “reale”. Subito dopo riporta le critiche di alcuni autori weird a certo “new weird”, visto come una moda editoriale. Poi accenna a un incerto weird italico, rimandando a un articolo di Vanni Santoni pubblicato sul Foglio il 12 novembre 2018. Non conoscevo l’esistenza di una scena weird al di fuori delle piccole riviste specializzate come Studi Lovecraftiani, Hypnos, Providence Press, ecc.
Cerco su internet l’articolo di Santoni e scopro un elenco di scrittori (che dai nomi avrei associato a un certo mainstream fighetto nostrano) che sembra vogliano uscire dalle rigide gabbie del romanzo intimista e psicologico. Ne cerco qualcuno, tanto per farmi un’idea. In realtà Santoni parla di una letteratura alla ricerca di nuove forme di perturbante, per confrontarsi e misurarsi con un presente sempre più complesso e stratificato in cui si mescolano sentimenti, narrazioni impegnate e derive distopiche o fantastiche. Santoni rintraccia le radici di questa nuova letteratura fantastica in una scrittrice come Laura Pugno, o addirittura in quel pasticciaccio di “Branchie” di Ammaniti, e forse chissà, allora pure nei cannibali einaudiani.
Sarà?
Con qualche dubbio nell’aver buttato gli ultimi soldi della disoccupazione, aspetto il pacco. Arriva.
Premetto che sono un lettore di genere, uno che considera esista una linea di demarcazione ben definita tra scrittori da classifica (forgiati dalle agenzie letterarie, costretti a estenuanti riscritture imposte dagli editor, omologati dai corsi di scrittura creativa che servono solo ad arrotondare lo stipendio degli addetti all’editoria) e le scritture invisibili (oggi disperse nel maelstrom del web.
 Leggo il primo libro. L’edizione e la copertina (vintage, da volume usato, un po’ consunto) è fantastica. Violetta Bellocchio, “La festa nera”, Chiarelettere, 2018. È un libro non troppo lungo. La trama, vagamente fantascientifica – lascia adombrare una catastrofe imminente (pare che il tema apocalittico piaccia molto alle nuove leve delle nostre patrie lettere) – vede un gruppo di giovani che con le loro macchine da presa se ne vanno in giro nella Val di Trebbia per realizzare dei documentari su comunità autarchiche e alternative che hanno scelto forme di socialità alternative alla nostra. Il romanzo alterna i viaggi e i reportage a momenti intimi della protagonista e alle dinamiche interne al gruppo. Le parti ambientate nelle varie comuni sono le migliori del libro, a tratti quasi una sorta di folk horror italico in cui, tra roulotte parcheggiate lungo i letti di un fiume, statali desolate, automobili sventrate, frazioni disabitate, vivono confraternite autarchiche che vogliono sfuggire (un po’ come avveniva in “The Sacrament” di Ti West) alla violenza innata dell’uomo. La Bellocchio fa muovere i suoi personaggi in un mondo fitto di rituali che hanno lo scopo di sfuggire all’alienazione del mondo contemporaneo e recuperare linee di identità frantumate da mari di Xanax. Tra le regole di queste comunità fricchettone e ragazzi in skateboard, sembra quasi di vedere un nuovo mondo folclorico della modernità, nuove forme terapeutiche che si affidano a poteri magici, santoni, benefattori, scuole educative speciali che coniugano pedagogia e lotta armata. Come ai tempi di De Martino emerge una miseria psicologica dell’uomo moderno, fragile, dall’identità disciolta nelle derive magmatiche del web, sempre più bisognoso di coniugare la cultura di massa con nuove forme di vita popolari, tracce mutate di relazioni tra ceti dominanti e società subalterne distopiche sul ciglio di altre apocalissi culturali. Alla fine rimane un libro a tratti interessante ma frammentario, affidato a una scrittura semplice, fatta di periodi brevi, frasi nominali, molto descrittiva, asciutta come una sceneggiatura, con strizzatine alla cultura alta e bassa (insomma la tipica scrittura da romanzo italiano di oggi, una prosa efficace affilata dalla pratica giornalistica, abbastanza anonima). Nella quarta di copertina, Luciano Funetta, individua nella voce narrante della Bellocchio, un “io” differente da quelli ipertrofici della letteratura italiana. Se lo dice lui? A me le 150 pagine del libro son parse fin troppo, annacquate in personaggi senza consistenza se non la pretesa di averne una, afflitti da quel tono intimistico depressivo tipico di tanta letteratura mainstream. Inoltre il libro sembra, come dicevo, una seria di servizi giornalistici cuciti insieme e amalgamati dai pensieri della protagonista, pensieri che spesso non vanno oltre un “Troia, puttana, cagna in calore. Se il buongiorno si vede dal mattino, a quest’ora avrà la fica come una fogna. Non le basta mai. Il primo che trova il suo indirizzo. Il primo che trova il suo numero. Il primo che. Puttana. Troia. Puttana. Troia, ecc”. Mi ricorda il folgorante incipit di “Io sono Nanni Moretti” di Giuseppe Culicchia (un altro che oggi passa come uno dei vertici letterari della narrativa italiota e scrive, da trent’anni, con una sintassi elementare), altro romanzo infittito di copia e incolla, una parola e a capo e via dicendo.
Leggo il primo libro. L’edizione e la copertina (vintage, da volume usato, un po’ consunto) è fantastica. Violetta Bellocchio, “La festa nera”, Chiarelettere, 2018. È un libro non troppo lungo. La trama, vagamente fantascientifica – lascia adombrare una catastrofe imminente (pare che il tema apocalittico piaccia molto alle nuove leve delle nostre patrie lettere) – vede un gruppo di giovani che con le loro macchine da presa se ne vanno in giro nella Val di Trebbia per realizzare dei documentari su comunità autarchiche e alternative che hanno scelto forme di socialità alternative alla nostra. Il romanzo alterna i viaggi e i reportage a momenti intimi della protagonista e alle dinamiche interne al gruppo. Le parti ambientate nelle varie comuni sono le migliori del libro, a tratti quasi una sorta di folk horror italico in cui, tra roulotte parcheggiate lungo i letti di un fiume, statali desolate, automobili sventrate, frazioni disabitate, vivono confraternite autarchiche che vogliono sfuggire (un po’ come avveniva in “The Sacrament” di Ti West) alla violenza innata dell’uomo. La Bellocchio fa muovere i suoi personaggi in un mondo fitto di rituali che hanno lo scopo di sfuggire all’alienazione del mondo contemporaneo e recuperare linee di identità frantumate da mari di Xanax. Tra le regole di queste comunità fricchettone e ragazzi in skateboard, sembra quasi di vedere un nuovo mondo folclorico della modernità, nuove forme terapeutiche che si affidano a poteri magici, santoni, benefattori, scuole educative speciali che coniugano pedagogia e lotta armata. Come ai tempi di De Martino emerge una miseria psicologica dell’uomo moderno, fragile, dall’identità disciolta nelle derive magmatiche del web, sempre più bisognoso di coniugare la cultura di massa con nuove forme di vita popolari, tracce mutate di relazioni tra ceti dominanti e società subalterne distopiche sul ciglio di altre apocalissi culturali. Alla fine rimane un libro a tratti interessante ma frammentario, affidato a una scrittura semplice, fatta di periodi brevi, frasi nominali, molto descrittiva, asciutta come una sceneggiatura, con strizzatine alla cultura alta e bassa (insomma la tipica scrittura da romanzo italiano di oggi, una prosa efficace affilata dalla pratica giornalistica, abbastanza anonima). Nella quarta di copertina, Luciano Funetta, individua nella voce narrante della Bellocchio, un “io” differente da quelli ipertrofici della letteratura italiana. Se lo dice lui? A me le 150 pagine del libro son parse fin troppo, annacquate in personaggi senza consistenza se non la pretesa di averne una, afflitti da quel tono intimistico depressivo tipico di tanta letteratura mainstream. Inoltre il libro sembra, come dicevo, una seria di servizi giornalistici cuciti insieme e amalgamati dai pensieri della protagonista, pensieri che spesso non vanno oltre un “Troia, puttana, cagna in calore. Se il buongiorno si vede dal mattino, a quest’ora avrà la fica come una fogna. Non le basta mai. Il primo che trova il suo indirizzo. Il primo che trova il suo numero. Il primo che. Puttana. Troia. Puttana. Troia, ecc”. Mi ricorda il folgorante incipit di “Io sono Nanni Moretti” di Giuseppe Culicchia (un altro che oggi passa come uno dei vertici letterari della narrativa italiota e scrive, da trent’anni, con una sintassi elementare), altro romanzo infittito di copia e incolla, una parola e a capo e via dicendo.
A questo punto mi viene subito un dubbio. Ma se questi passano per autori di genere, come scrivono quelli che fanno genere per davvero e pubblicano su riviste specializzate, o sul web, senza avere dietro agenzie letterarie o editor?
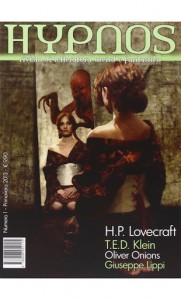 Prendo il primo numero della rivista “Hypnos” (primavera del 2013). All’interno un racconto italiano di tali Andrea Jarok e Giovanni De Matteo. Non so nemmeno che faccia abbiano (come per la Bellocchio). Il racconto si intitola “Cumhu, oltre la soglia dell’ignoto” e appare da subito un omaggio a quei racconti weird da rivista popolare americana. Il riferimento a Lovecraft è palese. L’idea è quella di mescolare il personaggio di Burroughs (qui chiamato “Lo straniero”) coi miti dei Grandi Antichi, ossia vecchi papiri che schiudono mondi e antiche civiltà inumane, passaggi dimensionali lungo i bordi lynchiani di highway dimenticate da Dio. Bene. Niente di nuovo sotto il sole nemmeno nel 2013. Cosa cambia dalla Bellocchio? La scrittura è molto meno affilata. Le frasi, più corpose, abbondano di aggettivi e dettagli sonori, visivi, per costruire una dimensione sognante, infittita da citazioni meno telefonate o sbattute sulla pagina. Il personaggio principale non è caratterizzato in modo psicologico, ma in modo funzionale a ciò che deve fare nel racconto per far progredire quel minimo di plot. Il racconto inoltre, in ossequio alle teorie letterarie dello scrittore di Providence, ha il fine di creare un’atmosfera sospesa e stellare (una sorta di gotico cosmologico), senza andare a ricercare particolari sfumature sociali…
Prendo il primo numero della rivista “Hypnos” (primavera del 2013). All’interno un racconto italiano di tali Andrea Jarok e Giovanni De Matteo. Non so nemmeno che faccia abbiano (come per la Bellocchio). Il racconto si intitola “Cumhu, oltre la soglia dell’ignoto” e appare da subito un omaggio a quei racconti weird da rivista popolare americana. Il riferimento a Lovecraft è palese. L’idea è quella di mescolare il personaggio di Burroughs (qui chiamato “Lo straniero”) coi miti dei Grandi Antichi, ossia vecchi papiri che schiudono mondi e antiche civiltà inumane, passaggi dimensionali lungo i bordi lynchiani di highway dimenticate da Dio. Bene. Niente di nuovo sotto il sole nemmeno nel 2013. Cosa cambia dalla Bellocchio? La scrittura è molto meno affilata. Le frasi, più corpose, abbondano di aggettivi e dettagli sonori, visivi, per costruire una dimensione sognante, infittita da citazioni meno telefonate o sbattute sulla pagina. Il personaggio principale non è caratterizzato in modo psicologico, ma in modo funzionale a ciò che deve fare nel racconto per far progredire quel minimo di plot. Il racconto inoltre, in ossequio alle teorie letterarie dello scrittore di Providence, ha il fine di creare un’atmosfera sospesa e stellare (una sorta di gotico cosmologico), senza andare a ricercare particolari sfumature sociali…
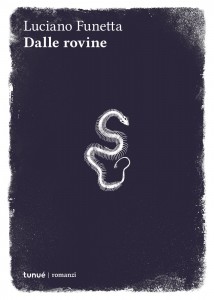 Passiamo a Luciano Funetta con “Dalle rovine”, Tuné, 2015. La Tuné è una casa editrice specializzata in fumetti e in effetti la grafica della collana (guarda caso diretta da quel Vanni Santoni dell’articolo sul Foglio, della serie, me le canto e me le suono…) è sfiziosa. Funetta passa per il nuovo messia della letteratura italiana. La trama del romanzo è un “famolo strano” al cubo: un collezionista di serpenti che, mollato da moglie e figlia, si fa masturbare dai suoi invertebrati velenosissimi; si filma, così, tanto per fare (la psicologia di questi personaggi è inesistente tanto quanto quella di quelli dei “Racconti di Dracula”), consegna il dvd a un gestore di cine porno che gira la cosa a un regista misterioso di porno artistici. Da qui una spirale di personaggi ed eventi (pochi, gli eventi) che trascineranno il protagonista nei meandri oscuri dello snuff movie e a incontrare un enigmatico sceneggiatore argentino ossessionato dall’idea di filmare l’impossibile. Finale, come si conviene, sospeso e vagamente allucinatorio. Funetta sembra uno stiloso e seducente, dice e non dice, costruisce una storia labirintica che, probabilmente, non significa nulla, ma nessuno si prenderà mai il rischio di dirlo. Ne esce un romanzo all’inizio curioso, ma che, nelle sue quasi duecento pagine, finisce per stancare, trascinandosi in una sorta di gara alla “stranezza” che sembra artefatta, troppo costruita, o comunque stilosa, affidata a personaggi monodimensionali il cui unico tratto è l’assoluta (e banale) enigmaticità. Una roba così è finita al Premio Strega? Di mio, sento il bisogno di riprendermi con un altro raccontino “Hypnos”.
Passiamo a Luciano Funetta con “Dalle rovine”, Tuné, 2015. La Tuné è una casa editrice specializzata in fumetti e in effetti la grafica della collana (guarda caso diretta da quel Vanni Santoni dell’articolo sul Foglio, della serie, me le canto e me le suono…) è sfiziosa. Funetta passa per il nuovo messia della letteratura italiana. La trama del romanzo è un “famolo strano” al cubo: un collezionista di serpenti che, mollato da moglie e figlia, si fa masturbare dai suoi invertebrati velenosissimi; si filma, così, tanto per fare (la psicologia di questi personaggi è inesistente tanto quanto quella di quelli dei “Racconti di Dracula”), consegna il dvd a un gestore di cine porno che gira la cosa a un regista misterioso di porno artistici. Da qui una spirale di personaggi ed eventi (pochi, gli eventi) che trascineranno il protagonista nei meandri oscuri dello snuff movie e a incontrare un enigmatico sceneggiatore argentino ossessionato dall’idea di filmare l’impossibile. Finale, come si conviene, sospeso e vagamente allucinatorio. Funetta sembra uno stiloso e seducente, dice e non dice, costruisce una storia labirintica che, probabilmente, non significa nulla, ma nessuno si prenderà mai il rischio di dirlo. Ne esce un romanzo all’inizio curioso, ma che, nelle sue quasi duecento pagine, finisce per stancare, trascinandosi in una sorta di gara alla “stranezza” che sembra artefatta, troppo costruita, o comunque stilosa, affidata a personaggi monodimensionali il cui unico tratto è l’assoluta (e banale) enigmaticità. Una roba così è finita al Premio Strega? Di mio, sento il bisogno di riprendermi con un altro raccontino “Hypnos”.
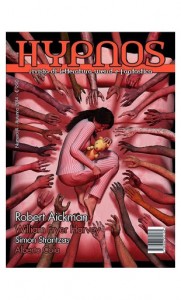 Parliamo di “Hypnos” n. 4, autunno 2014, con “Le Bastarde” di Alberto Cola. Ambientazione interessante, Civitanova Marche, Porto Recanati, le alture del Conero. Protagonisti un gruppo di bambini, che nelle notti senza luna, devono vedersela con strane creature (le bastarde del titolo) che escono dal mare per esigere i loro tributi di sangue. L’idea rimanda ancora a Lovecraft e a quel “The Shadow over Innsmouth” con le sue comunità rurali isolate e degradate. Il racconto mescola questa tematica fantastica con quello sulla violenza ai minori, mettendo in scena un maniaco pedofilo che i ragazzini riusciranno a far acchiappare dai mostri, così da placare momentaneamente la loro insaziabile sete. Il racconto ha una scrittura semplice, senza fronzoli o frasi a effetto, comunque ricca di atmosfera, capace di evocare (più che spiattellare) lo stato emotivo di meraviglie e paure con cui i bambini, lontani dal mondo quasi invisibile degli adulti, devono avere a che fare! Qui Cola gioca anche su un percorso di crescita non lontano da certe comitive di ragazzi cari a tanto Stephen King.
Parliamo di “Hypnos” n. 4, autunno 2014, con “Le Bastarde” di Alberto Cola. Ambientazione interessante, Civitanova Marche, Porto Recanati, le alture del Conero. Protagonisti un gruppo di bambini, che nelle notti senza luna, devono vedersela con strane creature (le bastarde del titolo) che escono dal mare per esigere i loro tributi di sangue. L’idea rimanda ancora a Lovecraft e a quel “The Shadow over Innsmouth” con le sue comunità rurali isolate e degradate. Il racconto mescola questa tematica fantastica con quello sulla violenza ai minori, mettendo in scena un maniaco pedofilo che i ragazzini riusciranno a far acchiappare dai mostri, così da placare momentaneamente la loro insaziabile sete. Il racconto ha una scrittura semplice, senza fronzoli o frasi a effetto, comunque ricca di atmosfera, capace di evocare (più che spiattellare) lo stato emotivo di meraviglie e paure con cui i bambini, lontani dal mondo quasi invisibile degli adulti, devono avere a che fare! Qui Cola gioca anche su un percorso di crescita non lontano da certe comitive di ragazzi cari a tanto Stephen King.
 Prendo “Suttaterra” di Orazio Labbate, sempre per Tuné (2017). Un becchino emigrato in America, riceve cartoline dalla moglie morta. Per il protagonista comincia un viaggio di ritorno alle proprie radici, in una Gela che è anche una discesa infera che dall’Atlantico arriva in una terra moribonda, un utero di catrame, petrolchimici e un luna park abbandonato dal sapore ligottiano. Alla fine la vicenda ha una conclusione che piace molto a questi nuovi narratori, in un impasto di vivi e morti, di aldilà molto simili al nostro aldiquà e via discorrendo. L’idea di Labbate è poco più di un raccontino, gonfiato da continue digressioni, incubi, narrazioni nella narrazione, ecc. La scrittura, più pretenziosa, è ingolfata da una ricerca linguistica a tratti desueta e che finisce quasi subito per stancare. La parte migliore è sicuramente quella nel luna park sul mare, luogo perturbante che si allaccia alle edicole votive, alle immagini di una religiosità di un sud Italia deformato, ennesima evocazione di quel mondo protostorico separato dalla modernità e indagato da De Martino.
Prendo “Suttaterra” di Orazio Labbate, sempre per Tuné (2017). Un becchino emigrato in America, riceve cartoline dalla moglie morta. Per il protagonista comincia un viaggio di ritorno alle proprie radici, in una Gela che è anche una discesa infera che dall’Atlantico arriva in una terra moribonda, un utero di catrame, petrolchimici e un luna park abbandonato dal sapore ligottiano. Alla fine la vicenda ha una conclusione che piace molto a questi nuovi narratori, in un impasto di vivi e morti, di aldilà molto simili al nostro aldiquà e via discorrendo. L’idea di Labbate è poco più di un raccontino, gonfiato da continue digressioni, incubi, narrazioni nella narrazione, ecc. La scrittura, più pretenziosa, è ingolfata da una ricerca linguistica a tratti desueta e che finisce quasi subito per stancare. La parte migliore è sicuramente quella nel luna park sul mare, luogo perturbante che si allaccia alle edicole votive, alle immagini di una religiosità di un sud Italia deformato, ennesima evocazione di quel mondo protostorico separato dalla modernità e indagato da De Martino.
 Non lontano da queste traiettorie è il romanzo fiume (più di 500 pagine) di Andrea Gentile, “I vivi e i morti”, Minimum Fax, 2018. Pare che Gentile sia uno dei giganti della nuova narrativa italiana. Di professione credo sbarchi il lunario dirigendo la collana di narrative de il Saggiatore (e infatti ricordo una sua lunga, pretenziosa, abbastanza inutile postfazione al “Nottuario” di Thomas Ligotti, autore presentato e curato in Italia in modo più puntuale da Armando Corridore per Elara). Gentile è anche scrittore e forse la postfazione pensata per Ligotti serve di più a farmi capire qualcosa sul suo libro. Su internet lo si passa come un romanzo terminale, il capolavoro ultimo della letteratura italiana, roba da Antonio Moresco o Giù Genna (nomi dai quali mi tengo alla larga come un vampiro dall’aglio!). Il libro, senza fine, è una sorta di spaccato horror grottesco di un sud dei sud dei santi (paesi nebulose dai nomi fantasmatici) un Masserie di Cristo popolato da personaggi forse vivi, forse morti, nel loro tran tran quotidiano nei campi, i dialoghi brevissimi (che fanno far pagine velocemente), leggende, sparizioni, microavvenimenti, filastrocche, e personaggi monodimensionali che non si distinguono l’uno dall’altro (l’ispettore agrario, il cowboy, Beberto, Tebaldo e chi più ne ha ne metta in una gara all’accumulo e alla stranezza che finisce per diventare solo rumore di fondo). In un girotondo di masserie, case screpolate, catapecchie e malattie varie, la civiltà di Masserie di Cristo ricorda una sorta di “Twin Peaks” demartiniana, una popolazione sottumana che passa il suo tempo tra Feste della Pallacorda, animali, un sisma di scene e scenette staccate che fanno pensare a un mosaico di racconti scomposti e ricombinati per dare la parvenza di un grande affresco allegorico di un’ennesima fine del mondo tascabile (qualcosa di simile, ma con altri risultati e un centesimo di pagine lo aveva fatto Tiziano Sclavi col suo “Film” nel 1974). Gentile deve essere cresciuto col poster di Moresco in camera e quanto scrive di Ligotti vale in realtà per lui; “I vivi e i morti” è un libro inutilmente lungo, una sorta di prova di resistenza imposta al lettore, un fluire che trabocca, crepita, lacera la pagina, una scrittura troppo furbetta (e sintatticamente nemmeno poi tanto ricercata, al solito affidata a frasi non più lunghe di un battito di ciglia) fatta di crolli, squarci, abissi. Gentile ama l’opera mondo, il libro dentro al quale ti puoi perdere? Può darsi, peccato che il romanzo, pur conservando almeno all’inizio un certo fascino nell’idea di fondo (quella appunto di un microcosmo collettivo calato in un mondo magico e antico, un mondo ctonio e marginale, immerso nelle fantasmagorie di un folklore reinventato dall’autore), si risolva in un inutile accumulo di micronarrazioni che finiscono per assomigliarsi tutte, in una compressione dello spazio/tempo narrativo che porta al nulla, perché, alla fine, anche questo libro è un monumento al nulla (o se volete all’arroganza dell’autore, o ancora alla mia imbecillità per essermi pippato tutte e 500 le paginette!).
Non lontano da queste traiettorie è il romanzo fiume (più di 500 pagine) di Andrea Gentile, “I vivi e i morti”, Minimum Fax, 2018. Pare che Gentile sia uno dei giganti della nuova narrativa italiana. Di professione credo sbarchi il lunario dirigendo la collana di narrative de il Saggiatore (e infatti ricordo una sua lunga, pretenziosa, abbastanza inutile postfazione al “Nottuario” di Thomas Ligotti, autore presentato e curato in Italia in modo più puntuale da Armando Corridore per Elara). Gentile è anche scrittore e forse la postfazione pensata per Ligotti serve di più a farmi capire qualcosa sul suo libro. Su internet lo si passa come un romanzo terminale, il capolavoro ultimo della letteratura italiana, roba da Antonio Moresco o Giù Genna (nomi dai quali mi tengo alla larga come un vampiro dall’aglio!). Il libro, senza fine, è una sorta di spaccato horror grottesco di un sud dei sud dei santi (paesi nebulose dai nomi fantasmatici) un Masserie di Cristo popolato da personaggi forse vivi, forse morti, nel loro tran tran quotidiano nei campi, i dialoghi brevissimi (che fanno far pagine velocemente), leggende, sparizioni, microavvenimenti, filastrocche, e personaggi monodimensionali che non si distinguono l’uno dall’altro (l’ispettore agrario, il cowboy, Beberto, Tebaldo e chi più ne ha ne metta in una gara all’accumulo e alla stranezza che finisce per diventare solo rumore di fondo). In un girotondo di masserie, case screpolate, catapecchie e malattie varie, la civiltà di Masserie di Cristo ricorda una sorta di “Twin Peaks” demartiniana, una popolazione sottumana che passa il suo tempo tra Feste della Pallacorda, animali, un sisma di scene e scenette staccate che fanno pensare a un mosaico di racconti scomposti e ricombinati per dare la parvenza di un grande affresco allegorico di un’ennesima fine del mondo tascabile (qualcosa di simile, ma con altri risultati e un centesimo di pagine lo aveva fatto Tiziano Sclavi col suo “Film” nel 1974). Gentile deve essere cresciuto col poster di Moresco in camera e quanto scrive di Ligotti vale in realtà per lui; “I vivi e i morti” è un libro inutilmente lungo, una sorta di prova di resistenza imposta al lettore, un fluire che trabocca, crepita, lacera la pagina, una scrittura troppo furbetta (e sintatticamente nemmeno poi tanto ricercata, al solito affidata a frasi non più lunghe di un battito di ciglia) fatta di crolli, squarci, abissi. Gentile ama l’opera mondo, il libro dentro al quale ti puoi perdere? Può darsi, peccato che il romanzo, pur conservando almeno all’inizio un certo fascino nell’idea di fondo (quella appunto di un microcosmo collettivo calato in un mondo magico e antico, un mondo ctonio e marginale, immerso nelle fantasmagorie di un folklore reinventato dall’autore), si risolva in un inutile accumulo di micronarrazioni che finiscono per assomigliarsi tutte, in una compressione dello spazio/tempo narrativo che porta al nulla, perché, alla fine, anche questo libro è un monumento al nulla (o se volete all’arroganza dell’autore, o ancora alla mia imbecillità per essermi pippato tutte e 500 le paginette!).
 Concludo con Andrea Morstabilini, traduttore di Lovecraft per il Saggiatore di Andrea Gentile, e che pubblica nel 2016 “Il demone meridiano”: Scrittura mostosa, volutamente ricercata (il risvolto di copertina ci informa subito che Manganelli e Landolfi sono tra i numi tutelari dell’autore), infittita da rimandi alla letteratura gotica ottocentesca, agli Scapigliati e a un soggetto che va a pescare le interessanti collezioni anatomiche di Paolo Gorini, pietrificatore. Ne esce un libro tanto incomprensibile, sfilacciato, letterario (d’un letterario che sgozza parole, le arrotola sulla pagina e sulla lingua, nella costruzione di una landa fatta di muscoli, tendini, candele affumicate e altri simboli arrovesciati e imputriditi che vorrebbero rimandare alla faconda abbondanza carnale di un Camporesi, senza però averne la piacevole scorrevolezza), quanto noioso e inconsistente da quello narrativo. Sarà, questi narratori mi paiono scrittori tutti mainstream (basta leggere alcune interviste di Gentile per farsi cadere le braccia dallo snobismo) che strizzano l’occhio al genere, forse solo per tirar su qualche incauto imbecille come il sottoscritto.
Concludo con Andrea Morstabilini, traduttore di Lovecraft per il Saggiatore di Andrea Gentile, e che pubblica nel 2016 “Il demone meridiano”: Scrittura mostosa, volutamente ricercata (il risvolto di copertina ci informa subito che Manganelli e Landolfi sono tra i numi tutelari dell’autore), infittita da rimandi alla letteratura gotica ottocentesca, agli Scapigliati e a un soggetto che va a pescare le interessanti collezioni anatomiche di Paolo Gorini, pietrificatore. Ne esce un libro tanto incomprensibile, sfilacciato, letterario (d’un letterario che sgozza parole, le arrotola sulla pagina e sulla lingua, nella costruzione di una landa fatta di muscoli, tendini, candele affumicate e altri simboli arrovesciati e imputriditi che vorrebbero rimandare alla faconda abbondanza carnale di un Camporesi, senza però averne la piacevole scorrevolezza), quanto noioso e inconsistente da quello narrativo. Sarà, questi narratori mi paiono scrittori tutti mainstream (basta leggere alcune interviste di Gentile per farsi cadere le braccia dallo snobismo) che strizzano l’occhio al genere, forse solo per tirar su qualche incauto imbecille come il sottoscritto.
Voglio dire, meglio di questa roba i weird tradotti da Providence Press nella deliziosa collana “Nightgaunts”, oppure basta rovistare su internet. Sul sito de “La Soglia Oscura” leggo un racconto di Natalia Gennuso, “Le mie false memorie”, poche semplici righe per costruire un gioiellino gotico che, pur senza particolari pretese, riesce meglio e coinvolge di più del 90% della nuova narrativa italiana offertaci dalle agenzie letterarie.






























