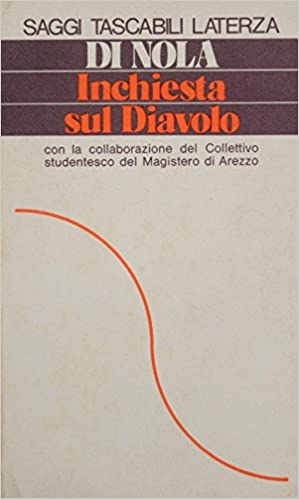Vede, qui da noi abitava una volta una ragazza,
una giovane che era stata sempre fedele
alla Democrazia Cristiana.
Poi d’improvviso si mise con i comunisti.
Il Diavolo l’aveva posseduta. L’ho esorcizzata.
Le sono usciti dalla bocca almeno cento diavoli.
Poi è tornata alla Democrazia Cristiana”.
(Alfonso M. Di Nola, Inchiesta sul Diavolo, Laterza)
Prima di un veloce commento sui testi letterari di Avati, voglio mostrare gli attrezzi di cui mi servirò. Gli studi sul gotico a cui sempre mi rifaccio son sempre gli stessi.
La monografia densissima di Roberto Curti (2011) dedicata al gotico italiano comincia ponendosi la spinosa questione di definire la parola “gotico”. Le risposte, nel corso della monografia, saranno molteplici: l’eredità del melodramma, un cinema dell’alienazione sotto il travestimento del passato, l’ovvia insistenza su tematiche legate all’occulto e al morboso.
Il gotico italiano cinematografico ha il suo corpus principale tra il 1957 e il 1966, con una coda meno significativa nel decennio successivo; oltre a cunicoli, cripte e cimiteri, il gotico italiano su pellicola ha trovato la sua centralità, più che su figure canoniche come i mostri di Frankenstein e Dracula, nella figura femminile vista come elemento perturbante alla base delle varie vicende, vicende legate a una letterarietà sbandierata quanto fittizia che spazia dai vari Maupassant, Tolstoj, Gogol’, Poe, Sheridan Le Fanu, per arrivare ai volumetti da edicola delle collane “I racconti di Dracula” e i “KKK”, o i fotoromanzi originali pubblicati da “Malia”, fino ad antologie di successo che Feltrinelli ed Einaudi vanno proponendo nelle librerie dai primi anni ’60 a cura di studiosi come Valerio Riva, Ornella Volta e Fruttero & Lucentini.
 I tempi e i luoghi del gotico italiano (che poi sono quelli dell’Italia lunare indagata da Camilletti) sembrano assumere le forme di spettri, vampiri, maledizioni e situazioni claustrofobiche che si aprono su manipolazioni temporali dove il presente e il passato riescono a toccarsi, il tutto condito da un erotismo, una perversione, un gusto per l’esagerazione che finirà per sostituire negli anni ’70 lo schema del melodramma. Curti, nelle sue pagine più belle, indaga anche i gotici letterari più eretici ed eccentrici spaziando da autori come Bernardino Zapponi, Tommaso Landolfi, Anna Maria Ortese, Giovanni Arpino, Goffredo Parise.
I tempi e i luoghi del gotico italiano (che poi sono quelli dell’Italia lunare indagata da Camilletti) sembrano assumere le forme di spettri, vampiri, maledizioni e situazioni claustrofobiche che si aprono su manipolazioni temporali dove il presente e il passato riescono a toccarsi, il tutto condito da un erotismo, una perversione, un gusto per l’esagerazione che finirà per sostituire negli anni ’70 lo schema del melodramma. Curti, nelle sue pagine più belle, indaga anche i gotici letterari più eretici ed eccentrici spaziando da autori come Bernardino Zapponi, Tommaso Landolfi, Anna Maria Ortese, Giovanni Arpino, Goffredo Parise.
Fondamentale anche il numero monografico della rivista Nocturno (2009) dedicato al gotico e curato da Riccardo Fassone con una messe di immagini a colori. Nella conclusione dell’introduzione Fassone spiega che il gotico italiano cinematografico, oltre alle sue peregrinazioni tra ragnatele e castelli diroccati, è una fantasmagoria che mostra un’avversione estrema verso la scrittura e che trova negli sberleffi di Bava e nella radicalità di Fulci i suoi punti più alti.
Questo legame tra gotico e sperimentazione torna anche in un volume della rivista Bianco e nero (2014) dedicata al genere. Anche qui, tra i vari contributi, viene approfondito un certo legame tra un cinema sperimentale italiano degli anni ’60 e il cinema di bassa manovalanza. Sorvolando su questi aspetti, una certa anti-narratività del gotico e una tendenza a certe sperimentazioni sono già evidenti negli scrittori sopra elencati. Questo per tirare le fila del discorso e arrivare di colpo all’oggi.
Sia Curti che Pezzotta si chiedono se possa avere un senso parlare oggi di un genere come il gotico, soprattutto in un paese come l’Italia. A livello narrativo negli anni ‘80 l’horror è riaffiorato a tratti in autori singolari come Alberto Abruzzese, Furio Jesi, Tiziano Sclavi, Gianfranco Manfredi. Nel cinema il genere si è inabissato negli anni ’80 con prodotti televisivi sempre più fuori dal tempo. Negli anni Zero si è visto un cinema orgogliosamente low budget e autoprodotto che raramente è riuscito ad aggiungere qualcosa di nuovo. Qui mi basterà citare il Lorenzo Bianchini di Custodes Bestiae, l’originalissimo Gianni Virgadaula di Lilith, fino all’Ivan Zuccon de La casa sfuggita o di Colour of the dark, originale ibrido tra le atmosfere lovecraftiane e quelle del gotico padano.
Ecco, il gotico padano.
Tra i testi che mi guidano in questa disamina come non citare il lavoro di Adamovit e Bartolini (2019) dedicato proprio al gotico padano di Pupi Avati. Leggendo questo volume mi sono accorto di come il regista bolognese abbia dedicato questi ultimi anni alla scrittura di alcuni romanzi gotici. Si tratta di quattro testi usciti tra il 2015 e il 2020, di cui solo uno trasposto poi in pellicola [1]. Tralasciando volutamente la versione filmica, mi concentro sul cosiddetto gotico padano di Avati, dislocato nella zona del Delta, nelle paludi tra Rovigo e Ferrara, intriso di riferimenti legati alla vita delle campagne e a una mentalità fantasiosa. Il gotico emiliano di Avati ha raccontato la civiltà contadina, un patrimonio orale frammentato e contrapposto agli agglomerati urbani delle città e ai suoi ritmi alienanti. In questo mondo contadino di fole e fiabe nere, Avati disegna le sue geografie chimeriche dell’ombra, scoprendo in età matura una vena narrativa assai felice.
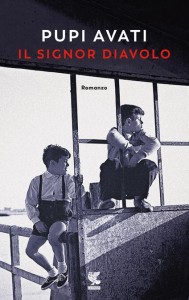 Parto dal romanzo del 2018, il più conosciuto, per via anche della trasposizione cinematografica, Il Signor Diavolo, appunto. Il romanzo (edito da Guanda) esce con una copertina poco incisiva che non fa pensare a un racconto del terrore e nasce da un embrionale copione scritto (assieme al fratello Antonio e al figlio Tommaso) nel 2016 e rifiutato da varie distribuzioni. Prima di ridivenire sceneggiatura, Avati prova a trasformare la storia in un romanzo inedito, il suo secondo in assoluto.
Parto dal romanzo del 2018, il più conosciuto, per via anche della trasposizione cinematografica, Il Signor Diavolo, appunto. Il romanzo (edito da Guanda) esce con una copertina poco incisiva che non fa pensare a un racconto del terrore e nasce da un embrionale copione scritto (assieme al fratello Antonio e al figlio Tommaso) nel 2016 e rifiutato da varie distribuzioni. Prima di ridivenire sceneggiatura, Avati prova a trasformare la storia in un romanzo inedito, il suo secondo in assoluto.
La trama è alquanto interessante: sono gli anni ’50, un delitto insolito e feroce commesso da un adolescente armato di fionda che dice di aver ammazzato il Maligno. La vittima appartiene a una famiglia bene di Venezia ed è un ragazzo deforme, reduce da otto anni di manicomio per aver (forse) ammazzato a morsi la sorellina. Questi gli antefatti su cui è chiamato a indagare un incauto ispettore del Ministero di Grazia e Giustizia inviato da Roma per smorzare il fatto di cronaca che vede implicati, a vario titolo, anche una suora e la chiesa del luogo. La Democrazia Cristiana, preoccupata che il caso di cronaca possa tramutarsi in una catastrofe politica, cerca di smontare le accuse della madre della vittima, vedova di un importante diplomatico del fascismo. Avati costruisce un pezzo alla volta un romanzo semplice ed efficacissimo, impreziosito da una tecnica narrativa stratificata: da una parte gli atti giudiziari del Giudice Istruttore, i suoi interrogatori ai vari protagonisti della vicenda, a partire soprattutto da quelli di Carlo Mongiorgi, il ragazzo imputato di omicidio per aver ucciso un altro adolescente disgraziato. Dall’altra le vicende di Furio Momenté, il grigio impiegato del ministero (e baciapile dei preti, reduce da un matrimonio disastroso con una donna che, per ripianare dei debiti, ha costretto a prostituirsi; questa cornice del romanzo è lontana dal resto del racconto e quasi ha il passo di una commedia amara dove avrei visto bene il viso neutro di uno come Nino Manfredi) promosso sul campo ispettore; muovendosi incauto da Roma a Venezia, Momenté legge le carte del processo ed esamina il lavoro svolto dal Giudice Istruttore di fede comunista in cerca di un bandolo per sbrogliare la matassa. In questa cornice quasi da legal-thriller, Avati dissemina svariati indizi del suo mondo contadino e superstizioso, ricostruendo la vita di un piccolo borgo lagunare dal nome Lio Piccolo.
Come dicevo, sono gli anni ’50, quelli di due partiti di massa che duellano come il Partito Comunista da una parte e la DC dall’altra, il tutto in un paese di frontiera come l’Italia sotto l’influenza occidentale. Il tempo del romanzo cade negli anni di De Gasperi, anni di ricostruzione e speranze per un mondo libero, anni in cui l’industria e il dinamismo imprenditoriale risorgono dalle ceneri. Il ’53 è anche l’anno in cui il governo istituisce l’Ente nazionale idrocarburi (Eni) che ha il compito di cercare nella penisola giacimenti di gas naturale e idrocarburi. Sono gli anni in cui svetta una figura dinamica come quella di Enrico Mattei, desideroso di rendere l’Italia autonoma e competitiva sul mercato petrolifero internazionale. Sono anche gli anni delle feroci schedature alla Fiat di Valletta, anni di rappresaglie e licenziamenti, oltre che di un fenomeno migratorio che coinvolgerà milioni di italiani. Nell’aprile del ’53 scoppia il caso Montesi, dove la magistratura accusa e coinvolge il figlio di Attilio Piccioni, una delle figure più autorevoli e in vista della Dc.
 Il mondo di Lio Piccolo è lontano dai grandi fatti della Storia patria, impregnato com’è da un substrato antico e sotterraneo, un filo oscuro che collega questo nord padano agli avamposti dell’inconscio indagati da Ernesto de Martino in quegli stessi anni. Tra ostie sconsacrate, evocazioni dei defunti, giaculatorie a mezza voce, bambini moribondi, deformità fisiche e porcilaie, Il Signor Diavolo di Avati non ha nulla del moderno Maligno indagato dal collettivo studentesco di Arezzo nel curioso volume Inchiesta sul Diavolo (Laterza 1979); un diavolo ormai alla moda, rilanciato dalle omelie di Paolo VI, dall’industria del cinema, come da club stregoneschi sorti un po’ ovunque. Il Diavolo degli anni ’70 si è liberato dalle pastoie arcaiche e si annida nei nuovi mali dell’uomo moderno, nell’impotenza, nelle tasse, nella disoccupazione, nelle malattie improvvise e inspiegabili, come nella pazzia. Avati, nel suo essere un pio cattolico, si riaffaccia in questi anni Dieci con un Diavolo severo e austero imbevuto di cultura subalterna e magia, possessioni, esorcismi e fatture sullo sfondo di un mondo contadino sul punto di scomparire, ancora pieno di difficoltà materiali, oppressione sociale e povertà culturale sconfinata (così come ricorda lo stesso de Martino nella chiusa del suo Sud e Magia, ribadendo come il perdurare magico all’interno di una società moderna sia testimonianza di contraddizioni e arresti nello sviluppo).
Il mondo di Lio Piccolo è lontano dai grandi fatti della Storia patria, impregnato com’è da un substrato antico e sotterraneo, un filo oscuro che collega questo nord padano agli avamposti dell’inconscio indagati da Ernesto de Martino in quegli stessi anni. Tra ostie sconsacrate, evocazioni dei defunti, giaculatorie a mezza voce, bambini moribondi, deformità fisiche e porcilaie, Il Signor Diavolo di Avati non ha nulla del moderno Maligno indagato dal collettivo studentesco di Arezzo nel curioso volume Inchiesta sul Diavolo (Laterza 1979); un diavolo ormai alla moda, rilanciato dalle omelie di Paolo VI, dall’industria del cinema, come da club stregoneschi sorti un po’ ovunque. Il Diavolo degli anni ’70 si è liberato dalle pastoie arcaiche e si annida nei nuovi mali dell’uomo moderno, nell’impotenza, nelle tasse, nella disoccupazione, nelle malattie improvvise e inspiegabili, come nella pazzia. Avati, nel suo essere un pio cattolico, si riaffaccia in questi anni Dieci con un Diavolo severo e austero imbevuto di cultura subalterna e magia, possessioni, esorcismi e fatture sullo sfondo di un mondo contadino sul punto di scomparire, ancora pieno di difficoltà materiali, oppressione sociale e povertà culturale sconfinata (così come ricorda lo stesso de Martino nella chiusa del suo Sud e Magia, ribadendo come il perdurare magico all’interno di una società moderna sia testimonianza di contraddizioni e arresti nello sviluppo).
Il romanzo, nerissimo e senza un filo di luce nel suo finale raggelante, è abitato da personaggi che paiono nati per una commedia erotica andata a male, imbevuti dall’enorme potenza del negativo che li sovrasta e li muove, lasciando nel lettore l’impressione che mai il piccolo ispettore ministeriale (e ruffiano) possa davvero arrivare alla fine della sua indagine. Con una prosa asciutta, affidata a lunghi dialoghi (cosa che tradisce l’abitudine col linguaggio delle sceneggiature) Avati ci consegna a un passo dagli orizzonti pandemici un romanzo colorato di magia e cattolicesimo, originalissimo nella sua semplice compostezza conformista, dove il Diavolo lo si deve ancora chiamare signor, perché le persone cattive bisogna trattarle bene.
 L’archivio del Diavolo (Solferino 2020) è invece un romanzo più artefatto del precedente, ingolfato di cornici e spunti letterari non sempre poi sviluppati, infittito di presunti archivi parrocchiali, dozzine di ritagli da rotocalchi, una selva ridondante di personaggi disparati. L’ombra di Furio Momenté, il protagonista de Il Signor Diavolo, si muove nelle prime pagine e riappare nei sotterranei del Ministero come fantasma sbiadito che timbra ancora il suo cartellino e disbriga il lavoro nell’archivio.
L’archivio del Diavolo (Solferino 2020) è invece un romanzo più artefatto del precedente, ingolfato di cornici e spunti letterari non sempre poi sviluppati, infittito di presunti archivi parrocchiali, dozzine di ritagli da rotocalchi, una selva ridondante di personaggi disparati. L’ombra di Furio Momenté, il protagonista de Il Signor Diavolo, si muove nelle prime pagine e riappare nei sotterranei del Ministero come fantasma sbiadito che timbra ancora il suo cartellino e disbriga il lavoro nell’archivio.
La trama è però dominata dalla nuova figura di Don Stefano Nascetti, bel pretino mosso dal bisogno disperato di emergere nelle gerarchie ecclesiastiche, corrotto dal trauma di aver visto la propria madre far sesso col Questore di Venezia, Carlo Saintjust, uomo corrotto e vendicativo. A complicare la vita di Don Stefano la figura sessualmente inquieta della sventurata Silvana Ory, suicida beghina che lo coinvolge in uno scandalo da cui fuggire. Ecco allora che in soccorso viene prospettata la parrocchia di Lio Piccolo nella grande laguna, avamposto sperduto della fede in cui ancora risuona l’eco del delitto commesso da un minorenne plagiato da una suora e da un sagrestano misteriosamente svanito. Altro personaggio interessante è Franco Ciani, guardia notturna dei sotterranei gotici del Ministero, impiegato frustrato che insegue nelle ore notturne l’idea di scrivere un romanzo sulla sparizione del cranio del grande scrittore Gogol’.
A inframmezzare la narrazione brevi capitoletti che vorrebbero essere estratti da rotocalchi d’epoca, brani chimerici incentrati su allucinazioni ipnagogiche, cripte limacciose e corpicini mummificati di bimbi, tutto frutto di un interesse dell’Autore per l’agglutinarsi di memorie condivise e assemblate in modo allucinatorio. Dopo le prime cento pagine, ecco che Don Stefano approda col traghetto nella grande laguna, in un arrivo carico di fascino che ricorda certi gotici dello stesso Avati, o gli incipit di film horror anni ’60 di Ferroni e Mastrocinque. A Lio Piccolo, non volendo, Don Stefano conosce una giovane fisarmonicista (che pare un doppio abbellito della suicida) e ne rimane incantato, poi rinviene il cadavere del Momenté.
Questi gli elementi densi di un horror disarmonico e a tratti confuso, ancora una volta affidato a troppi dialoghi e portato avanti da una folla di personaggi che finiscono per sfilacciare e annacquare gli elementi horror. Rimangono, come filamenti sospesi, i tanti spunti (e le complicate vicende dei personaggi, spesso contornate da un alone da commedia grottesca e pruriginosa), al punto che il vero filo conduttore pare nascondersi nel buio infinito che si nasconde negli stretti corridoi e nelle scaffalature ricolme di fascicoli del Ministero, o nella vasta penombra delle pievi campagnole, dove tra cani randagi e giornate di gran luce, avvengono esumazioni di bare e cadaveri putrefatti.
Meno efficace rispetto al precedente, L’archivio del Diavolo trova il suo fascino proprio in questa sua confusa debolezza, in questo accumulo generoso di pezzi narrativi lasciati mal digeriti sulla pagina, in un compiaciuto e fecondo ritratto di santi di gesso, buissimi dipinti e paure sussurrate a mezza voce.
 Per concludere, l’interesse di questi romanzi avatiani è nel loro stesso esistere, nel fatto che un regista abbia scoperto in età avanzata una vena così feconda per il genere e si sia cimentato in racconti gotici, genere ormai sepolto e dimenticato nel nostro paese. Avati torna al gotico e lo fa con originalità, fregandosene dei gusti di oggi e tornando ai fecondi anni ’50, dipingendo vicende folkloriche incastrate nell’attualità storica del periodo, collocate geograficamente nella Pianura Padana, sfruttando le suggestioni della propria terra. A differenza degli scribacchini dell’horror anni ’60, Avati (come già lo Sclavi metropolitano degli anni ’80, o come Gianfranco Manfredi e Alberto Abruzzese) ambienta le sue storie in Italia, affonda le mani nel magma ancora fecondissimo di un passato recente pieno di robaccia e reliquie.
Per concludere, l’interesse di questi romanzi avatiani è nel loro stesso esistere, nel fatto che un regista abbia scoperto in età avanzata una vena così feconda per il genere e si sia cimentato in racconti gotici, genere ormai sepolto e dimenticato nel nostro paese. Avati torna al gotico e lo fa con originalità, fregandosene dei gusti di oggi e tornando ai fecondi anni ’50, dipingendo vicende folkloriche incastrate nell’attualità storica del periodo, collocate geograficamente nella Pianura Padana, sfruttando le suggestioni della propria terra. A differenza degli scribacchini dell’horror anni ’60, Avati (come già lo Sclavi metropolitano degli anni ’80, o come Gianfranco Manfredi e Alberto Abruzzese) ambienta le sue storie in Italia, affonda le mani nel magma ancora fecondissimo di un passato recente pieno di robaccia e reliquie.
Nel 2016 Avati, insieme allo sceneggiatore Roberto Gandus, aveva pubblicato con un piccolo editore come Golem, La casa delle signore buie: si tratta di un romanzetto breve d’ambiente siciliano di fine ‘700. La trama beccheggia il Manzoni nero e favella d’un conte Morè Barreca e del suo folle amore contrastato per la bellissima Antonia, sorella della primogenita a cui il Morè pare destinato per alto lignaggio. In una Sicilia contornata di monasteri bui, candele gocciolanti, esorcisti e confraternite religiose necrofile, gli Autori non si fanno mancare il bel rapimento di Antonia, confinata in un sinistro monastero che apre la parte più bella e inquietante del romanzetto, quella che si addentra nei riti oscuri del posto, sorta di ricovero terminale per nobildonne siciliane, spazio demoniaco ricco di stimoli olfattivi, feci schifose, escrementi, flora immane di ciarpami cadaverici. Tra citazioni più o meno esplicite da Suspiria e La casa dalle finestre che ridono, La casa delle signore buie è, dei quattro libri, il più bello e stupefacente, il più nero, gotico, orrorifico, retto da una scrittura meno ingolfata di dialoghi e più atmosferica. Il gotico di Avati e Gandus trova la sua originalità, come già detto, nel recupero di un romanzo nero classico, dove le forze impersonali dell’oltretomba anti-materico sono sostituite dai temi della pestilenza cadaverica, un pullulare di liquami corporali, un’atmosfera allucinatoria che rimette in gioco il mythos del monaco infernale (qui monache, converse, donne spretate ed eretiche) che conducono non poche parentele con la Gertrude manzoniana, a sua volta imparentata con Ambrogio e Matilda del Monaco, o con lo Schedoni dell’Italiano. La Casa delle signore buie è un gothic romance che merita un posto di rilievo nella narrativa horror italiana recente, una specie di santuario ossessivo (l’invadenza della morte è un’erba selvatica che infesta le pagine horror di tutto Avati) sulla misteriosa ruggine delle carni, sulla dilatata umidità delle tombe letterarie. Chapeau!
Davide Rosso
[1] Non tratterò il primo romanzo, Il ragazzo in soffitta (Guanda 2015), non tanto perché non sia di piacevole lettura; l’opera d’esordio narrativo di Avati è più un giallo che mescola la storia di un grande amore e di una amicizia – narrazione non ingombra dei brandelli figurali del gotico che qui spolvero.