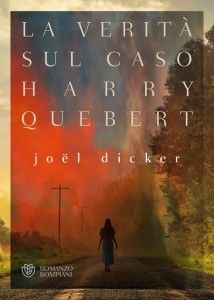 LA VERITÀ SUL CASO HARRY QUEBERT di Joël Dicker, del quale quest’anno ricorre il decennale della prima pubblicazione italiana, può esser letto come un romanzo d’amore classico che in quanto tale è costretto ad assumere i toni e gli accenti della tragedia: si tratta di un destino comune a qualunque testo s’incentri sull’eros inteso come passione aurorale, da Cime tempestose fino a Piattaforma, e poco importa se nel primo caso a far precipitare gli eventi sono un mix di dolore, nevrastenia e parto mentre nel secondo un più lineare e sbrigativo attentato terroristico.
LA VERITÀ SUL CASO HARRY QUEBERT di Joël Dicker, del quale quest’anno ricorre il decennale della prima pubblicazione italiana, può esser letto come un romanzo d’amore classico che in quanto tale è costretto ad assumere i toni e gli accenti della tragedia: si tratta di un destino comune a qualunque testo s’incentri sull’eros inteso come passione aurorale, da Cime tempestose fino a Piattaforma, e poco importa se nel primo caso a far precipitare gli eventi sono un mix di dolore, nevrastenia e parto mentre nel secondo un più lineare e sbrigativo attentato terroristico.
Dicker possiede una felicità e facilità di scrittura che tuttavia non gli evitano ingenuità ed errori di gioventù – nel senso letterario del termine, dato che qui era al suo primo romanzo – anche grossolani: in particolare gli insegnamenti di Harry a Marcus e la caratterizzazione della madre del protagonista sono insopportabili. Per il resto tutto bene: sceglie infatti un’assai convincente trama gialla compenetrata nella passione di Harry e Nola, già a priori socialmente inaccettabile a causa dei trentaquattro anni di lui e dei quindici di lei. Come che sia, all’amore aurorale è essenziale trovare un ostacolo, beninteso esterno, che funzioni da alibi per impedirne la compiuta realizzazione nel quotidiano. Soltanto a questo prezzo, infatti, esso resta quel che è: ricordo e insieme promessa del paradiso, illusione per i futuri amanti e per tutti noi, senza rivelare i propri limiti umani, ovvero, per dirla brutalmente alla napoletana, che prima o poi ogni scarpa diventa scarpone.
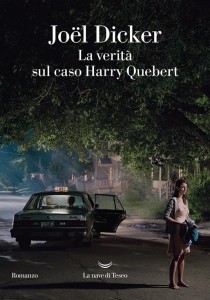 In LA VERITÀ SUL CASO HARRY QUEBERT stupirà forse che proprio i brani amorosi tratti da uno dei romanzi immaginari inseriti nel testo siano all’apparenza assai deboli e retorici, ma in questo caso è inutile tentare di scovarvi un difetto nella prosa o una debolezza nell’ideologia dell’autore: quando si tratta di passione corrisposta il cliché nasce perché, per parafrasare Tolstoj, si è felici tutti in maniera simile e dunque la frase fatta in questi casi è un bene, e non un luogo comune (1).
In LA VERITÀ SUL CASO HARRY QUEBERT stupirà forse che proprio i brani amorosi tratti da uno dei romanzi immaginari inseriti nel testo siano all’apparenza assai deboli e retorici, ma in questo caso è inutile tentare di scovarvi un difetto nella prosa o una debolezza nell’ideologia dell’autore: quando si tratta di passione corrisposta il cliché nasce perché, per parafrasare Tolstoj, si è felici tutti in maniera simile e dunque la frase fatta in questi casi è un bene, e non un luogo comune (1).
Occorre aggiungere che l’uso dei brani tratti da romanzi scritti dai personaggi non è affatto decorativo o estetizzante, ma semmai indispensabile per lo svolgimento della trama, in cui i misteri da risolvere non sono soltanto quelli relativi alla scomparsa di Nola. Quanto al momento della ricostruzione del crimine, ci troviamo di fronte a uno dei passi migliori del libro: la violenza diviene insopportabilmente realistica perché in fin dei conti non premeditata. Persuade nella sua escalation come un documento cronachistico e proprio attraverso essa diventa a noi più prossima.
Passo dopo passo la situazione sfugge progressivamente di mano, il sangue va al cervello, si sragiona e un errore tira l’altro, fino all’esito fatale. Immedesimandoci nei simulacri neri che si agitano sulla pagina, con progressivo smarrimento arriviamo a temere che qualcosa di simile possa accadere a tutti, e quindi anche a noi.
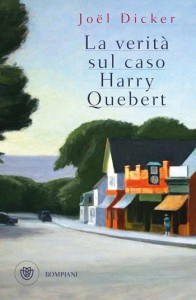 A proposito d’immedesimazione, Dicker dimostrò fin da subito qualità di romanziere di razza anche attraverso la capacità di mettersi nei panni di personaggi ben più maturi di lui: la prova è che proprio attraverso due di essi offrì una via d’uscita all’amore aurorale, o forse semplicemente un suo simmetrico contraltare.
A proposito d’immedesimazione, Dicker dimostrò fin da subito qualità di romanziere di razza anche attraverso la capacità di mettersi nei panni di personaggi ben più maturi di lui: la prova è che proprio attraverso due di essi offrì una via d’uscita all’amore aurorale, o forse semplicemente un suo simmetrico contraltare.
Mi riferisco al rapporto coniugale fra il signore e la signora Quinn: all’inizio pare che la donna tiranneggi il marito al livello stilizzato di una barzelletta, ma nel momento in cui Robert viene a conoscere la vita più segreta di Tamara si rende conto di quanto lei lo ami e sia però incapace di dimostrarlo: una sorta d’impotenza sentimentale dipinta attraverso dettagli concreti molto più persuasivi di qualunque teoria e che, pur nel dramma questa volta tutto interno alla coppia, lascia aperto uno spiraglio a una realistica soluzione purgatoriale attraverso l’aiuto che Tamara cerca nel dottor Ashcroft.
Tutto sommato, non poco per un gradevole prodotto d’intrattenimento. Anche dieci anni dopo, per chi se lo fosse perso o avesse visto solo la miniserie che ne è stata tratta nel 2018 da Jean-Jacques Annaud.
Gianfranco Galliano
NOTE
(1) Se ci si vuole spingere più in là su questa strada, si può scomodare Mishima che in “Sole e acciaio” parla delle lettere lasciate dai kamikaze come di scritti anonimi, quando chiunque si aspetterebbe un’esibizione di protagonismo e ricerca della singolarità a ogni costo da parte dei piloti pronti al sacrificio programmato per la propria nazione: ci si dimentica che, come nel caso dell’amore, per tradursi in realtà quelle frasi comportano gesti che siano gesta. La morte è il cliché dei clichés perché nessuno può sottrarsi a essa, ma è ben difficile volerla come proprio reale destino.






























